Capitolo 7 - Doreen
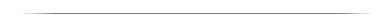
«Sam, si è svegliata.» Sento la voce di mamma vicino a me e una carezza sulla guancia.
«Oh.» Dei passi raggiungono il mio letto. «Håbe? Buongiorno! Finalmente, dormigliona!»
Apro gli occhi e li vedo entrambi. Sbiascico un "ciao". Mamma mi guarda, il viso disteso e sollevato. I capelli castani le scivolano sulle spalle. Si sistema gli occhiali da vista e si scansa un poco affinché Sam si allunghi ad abbracciarmi forte. Ricambio, premendo le mani sulla sua schiena. Il profumo di bagnoschiuma e cannella che caratterizza il ragazzo mi coccola.
«Bene, vi lascio soli, devo andare a lavoro, ti ho lasciato qualcosa da mangiare Håbe. Resti per pranzo, Sam? Ce n'è anche per te, ovviamente.»
Il grande Indiano Palestrato si stacca da me per risponderle con un sorriso. Indossa la sua felpa preferita nera e un paio di jeans, mentre i capelli sono raccolti in un codino basso. «Va benissimo, grazie Sofie.»
Mia mamma chiude la porta e Sam torna a guardarmi. Si sdraia comodo vicino a me, gli faccio un po' di posto sul letto. Mentre mi accarezza i capelli, chiedo: «Quanto ho dormito?»
La mia voce è roca, ancora non sono molto lucida, e sento formicolare tutto il corpo.
«Fammi fare i conti» ride. «A occhio e croce, ventiquattro ore, da ieri mattina a stamattina.»
«Wow.» Rimango un attimo a pensare. «Oh, cavolo, no, oggi pomeriggio dovevo...» mi blocco, e mi correggo mentalmente: ieri pomeriggio.
«Cosa?» chiede, guardandomi interrogativo.
Dovevo andare a vedere lo Sconosciuto che suonava, allo studio. Cioè, non "dovevo", ma "volevo". Nonostante tutto, volevo andarci.
Mi giro e sprofondo nel cuscino. Maledetto sonno. Non riemergo, perché Sam è ancora lì ad aspettare una risposta che non voglio dargli, quindi evito il suo sguardo.
«C'entra qualcosa quel tipo con i capelli neri?»
Canestro, tre punti puliti. Resto ancora in silenzio.
Ovvio che c'entra quel tipo, da giorni è l'unica cosa che ho in testa, lui e quello che scatena nel mio cervello. Ogni volta che sento menzionarlo il sangue pare circolare più velocemente nel mio corpo e una spinta di adrenalina colpisce la mia memoria che inizia a sparare immagini a raffica, e seppur io cerchi in tutti i modi di cancellarle, rimangono incastrate sotto le palpebre, pronte a ripresentarsi appena chiudo gli occhi, appena tento di dormire.
Ho incontrato quel ragazzo venerdì sette maggio, al concerto. E per i sei giorni successivi, non ho avuto altro che incubi. Fino a ieri, quando mi ha fatto bere quella roba e mi sono addormentata tra le sue braccia, e non sono neanche riuscita a gustarmi il momento.
Anzi... sembra quasi che non sia successo, a ripensarci ora.
Gustarmi il momento? Ma che sto dicendo?
«Sì, dovevo andare a vederlo suonare ieri. È un membro dei Fourth-off July.»
Sam sgrana gli occhi, e spalanca la bocca. «Cazzo, ecco dove lo avevo già visto! Pazzesco! Ma come lo hai conosciuto scusami? E quando?»
Mi rendo improvvisamente conto di quanto le domande nei suoi confronti mi diano fastidio. Non mi va di parlare di lui con altre persone, nemmeno con Sam. È una faccenda talmente personale la mia conoscenza con quel ragazzo che mi sorprendo di me stessa.
Sam sa tutto di me, tutto. Ma sento che quello che provo quando sto con quel ragazzo, deve rimanere tra me e lui e basta.
Non appena visualizzo questo pensiero, la mente mi ricorda di quel giorno, di quel maledetto trenta luglio. Di come Sam... della promessa...
E allora mi prendo a parolacce da sola. Sam ha fatto l'impossibile per me, e si merita di essere parte della mia vita in ogni cosa, in ogni minima cosa.
«Al concerto, era lui quel ragazzo che mi ha spinto e mi ha tirato su. E poi, quando io e te abbiamo litigato domenica, l'ho incontrato per caso all'East River Park» dico, in un sospiro. Fisso la coperta e prendo a giocarci con le mani per non guardarlo negli occhi.
Resta in silenzio e lo sento: il suo sguardi preme su di me. Mi conosce fin troppo bene, e ho paura di quello che possa leggere sul mio volto; per questo lo evito. Prima che possa chiedermi altro, gli chiedo io: «Ti ha detti per caso come si chiama?»
«Chi? Quello la?»
«Già.»
«Non ti ha detto il suo nome?» Fa un'espressione confusa molto comprensibile.
"Maledetto Sconosciuto". «No.»
«No, non so come si chiama. Ora che ci penso, anche io glielo ho chiesto, ma non me lo ha detto... anzi, ha voluto sapere come si scriveva il tuo di nome.»
«Cosa?! Gli hai detto il mio nome?» Sono sbigottita, non vale! Ora sa come mi chiamo, dove abito, chi frequento.
«Beh, credevo lo sapesse già. Inoltre, credo abbia parlato anche con tua madre al telefono.»
Sbuffo, stizzita. Apposto, addio al piano. Avrei tanto voluto usare la sua stessa arma "non-ti-dico-nulla-di-me-neanche-sotto-tortura" contro di lui, ma non è più possibile.
«Perché eri a casa sua ieri mattina?»
Stringo i denti e gli dico la verità: «Dovevo riportargli la maglietta che mi aveva prestato qualche giorno prima, quando ero fradicia di pioggia e mi aveva fatto cambiare a casa sua.»
Il viso di Sam si indurisce. «C'è altro che non mi hai detto?»
Abbasso lo sguardo di nuovo. «Scusa, Sam. No, penso sia tutto.»
«Ah si, è tutto? E perché sei svenuta? Di cosa stavate parlando tu e quello lì? E perché non mi hai detto che non dormivi da giorni?»
Ognuna di quelle domande è un pugno allo stomaco.
Mi sale un gusto amaro in bocca, e mi metto a sedere, scivolando dalla parte opposta del letto. Scuoto la testa, questa volta non ce la faccio davvero a rispondergli, e so che tanto c'è già arrivato da solo.
«Håbe. Guardami.» Si alza anche lui, fa il giro del letto e mi prende il viso con una mano, costringendomi a guardarlo. «Ti ricorda lui. Vero?»
Sfuggo dalla sua presa, in fretta mi alzo dal letto e cammino veloce verso la scrivania, dandogli le spalle. Dentro me lo stomaco comincia a vorticare su se stesso. Tutto trema, mi tremano le dita, mi tremano le ginocchia. Chiudo gli occhi forte. Immagini cominciano a colmare repentine il buio.
Non ho scampo dal mio incubo.
«Håbe Powell, guardami e dimmi che cosa cazzo hai intenzione di fare! Vuoi rovinarti, Håbe? Vuoi davvero rovinarti? Quando ho sentito quel nome, al telefono, ieri quando ti ho chiamato e sei svenuta, io ho pensato al peggio Håbe, ho pensato che lo avessi davanti e che...»
«Smettila!» Sbatto i pugni contro la scrivania, cade qualche libro e si apre per terra. Mi prendo la testa fra le mani, la quale sembra sul punto di esplodere da un momento all'altro.
"Håbe, ti prego, non lasciarmi andare mai..."
La sua voce... mentre...
«È tornato, vero? Sono tornati gli incubi, eh? E quando pensavi di dirmelo, Håbe? È colpa di quello la? Io giuro che se ti ha toccato anche solo con un dito non commetterò lo stesso errore di un anno fa, Håbe!» Mi viene vicino, mi prende le braccia, mi libero, mi volto, lui mi trattiene.
Sento le sue mani addosso e urlo. «Lasciami, non toccarmi!» Scappo dalla sua presa, ma lo sento riacciuffarmi: è la goccia che fa traboccare il vaso. Mi giro per assestargli uno schiaffo sul viso, la vista appannata dalle lacrime.
Lui rimane immobile. Si massaggia la guancia. Poi mi guarda negli occhi a lungo e piano mi dice: «Scusa. Sono uno stronzo, non devo reagire così. Ma io lo faccio per te, Håbe, lo faccio per dirti che sono qui, guardami negli occhi, sono qui. Håbe non permetterò a nessuno di farti del male. Non più.»
Mi prende la mano, ma lo scanso. Il suo volto pare informe, pare mutare; gli angoli del mio campo visivo si tingono di rosso e sembra un anno fa, sembra la stessa scena. Il mio respiro si fa più veloce... ma poi basta una frase e riconosco la voce di Sam, il mio Sam, che mi riporta indietro, dicendo: «Håbe, io non sono lui. Siamo nel 2012. È tutto finito, Håbe. Tutto finito.»
E mi abbraccia, con cautela. I cerchi rossi scompaiono dalla mia vista via via che sprofondo nel calore della sua pelle. Scoppio a piangere mentre la sua grande mano accarezza i miei capelli.
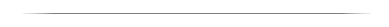
«Ho capito chi è! È quella che stava sempre vicino a te al quinto anno! Com'è che si chiamava... Aveva pure i capelli rossi...»
La bionda spreme le sue meningi fino allo stremo. Il bar è pieno di gente, tutti serviti ai tavoli, quindi per il momento non c'è molto da fare.
«Ti ho detto che non la conosci, Doreen. Non ti far andare in fumo il cervello. E poi, non è nessuno. Solo una ragazza.» Sono seduto comodo dietro la cassa, lei è vicino a me, poggiata al bancone con i gomiti. Indossa un vestito a fiori lilla, con sopra il grembiule del bar.
Mi guarda e scuote la testa, facendo "no" con il dito. «Non l'avresti portata qui a mangiare con te e non avresti offerto tu. Non ti comporti così di solito.»
Ci rifletto un attimo. «Infatti. Era puro divertimento» le spiego.
Inorridisce. «La stai illudendo?»
Alzo le spalle, la guardo di sbieco. «Anche se fosse? È parecchio che non mi diverto per bene.»
Afferra al volo uno strofinaccio e me lo tira in faccia. Lo raccolgo, mentre lei inveisce contro di me. «Sei un essere spregevole! Se andrai avanti così non avrai mai una ragazza.»
«Così come? Che faccio di strano?»
Lei mi guarda, pensando forse che io stia scherzando. Quando realizza che è effettivamente così, scoppia a ridere. «Sei tutto strano tu!»
«Non la voglio una ragazza.»
Continua a guardarmi di sottecchi, scuotendo il capo. «Davvero non so cosa ci trovino le donne in te.»
«Lo sai benissimo, perché tra quelle donne ci sei anche tu, Doreen.» Aspetto una sua replica, ma lei arrossisce e ammutolisce. Dopo un paio di minuti, dice: «Per avere vent'anni ne hai di coraggio.»
«E tu per averne ventitré hai la testa sulle nuvole. Guarda lì.» Le indico un tavolo dove della gente si è appena alzata, lasciando da sparecchiare. «Potrei farti licenziare.» E le rilancio lo strofinaccio.
In tutta risposta lei sbuffa, dopo averlo preso al volo ed essersi legata i lunghi capelli biondi in una coda. «Questa conversazione non finisce qui.»
«Certo.» Mi alzo e simulo un inchino. «Alla prossima, madame, io smonto.»
«Mancano ancora tre minuti. Potrei farti licenziare» ammicca, mandandomi un bacio. La saluto con la mano e la osservo andare ai tavoli in fondo.
Mi avvicino alla porta, e vedo entrare Oliver, venuto a sostituirmi. Mi dà una pacca sulla spalla: bestemmio tra me e me.
Secco come un lampione e impettito, la camminata energica come se si fosse fatto una bella corsa o - più probabilmente - una dose massiccia di eroina, il riccioluto mi saluta con voce squillante. Ha sempre quel viso da bambino in un centro giocattoli, sempre felice, come se non gli capitassero mai dispiaceri o cose brutte, e quindi automaticamente mi fa incazzare.
«Ciao tigre! Smonta, vai, ci penso io qua», e lo dice come se lavorare a un bar del centro sia vincere alla lotteria.
Fastidio.
Non è certo colpa sua, lui non mi ha fatto niente; non lo fa sicuramente neanche apposta. Ma provo una certa invidia verso chi ostenta tutta quella felicità e te la sbatte in faccia ogni giorno. È una cosa mia, non mi piace che mi si spiattellino in faccia i sentimenti. Ok, mi correggo, non mi piacciono i sentimenti.
Senti-menti. Comico, quasi ti avverte la parola stessa: "senti, stai mentendo a te stesso; la felicità non esiste, e come esseri umani siamo destinati alla morte, non abbiamo senso. È una buffonata, vero? Eppure capita di nascere. Ops."
«Si, cià.»
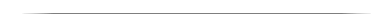
L'ho fatto davvero. Sono in questo corridoio, di fronte a questa porta. Non ci posso credere. Nonostante quello che mi ha detto Sam e nonostante quello che mi sono detta io, sono qui. E non posso farne a meno.
Le mie gambe, in questa domenica mattina, hanno scelto per me. Scendendo le scale di casa mia, un'ora e venti minuti fa, mi ero detta: "Vai a fare il pieno alla macchina di mamma e poi dritta a casa, Håbe. Dritta a casa. Intesi? Intesi. Non farti venire strane idee."
E invece eccomi qua. Indecisa se suonare o no.
"Metti che non sta a casa. Sicuramente, non sta a casa. È domenica, sarà andato a fare una passeggiata, non sarà certo rimasto solo perché una stupida gli venga a dire una cosa tipo «grazie-per-avermi-fatto-dormire-e-riportato-a-casa». Insomma Håbe, che lo suoni a fare il campanello?"
Suono il campanello.
"Vaffanculo, Håbe Powell. Sono ufficialmente nemica di me stessa."
Sto per scappare, ripensandoci, quando sento dei passi dietro la porta. La voglia che ho di rivederlo è insana, sono davvero tanto masochista.
Ma non ho scelta. Ormai ci siamo ficcati in questa cosa, e dirgli grazie mi sembra il minimo, per quello che ha fatto, anche se l'ha fatto in modo brusco e sconsiderato, mettendomi quella cosa nel bicchiere.
Forse è arrivato il momento di darci una tregua, e ricominciare d'accapo. Questa cosa è partita così male. Questo rapporto, intendo, il mio e il suo.
"Se oggi sono qui, è per un'offerta di pace. Gli offrirò di ricominciare tutto e sarà meglio. Chiarirò le cose dall'inizio. Magari gli racconterò. Potrei davvero... no, magari quello no. Però proverò a spiegargli. Sì."
I passi si avvicinano e io mi preparo psicologicamente ai suoi occhi.
La porta si apre.
Una ragazza bionda, alta, con i lineamenti perfetti. Ha gli occhi di un azzurro chiarissimo, affusolati, le ciglia lunghe. Il trucco che porta sembra consumato. Le è rimasta una vaga sfumatura di viola sulle palpebre, in tinta col vestito. Lì per lì mi ricorda una medusa: sembra quasi fluttuare. La luce che proviene dalla finestra alle sue spalle la fa sembrare eterea.
Abbasso lo sguardo: è scalza.
Non la riconosco immediatamente, più che altro per la sorpresa. Quando mi vede senza fiato, le appare un sorrisino sul volto, e allora...
È la commessa del bar dove lavora lo Sconosciuto.
A casa sua.
Scalza.
Di domenica mattina.
Faccio finta di non sentire il mio cuore gemere.
"Magari è un caso. Magari stanno parlando di lavoro. Perché è scalza? Boh, avrà pestato una merda e si sarà dovuta togliere i tacchi. No?"
Cerco di calmarmi. "Piano, Håbe. Piano. Adesso che mi invento?"
Opto per la fuga. Spero davvero che lei non mi abbia riconosciuto, e dico: «Scusi, devo... Devo aver sbagliato porta.» Sorrido in modo fintissimo, e con un gesto fugace della mano mi volto.
Dall'altra parte della porta, che la ragazza tiene aperta, si sente una voce, quella voce, che chiede: «Chi è?»
Resisto all'impulso di mandarlo a fare in culo e continuo a camminare. Poi sento la porta chiudersi dietro di me e la ragazza mi chiama, quando io sto per scendere le scale e correre via.
«Aspetta, ehi! Ti ho riconosciuta, sai? Non hai sbagliato porta, è quella giusta.» Mi sorride. «Però devo metterti in guardia, ragazza. Da donna a donna. Ti prego di ascoltarmi.»
Mi raggiunge. Quanto diavolo è bella. Si muove in modo sinuoso, sembra sul punto di danzare oppure di sbranarti, come una pantera su un albero, da un momento all'altro in grado di balzare sulla preda ferita sottostante. «Non ti preoccupare, davvero, ho sbagliato, io...», cerco di dire.
«Devi stare attenta, con lui. Non puoi aspettarti troppo e non puoi aspettarti poco. È un tipo... particolare. Molto, direi. Solo: non lasciarti illudere. Se senti che ti sta prendendo in giro... Scappa. E scappa per davvero. So quanto è facile cascarci di nuovo», e ciò detto, si mette una mano sul cuore. «Esperienza personale. Adesso, puoi scegliere tu se andare via o no. Ma ricordati quello che ti ho detto, ok? Io stavo uscendo. Ciao, ragazza. Ricordati chi sei, quando entri lì dentro.»
Dice l'ultima frase in modo triste, come se lei ogni volta se lo scordasse.
Mi rendo conto che tiene le scarpe in mano. Se le infila veloce e mi supera.
Sento i suoi tacchi fare le scale e poi uscire dalla porta d'ingresso.
Ma c'è qualcuno di normale qui? A partire da me, intendo.
Mi strofino gli occhi. E adesso? Seguo il suo consiglio? Entro? O me ne vado?
E poi la porta di fronte a me si apre.
Lui si affaccia, mi vede. E, lasciando la porta aperta, mi viene incontro.
Non riesco a muovere un muscolo, sono del tutto pietrificata. Si blocca a un paio di metri da me, e cerca intorno con lo sguardo.
«È andata via» spiego, quando realizzo che sta cercando la ragazza. Neanche un "ciao", neanche un "oh che bello sei viva", oppure un "come va?", niente.
«Che ti ha detto?»
Non gli risponderò. «Ero venuta solo per dirti grazie, per quello che hai fatto venerdì.» "E per proporti di ricominciare da capo." «Tutto qua. Fossi in te, laverei bene la camicia sul colletto, è piena di rossetto. Ciao.»
Scendo tre scalini, prima che lui dica: «Cos'è, sei gelosa?»
M'irrigidisco. «Io? Di te? No.»
«E allora perché scappi?» Scende tre scalini anche lui, allora io ne scendo un altro.
«Perché sì.»
E succede: allunga una mano e mi prende il polso, strattonandomi a sinistra. Mi ritrovo con la schiena al muro; lui è davanti a me, che mi impedisce di passare, con le mani poggiate alla parete, ai lati della mia testa. Il mio stomaco fa una tripla capriola da primo posto alle Olimpiadi.
Mi guarda dritto negli occhi. Sono così freddi che ho i brividi. O forse non sono brividi di freddo. È paura? No, nemmeno.
È ché è vicino.
«Lasciami passare» dico, cercando di impormi, ma abbassando lo sguardo per evitare che i suoi occhi mi provochino quelle sensazioni assurde e mi intrappolino.
«Non è come pensi.»
«Che?»
«Con quella ragazza.»
«E che mi frega!» Faccio per scappare ma lui trova il modo di impedirmelo anche senza toccarmi. Mi incatena con quelle dannate iridi che comincio a odiare.
«Non stiamo insieme. È solo sesso e basta.»
A quel punto comprendo: mi sta mettendo alla prova. Quello lì si sta divertendo un mondo. Vuole vedere la mia reazione. Gli piacerebbe così tanto se scappassi adesso e non tornassi più, certa di essermi risparmiata di conoscere una brutta persona.
Gli avrei dato questa soddisfazione?
Scoppio a ridere.
No.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top