Capitolo 6 - Sam
Quando mi sveglio, la prima cosa che percepisco è una superficie morbida sotto il mio corpo e successivamente un forte mal di testa. Una fitta di dolore parte dalla tempia destra e sembra trapassare il mio cranio con forza. Apro pian piano gli occhi, mentre barcollo nel dolore.
«Sam...» mugugno, cercando il mio migliore amico.
«Come?» Qualcuno si avvicina a me. Non riesco a distinguerlo bene ma so chi è, sento il suo profumo, lo stesso del divano sul quale sono sdraiata. Mi capacito anche di sentire del freddo sulla fronte: probabilmente è ghiaccio.
«Ti prego, chiama Sam, col mio telefono... Digli dove siamo.»
«Dimmi la password di sblocco.» Ha già il mio telefono in mano.
«Milleduecentoventuno, in numeri.»
«Tieni il ghiaccio, sta cadendo. Chi è Sam?»
«Non importa chi sia, digli che son svenuta, capirà.»
Finalmente i miei occhi riprendono a vedere più chiaramente e l'alone rosso si dissipa, giusto in tempo per mettere a fuoco il suo viso. È accovacciato alla mia sinistra, il mio cellulare sull'orecchio. La sua presenza al mio fianco non fa che peggiorare le cose. Mi rendo conto di avere un disperato bisogno di un abbraccio da orso di Sam, di vedere il suo viso preoccupato, di volere che mi riporti a casa.
«C'è la segreteria» afferma lo Sconosciuto, dopo un poco.
«Merda.»
«Dimmi dove abiti.»
«Non lo sai dove sta, è lontano.»
Mi guarda dritto negli occhi e quasi ho un altro mancamento. Un blu del genere non dovrebbe nemmeno essere un colore. «Ti ho detto di dirmelo.» Le sue labbra si muovono quasi impercettibilmente mentre parla. Sono rosse e carnose, non le avevo mai viste così da vicino. Con una mano mi sistema il ghiaccio sulla fronte.
«64 Columbus Ave, all'incrocio con la settantottesima.»
Lo vedo ragionare un attimo. «Di fronte al museo di storia naturale, più o meno?»
«Sì.»
«Andiamo. Ce la fai ad alzarti?»
«Sai dov'è? Sì, sì. Ce la faccio.»
Tiro su la schiena e in una frazione di secondo il mondo smette di esistere: tutto viene assorbito dal nero che si stende sui miei occhi come un velo. Crollo di nuovo sul divano. Sono costretta a stare cinque minuti con gli occhi chiusi, a calmarmi e respirare.
Quando mi riprendo, lo sento schioccare la lingua. «Tu hai bisogno di dormire. Aspetta.» Scompare dalla mia visuale qualche minuto. Poi, torna. «Bevi.» Con gli occhi chiusi, lo sento armeggiare con qualcosa che sembra una busta. Quando riesco ad aprirli, mi passa un bicchiere.
Gli lancio uno sguardo sospettoso: che diavolo ci avrà messo?
In risposta alla mia occhiata, lui aggiunge: «È solo acqua e zucchero.»
Lo bevo. Da giorni non dormo, ed è tutta colpa degli incubi.
Il silenzio ci copre per qualche minuto ancora, sento il battito del mio cuore calmarsi un po'. Lui sta aspettando non so cosa e io sono troppo presa dai miei pensieri per rendermene conto.
A un certo punto si china su di me e dice, chiaramente: «E adesso sentiti nel tuo giorno fortunato, perché sarà la prima e ultima volta che farò una cosa simile nella mia intera vita.» Dopo avermi guardato negli occhi serissimo, mi toglie il bicchiere dalle mani, infila le braccia sotto al mio corpo e mi solleva come se pesassi dieci chili.
Non ho la forza di oppormi. Rimango a guardare il suo viso mentre mi porta giù per le scale. Sento il mal di testa allentare la sua morsa e le palpebre farsi via via più pesanti. «Cosa c'era in quel bicchiere?»
«Non pensarci. Dormi.»
Non faccio in tempo a sentirlo aprire la porta del condominio che crollo, senza più difese.
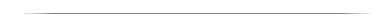
Parcheggio la macchina sotto un albero. Slaccio la cinta, scendo e apro la portiera dietro. Lei è lì, sdraiata, che dorme. I capelli, sparsi sul sedile nero, sembrano un mare di fuoco. Qualche ciocca le copre il viso. Ha mano sotto la guancia. L'espressione è rilassata e sembra stia dormendo bene. Gli occhi verdi sono celati dalle palpebre chiuse.
Prendo il suo cellulare. Chiamo il numero segnato sotto la voce "Mamma".
Una signora mi risponde.
«Pronto, tesoro?»
"Ok, adesso servirà tutto il mio impegno celebrale."
«Salve signora. Sono un conoscente di sua figlia...» parto già malissimo, dato che non so il suo nome. Mi affretto a proseguire: «È svenuta a casa mia, penso non dormisse da qualche giorno. Le ho dato qualcosa per aiutarla a dormire, è qui addormentata nella mia macchina. Credo di essere vicino casa sua, se magari potesse dirmi quale portone è...»
«Oh mio Dio! Aspetta, oh santo cielo! Io non sono a casa adesso. Dove ti trovi di preciso? Senti, fai una cosa, chiama Sam. Se hai il suo cellulare sicuramente ha il numero registrato. È il nostro vicino, lui è a casa adesso, può vederti e farti entrare. Io mollo tutto e arrivo subito.»
«Va bene.»
Chiudo la chiamata, provo a richiamare questo Sam e stavolta, con mio sommo piacere, squilla.
«Pronto? Håbe? Tutto bene? Håbe? Dove sei?»
"Hub". Quindi è così che si chiama. Ma "Hub" non significa "mozzo"? Forse non è proprio "Hub", forse si scrive in un altro modo. Chissà che lingua è.
«Salve, scusi, "Hub" e sua madre mi hanno detto di chiamare lei...»
«Che le è successo? Chi sei?»
«È svenuta, io sono sotto casa sua con la macchina, o almeno credo di esserci. "Hub" è qui con me. Se mi dicesse qual è la casa, la porterei dentro.»
«Merda, scendo subito. Cazzo, cazzo, cazzo!»
Sembra veramente agitato. Dovrei tranquillizzarlo? ...Nah.
Dopo qualche minuto, sento che urla nel microfono: «Ragazzo, guarda qui, alla tua sinistra, sono qua!»
"Ottimo, grazie per avermi appena privato della sensibilità sonora dell'orecchio destro. A cosa serve urlare se siamo al telefono? Idiota."
Mi volto. Un ragazzo è appena uscito da una delle tante porte a schiera. Mi viene incontro correndo, dopo aver praticamente saltato le scale del portone. Quando è a pochi metri da me, si ferma.
È davvero enorme. Ha un sacco di muscoli, in parti del corpo dove nemmeno pensavo ci potessero essere. Porta i capelli lunghi e una maglietta nera a maniche corte, con un paio di jeans al ginocchio. Il viso è piccolo, sproporzionato rispetto al collo grande. Sarà alto una decina di centimetri più di me, quindi deve aggirarsi attorno ai due metri. Ha gli occhi scuri come la sua carnagione e i suoi capelli.
È praticamente un Armadio. Con uno sguardo preoccupatissimo. Che sia il suo ragazzo?
Mentre lui parla, io mi infilo dentro la macchina e prendo "Hub" in braccio.
«Oh, merda, come è successo?»
«Stavamo parlando, mi sono voltato, sono tornato e lei era accasciata a terra.»
«Di cosa parlavate?»
«Qual è l'entrata?» chiedo.
«Qui, vieni.»
Mi conduce qualche portone più avanti, estrae una chiave dalla tasca e apre il piccolo cancello quando giungiamo alla casa giusta. La casa di "Hub". Una villetta schiacciata fra le altre cento della via, con tanto di piccolo giardino sul davanti. La ringhiera di ferro battuto nero circonda il perimetro. Il giardino è curato, con diversi cespugli, parecchi fiori, un alberello e delle sedie da picnic. La casa ha il tetto rosso mattone mentre le pareti sono gialle. In realtà l'entrata è veramente piccola, con una scaletta e un portico altrettanto minuscolo; vasi di fiori sono appesi alla tettoia.
L'Armadio si mette a tastare proprio dentro uno dei vasi di primule vicino l'entrata, finché non tira fuori una chiave. La infila nella toppa e mi tiene aperta la porta.
Entro, guardandomi intorno. Anche l'atrio è minuto come l'entrata, composto dalla sola scala poggiata alla parete di sinistra e una credenza sulla destra. Riesco a intravedere l'entrata della cucina, sempre a destra: si scorge il bancone in legno chiaro e il piano cottura, oltre a qualche sgabello rosso.
«Puoi dare "Hub" a me. Non ti preoccupare, ora ci penso io» dice l'Armadio. Ha un solco sulla fronte: pensavo fosse una ruga, invece, ora che lo osservo più da vicino, noto che è proprio una cicatrice.
E chi si preoccupa. «Ok.»
Si avvicina a me, allungando le braccia per prendere la ragazza. Sento la pelle di lui toccarmi e mi allontano. Mai più contatto fisico, mai più. L'overdose di oggi mi è bastata per tutta la vita.
Sto per andare via, quando sento, dietro di me: «Grazie mille, ehm... com'è il tuo nome?»
«Come si scrive "Hub"?»
«Oh, beh, H - å - b - e. La "a" si pronuncia "u". Tu invece chi sei?»
«Ciao, Sam» e mi chiudo la porta alle spalle.
* * *
Mi metto più comodo sullo sgabello e riprendo a pizzicare le corde. Quel suono mi riempie: colma ogni vuoto e per un momento mi sento pieno. Non di cose, ma di colori. La musica colora, colora la vita o, almeno, la mia. Non so se lo fa anche con quella degli altri e sinceramente non mi importa.
Lei ci sta sempre, la musica. Le persone no, quelle vanno e vengono. Le emozioni, anche. Le cose belle, pure. Quelle brutte, idem. E lei? Lei resta.
La musica c'era quando c'erano le prime tribù, la musica c'era quando si suonava con i piedi e la musica c'era quando le guerre mondiali, la musica c'era quando i canti razziali, la musica c'era quando non c'era più niente in cui credere e allora che si fa? Musica, ecco che si fa, ci si rifugia in lei, musica, come una madre, la madre che nessuno ha avuto, o forse, forse solo io.
So che questa passione non è altro che un modo per prendermi in giro, in realtà è come fumare: non serve a un cazzo, ma almeno senti che qualcosa ti circola nei polmoni, senti di essere vivo e senti di mettere in gioco qualcosa, fumando: la tua esistenza. Ecco, per me la musica è così: una sigaretta infinita, senza uno scopo che non sia illudermi.
Di cosa?
Di vivere.
Lo studio dove stiamo registrando è piccolo ma non ci sono pareti intorno a me quando comincio a suonare, non ci sono confini oltre i quali non posso andare. Ci sono solo note e tasti, e sono un totale, che porta ad un totale più grande considerando le combinazioni e le possibilità. Ed ecco che ci sarebbe un accordo per ogni momento della vita. Chissà che sensazione deve essere, arrivare alla fine e sul punto di morte dire: "ok, non sono diventato un astronauta, ma io ho suonato la mia vita, ed è venuta proprio bene".
Sento il sole caldo sulla schiena, che filtra dalla finestra aperta e in questo momento non desidero essere da nessun'altra parte.
Finisco con l'ultimo accordo. Riapro gli occhi, rimasti chiusi fin da quando avevo cominciato. Nella stanza mi guardano tutti. Poi si alzano e applaudono. Senza sapere che non c'è niente a cui applaudire.
Fare musica è l'unica cosa che mi riesce. È la mia fortuna si, ma la mia condanna. Perché se fai musica comprendi che ciò che hai non ti basta. Se fai musica, mentre suoni ti senti così vivo che se non hai qualcosa a cui aggrapparti quando smetti, ti rendi conto della realtà: tu non vivi.
Tu sopravvivi.
Non so se sono solo io: ma si da il caso che io non abbia nulla a cui aggrapparmi quando smetto. Solo un profondo niente. E quelle emozioni che vedo sui volti dei miei amici quando smettono di suonare, i loro sorrisi anche dopo l'ultimo accordo, mi raccontano che per loro la magia non finisce lì. Per me si.
Dopo non c'è niente.
Sono uno spettatore, sono lo spettatore degli altri, ma soprattutto di me stesso. Non ho voce in capitolo. Io mi guardo vivere sdraiato sul divano, anche conscio di aver messo sul canale sbagliato, ma non ho le forze, né voglia di cambiarlo.
«Bravissimo, man!» Taito mi da una pacca sulla spalla, facendomi rinsavire. I suoi occhi verdi mi sorridono e le piccole rughe che ha ai lati delle palpebre si infittiscono.
«Yuuuuhuuu!» Koky, che è inginocchiato di fronte alla batteria, alza un braccio, per mostrarmi la pelle d'oca.
Damian mi si avvicina, chiedendomi di prestargli lo spartito, per arrangiarci il testo. I suoi capelli color carota farebbero impazzire qualsiasi teenager. Ha un po' di barba, e si sta facendo crescere le basette. Il suo volto è rilassato, le iridi marroni screziate di giallo mi ricordano il budino misto cioccolato e vaniglia per cui andavo matto da piccolo.È lui il capo della band, anche se la maggior parte delle cose tecniche le fa Taito. In realtà, una volta, c'è stata una bella litigata tra di loro.
Ma sappiamo tutti quanto e perché Taito fosse fuori di sé in quel periodo. E non è certo da biasimare.
«Uscirà uno spettacolo, ragazzi. Manca solo il tuo pezzo finale, Koky. E l'assolo di Jazz. Dai, su.»
Un lamento proveniente dalla zona chitarra classica ci raggiunge. «Voglio un caffè», si lamenta Jazz, e poi fa uno sbadiglio che dura un minuto pieno.
«Jazz, che cazzo, ti ho visto anche l'intestino! La mano davanti la bocca!», si lamenta Koky.
Jazz risponde con un rutto.
Si mettono tutti a ridere. «Sei proprio un verginello, Koky, si vede che non sei abituato. Vieni qui che ti do un bacino dai!» Jazz mette un braccio intorno al collo di Koky e con il pugno gli scompiglia tutti i capelli biondi. Koky (Kristopher) è un bel tipo, il classico biondo dagli occhi chiari. Lo abbiamo trovato a un bar, mentre suonava da solo, facendo da sottofondo per le coppiette che pomiciavano lì intorno. Così, gli abbiamo detto: "Ehi, sei bravo, che ne dici di smetterla di fare il jukebox e unirti a noi? Ci manca proprio un batterista". E lui — stranamente — ha accettato.
Jazz (Jared), invece, è la "puttana" della band. C'è sempre quel componente che tutti prendono in giro e a cui tutti fanno scherzi telefonici in caso di noia la domenica mattina: nel nostro caso è lui. Ha origini afroamericane e nonostante abbia dei genitori altissimi, lui non arriva neanche a un metro e settanta.
Koky protesta: «Jazz, giù le manacce, e poi "verginello" a chi? Ho scopato più io di voi tutti messi assieme, guys!»
Un boato di cori di protesta e parolacce si alza contro Koky, finché Damian non placa le acque. Taito, poco dopo aggiunge: «Ti ricordo caro Koky di essere nella stessa stanza di quello lì!», dice, e poi mi indica.
«E quindi?», chiedo.
Damian sbotta, rinunciando anche lui a pensare a cose serie: «Dai, man, ti viene dietro mezza città! Possibile che non te ne accorgi? Tu che potresti stare tutto il giorno con ragazze come Viviette Moreira perdi tempo a fare il depresso.»
Viviette è stata la prima ragazza che ricordo a innamorasi di me e a confessarmelo. Inutile dire che non ho potuto ricambiarla, ma siamo rimasti amici. Fa la modella per lo studio fotografico di fianco a casa mia: spesso ci incontriamo, anche se non lavoro più lì.
Tra una bestemmia e un sorso di birra, Jazz commenta: «Quelle belle tutte lui.»
Scuoto la testa. «Cazzate, non m'interessa, ragazzi.»
E poi Taito commette uno degli errori più grandi che si può commettere in una stanza con i componenti della mia band: parla della bionda. «Amico, ti sei fatto Doreen Foster. Se non t'interessava, te ne sceglievi anche una brutta no?»
Cominciano cori di apprezzamento e battute che no, non ripeterò.
Mi accendo una sigaretta, andando con lo sgabello verso la finestra, sistemandomi la chitarra sulle gambe. I discorsi sulla mia collega intanto continuano. «Pff, Doreen non è proprio una santa, mezza città ci è andata a letto. Però mi chiedo: perché io sono sempre nella metà sfigata?!» Jazz lancia il tappo della bottiglia di Evil Twin contro uno dei piatti della batteria provocando un rumore assordante.
«Perché sei basso e stupido, Jazz. Comunque, man», mi chiama Taito, togliendosi le mani dalle orecchie, una volta finito il frastuono. «Quella ragazza di oggi...»
Lascio uscire il fumo. Nella stanza cala il silenzio.
«...È davvero bella. Com'è che si chiama?»
«Håbe», rispondo.
«Quindi non state insieme, hai fatto quella scenata solo per far andar via Miriam.»
Annuisco.
Taito scuote la testa energicamente e fa un gesto di rinuncia con le mani. «Sei impossibile.»
Comincia uno sciame di domande, fatte da tutti, che si confondono e sovrappongono:
«Chi è?»
«Si chiama "Mozzo"?»
«È di queste parti?»
«Quanti anni ha?»
Mi cade la chitarra dalle mani e provoca un tonfo sordo.
Silenzio improvviso. Proprio quello che volevo.
La raccolgo. «Sentite, io ho finito, quindi vado. Ci si vede.»
Appena esco e l'aria pulita mi invade i polmoni, sto subito meglio. Sento ancora rimbombare le loro domande su di lei nella mia testa. Le loro voci vanno da una parte all'altra del mio cervello, come in una partita di tennis. Forse dovrei davvero andare a dormire un po'.
* * *
Le tende del salotto erano così belle, color rosa pallido, con tanti disegni di fiori. Adoravo quel motivo, erano le mie preferite. Rendevano l'atmosfera pacifica e cordiale, chiunque entrava faceva un sorriso ed al tempo pensavo fosse merito proprio di quelle tende.
Poi le tende sono bruciate, insieme alla casa.
E allora ho capito che un sorriso non può nascere da qualcosa di così banale, qualcosa che brucia così in fretta, come una tenda. No?


-In foto: 64 Columbus Ave-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top