Capitolo 34 - "Ho cercato..."
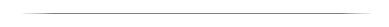
Il braccio destro è teso verso la lampada al neon. Il pavimento in linoleum riflette la luce, e la stanza brilla, anche grazie agli specchi: ma a brillare ancora di più è la bambina. Il tutù rosa un po' vecchio, nella sua mente è un lungo vestito da ballo. Le scarpette con la punta ormai rovinata, sono delle scarpe col tacco di cristallo. Fa una piroetta e chiude gli occhi: la stanza diventa un'enorme sala da ballo, come quella de "La bella e la bestia", con quel grande lampadario dorato. Lei volteggia: i suoi capelli non sono legati da un fermaglio senza più brillantini, ma da una cascata di diamanti, e una coroncina è posta proprio in cima alla sua chioma così scura, corvina, da essere quasi blu.
La bambina cambia. Diventa ragazza. Intorno a lei tutto muta: adesso non balla più in una palestra dismessa, ma in un teatro. Piccolo, ma pur sempre un teatro. Il suo body bianco è piano di perline d'argento, e mentre balla s'emoziona: le perline brillano come le lacrime sulle sue guancie quando finisce la serie, si mette nella posa finale, e le persone, dopo un attimo di sgomento, si alzano ed applaudono.
Gli applausi però si trasformano, si concretizzano: diventano una marea, che solleva la ragazza che comincia a vivere in modo così frenetico. Immagini si susseguono.
Quando balla da sola non ha più tempo di sognare. Deve allenarsi, deve imparare. Portamento, sorriso.
La ragazza diventa donna. Poi un giorno, la marea la posa, sul bagnasciuga.
Seduta, nel teatro vuoto. L'eco del rumore del mare nelle orecchie. Poi, si prepara: trattiene il fiato. Lo sa, che sta per succedere.
La marea la travolge in una potente onda. Per un po' volteggia sulla sua cresta, ma alla fine le gambe le cedono. Non ce la fa più e cade.
Non muore.
Ma qualcosa dentro lei smette di esistere.
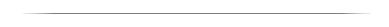
Passano due giorni e man non si fa vedere. È vero, glielo ho detto io, ma fa comunque male averlo lasciato in quel modo. Il mio cuore è diviso in due: una parte è follemente convinta che deve continuare a insistere, ma l'altra sta cedendo.
Me lo ero detta: se ci fosse stata l'eventualità che lui... beh, che non mi avrebbe più voluta, me ne sarei andata dalla sua vita, così come vi ero entrata.
Scuoto la testa, svegliandomi con questi pensieri.
Stare in casa non mi farà bene ancora per molto. Forse è arrivato il momento di uscire. Così dopo tre mesi mi vesto, coprendomi bene per il freddo che fa fuori, e mi incammino lungo le strade di una New York gelida alle undici del mattino.
Non so bene neanche io dove sto andando. Poi la parte del mio cuore che vuole insistere prevale, e mi dirigo verso il bar di man.
A rivederlo, con la neve accatastata sulla piccola tettoia, mi ricordo di quando ci entrai per la prima volta, quando ancora pensavo che man fosse uno stalker. Mi viene da ridere al ricordo...
"Ma era quasi meglio allora che adesso", mi trovo a pensare.
Appena varco la soglia, ho un tuffo al cuore: sono tutti lì. La band al completo, e Doreen dietro al bancone. Tutti insieme si voltano a guardarmi: la bionda fa cadere lo strofinaccio, e sussurra "Håbe!"
Ma la prima persona che si alza e corre ad abbracciarmi è Taito. Mi stringe forte, io ricambio: non mi ero resa conto di quanto avessi effettivamente bisogno d'un abbraccio, e questo provoca che qualche lacrima inizia a scendermi giù dalle guance, e probabilmente macchio la maglia di Taito di mascara. Oh, ma tanto è nera, chi se ne importa.
Lui, mentre mi abbraccia, mi dice: «Sei una tipa tosta tu, lo sapevo.»
«Dici?» gli chiedo, cercando di non far tremare la mia voce.
«Sei uscita di casa! Insomma, quando sono venuto una settimana fa eri ancora uno zombie!» Si allontana un po' da me e con le mani sulle mie spalle mi guarda negli occhi. «Sei forte.»
Faccio un grande respiro e mi asciugo le lacrime. «Taito, ho bisogno di parlarti.»
Con gli occhi, gli dico di chi. Lui perde il sorriso, e annuisce.
Anche Doreen, la ragazza che non abbraccia mai nessuno, esclama: «Fanculo!» e mi stringe forte. «È stato un tormento uscire con questa gente senza di te, Hubby.»
Gli altri mi salutano, Koky mi tiene per un po' la mano, senza dirmi nulla, e mi sorride.
Man è seduto sull'ultimo sgabello. Mi guarda solo per un attimo, poi torna al suo caffè.
Non ce la faccio più. Guardo Taito, lui annuisce e sussurra: «Vieni, andiamo.»
Lo seguo fuori dal locale, dove man non può sentirci. E gli dico tutta la verità: «Mi sento uno schifo, Taito, come se tutto quello che avessi fatto non fosse servito a niente. Man sembra avere paura di me. Ha paura quando lo sfioro, e addirittura sembra abbia paura anche di guardarmi negli occhi, è come se tutto fosse... ancora peggio.»
Respiro; averlo detto a qualcuno mi rilassa un poco.
Lui aggrotta la fronte e scuote la testa. «Håbe, tutto quello che hai fatto c'è e rimane. Man non sapeva neanche cosa fosse la paura fino a qualche mese fa. È già qualcosa.»
«Lo so. Ma comincio a temere che io non sia abbastanza. Comincio a perdere le speranze, stavolta sul serio.» Lui scuote ancora la testa e mi mette una mano sulla spalla.
«Ehi, no. Håbe tu hai acceso una luce nella stanza di qualcuno che era sempre stato al buio. Io penso... che sia terribile far paura alla persona che ami. Però non è neanche da biasimare. Secondo me tu dovresti fare qualcosa di ancora più grande di quello che hai fatto fin'ora. Devi scuoterlo definitivamente, perché manca davvero poco.»
«E come? Che altro posso inventarmi?» Il punk si mette a camminare avanti e indietro e mi ricorda tanto Sam quando è preoccupato. Solo con ottanta chili di massa muscolare in meno.
Poi, si blocca. I suoi occhi verde biglia si assottigliano. «Doreen può aiutarti in questo. Aspetta.»
Si affaccia dentro il locale e chiama Doreen. Lei si infila il cappotto ed esce: «Che succede?»
«Dor, a che scuola superiore andava man?»
Lei sembra spaesata dalla domanda quanto me, che guardo Taito, il quale sembra incredibilmente su di giri adesso, come se avesse avuto una folgorazione.
«Oh, beh, si chiama Manhattan Bridges High School. Ci andavo anche io.»
Taito si illumina e torna a guardarmi negli occhi. «Håbe tu devi andare lì. Scoprire il suo nome, il suo vero nome. E poi dirglielo. Io non lo so. Nessuno lo sa.»
Sbianco. «Stai scherzando?» Guardo prima lui, poi Doreen. «Non lo sapete neanche voi due? Ma non hai appena detto di esserci andata a scuola insieme, Dor?»
Lei mi sorride. Si accende una sigaretta. «Håbe, lui... prima era ancora peggio rispetto a quando lo hai conosciuto. Deve esserci stato qualcuno prima di te che lo ha cambiato un po'. Quando lo vedevo, prima, le rare volte che usciva dalla classe, durante i primi anni di liceo, era un fantasma. E i fantasmi non hanno corpo, figurarsi un nome. No, neanche io so il suo nome, Håbe. Ma sono d'accordo con Tai. Forse, se vai alla scuola, potresti trovarlo. Deve essere da qualche parte. So che addirittura non lo scriveva neanche sui compiti... Metteva il suo numero nell'ordine alfabetico e basta. Dovresti trovare qualcuno che ti permetta di accedere all'archivio. Io non ci ho mai provato. Non ho voglia di... scoprirlo così.» La bionda guarda Taito per un secondo. Lui annuisce.
«Håbe, noi tutti stiamo aspettando da tempo il momento in cui sarà lui a rivelarcelo. Ma giunti a ciò, estremi rimedi. Devi trovarlo. È una cosa abbastanza forte da scuoterlo definitivamente.»
Mi metto a pensare. «Non lo so. Forse è un po' troppo. Magari la paura che ha, è solo per quello che mi è successo. Magari è una cosa che passerà in qualche giorno. Direi di attendere ancore un poco.»
Lui e Dor non sembrano molto convinti, ma annuiscono. Taito aggiunge: «Concediamogli una settimana. Magari si riprenderà.»
***
Non fu così. Passò un altro mese che si portò via Natale e capodanno. A Natale io ed i miei genitori partimmo per un viaggio sulla neve, mentre invece capodanno lo passai con man e gli altri in un locale. Ballammo tanto e ci divertimmo, ma comunque la situazione non cambiava.
Man era più distante che mai.
Un venerdì dei primi di gennaio, lo invito da me. Lui accetta: sembra più rilassato del solito, e quando saliamo in camera mia, si sdraia sul mio letto.
«Allora, che hai fatto in questi giorni?», gli chiedo.
«Solite cose. Tra l'altro, ho un concerto a breve.»
«Davvero?» chiedo, emozionata.
«Oh ma tu non sei invitata», mi prende in giro. Gli tiro un cuscino, che lui schiva. Allora lo raggiungo sul letto e mi siedo al suo fianco.
«Håbe» mi chiama, a un certo punto.
«Si?» Lo guardo: sta fissando le stelle sul soffitto.
«È quasi un anno che ci conosciamo.»
Ci rifletto: «Beh, non proprio. Manca ancora tanto, è solo gennaio.»
Poi mi spiazza: «Se vuoi lasciarmi perdere, io lo capirò.»
Resto in un silenzio sbigottito per una manciata di secondi.
Poi mi arrabbio. Non ce la faccio più a tenere tutto dentro, ed esplodo: «Ma si può sapere che cazzo dici? Tu non hai ancora capito niente, eh?»
Lo guardo, lui mi guarda. Nei suoi occhi leggo solo confusione. E niente di più.
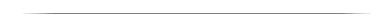
Håbe si alza dal letto. Io mi tiro su a sedere. Dentro di me c'è un gran macello ma quello di cui sono certo è che non posso continuare a mentirle.
Non ci riesco.
Sì, forse me ne sarei dovuto rendere conto prima.
Forse non avrei dovuto proprio andarci quel giorno all'East River Park, alle cinque.
Forse non avrei dovuto inseguirla per le scale, quella mattina, e forse non avrei dovuto niente.
Avrei dovuto lasciarla fin da subito, e dirle che io faccio solo del male, e quello continuerò a fare, nient'altro.
Mentre penso a questo, ovviamente, la bestia è d'accordo. Forse è lei che me lo fa pensare.
«Vai, man» mi dice Håbe, dandomi le spalle.
Non riesco a dirle quello che vorrei dirle, perché la paura dentro me di farlo è così forte che a stento respiro.
Mi alzo, e il mio corpo sembra di piombo. Lei non si gira a guardarmi: forse sta piangendo.
Non mi è permesso di dire nulla.
E così vado. Ogni scalino che scendo è un tuffo al cuore: la parte di me stesso che è me, mi supplica di non aprire la porta che ho davanti, ma è troppo soffocata dalla paura.
"Sei uno stupido" ripete, e lo urla, e io mi sento quasi mancare.
Vado fuori, respiro, guardo il cielo.
Il gelo mi si insinua nel naso, e vorrei non essere me. Vorrei essere un lampione. O un'onda del mare. Un albero, una foglia. Un fottuto chicco di grandine.
Tutto ma non me.

***
«A quale traversa giro adesso?», chiedo. Mi tiro bene la sciarpa sul viso, il vento mi sferza in ondate di gelo puro.
«Dovrebbe essere la seconda a destra, se non ricordo male.» Doreen, dall'altra parte del telefono, mi da le istruzioni. «Non ti puoi sbagliare. È un edificio parecchio grande.»
Svolto l'angolo e vedo l'insegna: "Manhattan Bridges High School". «Grazie, Dor, l'ho trovata! Allora entro e speriamo bene.»
«Va benissimo! Fammi sapere come va, ok?»
«Certo, a dopo.» Attacco il telefono. Attraverso la strada di alberi. La scuola è davvero grande, con linee moderne, pitturata di rosso e bianco. Mi affretto a entrare dalla porta principale. Sono le tre del pomeriggio eppure è già praticamente buio a causa delle minacciose nuvole che si sono accumulate e il freddo fuori è una morsa: sentire il caldo dei termosifoni è un sollievo.
Mi tolgo la sciarpa e il capello, dandomi una manata ai capelli, e pulendomi le scarpe sul tappeto.
All'interno, dà l'aria di essere una buona scuola: ci sono tante bacheche, trofei, premi. Molti visi di alunni sono appesi alle pareti in foto ricordo di gite e uscite. Mi guardo un po' intorno, poi una signora all'interno di un gabbiotto alla mia sinistra fa cenno di andare lì.
«Salve», mi saluta. «È una nuova iscritta?»
«Salve! Oh, no, veramente no. Sono venuta a chiedere un'informazione, in realtà.»
«Mi dica pure.» La donna ha i capelli grigi appuntati sulla testa in uno chignon un po' disordinato, e porta un maglione blu scuro. I suoi occhi sono piccoli e mi sembrano anche un po' severi: se quella è anche un'insegnante, deve essere tosta.
«Ecco, vede, sto cercando di sapere il nome di un ragazzo che conosco, e che so ha frequentato questa scuola.»
Lei inclina la testa «Lo conosce ma non sa il suo nome?»
Eh, già. «Esatto», sospiro.
Lei scuote la testa. «Mi dispiace, signorina, ma per la privacy non posso divulgare informazioni altrui senza una delega o un permesso.»
Come non detto. «Beh, già, immaginavo. Non importa. Grazie comunque.»
«Se vuole fare un giro per la scuola, in ogni caso, può andare. Abbiamo una biblioteca molto grande. Se vuole l'accompagno.»
Ormai sono arrivata fin qui. Perché no? «Va bene. Grazie.»
La donna mi guida lungo il corridoio, e mi fa entrare in una porta di legno. «Eccola qui.»
È spettacolare. Una biblioteca di quelle antiche, una cosa che non mi sarei mai aspettata dalla forma moderna dell'istituto. Le librerie sono tutte in legno, un po' buie ma bellissime.
«La lascio guardare allora, faccia pure con comodo. Per qualsiasi cosa, chieda alla signora laggiù, se vuole un consiglio, o un libro.» Mi indica un grosso bancone rotondo, dritto davanti a noi, all'interno del quale una donna di mezza età legge un giornale.
«Grazie mille. Arrivederci!», la saluto.
Mi metto a gironzolare un poco. Tutti i libri sono ordinati alfabeticamente. Ci sono diverse sezioni: storia, scienze, arte, letteratura, addirittura un'intera parte dedicata ai miti. Mi sporgo un poco per leggere qualche titolo, e sospiro.
«Posso aiutarti?»
Sussulto.
«Oh, scusami. Non intendevo spaventare.» È la donna di prima, quella che leggeva il giornale dietro il bancone. Mi regala un sorriso di scuse. Il suo volto ha qualche ruga ma azzarderei a dire che la rendono ancora più bella: ha i capelli color miele legati in una coda sulla spalla, non troppo lunghi. Porta un semplice maglione grigio, un poncho e un paio di jeans.
Degli occhiali da lettura le pendono sul petto.
«Mi scusi, ero sovrappensiero, non è colpa sua», la rassicuro.
«Dimmi, posso aiutarti in qualche modo?»
«In realtà temo di no.»
«Non sei una studente della scuola, vero?» Inclina un po' la testa, e mi ricorda me quando divento curiosa.
«No, affatto.»
«E neanche sei qui per i libri, li guardi come si ti avessero fatto un torto.»
Mi metto a ridere, e lei mi sorride di nuovo.
Mah, mi sembra tempo perso, ma decido di provarci: «In realtà, sono venuta per delle informazioni, riguardo ad un ragazzo che so ha frequentato questa scuola. Speravo che qualcuno potesse dirmi come si chiama. Ma non avevo molte speranze.»
Quando la guardo nuovamente, il suo sorriso ha per un attimo un fremito, e trema. «Vieni, raccontami meglio.»
Mi porta al bancone: lei entra nel cerchio di legno, io mi siedo sulla sedia di fronte a lei.
«Raccontami un po'. Siete amici?»
«È... molto complicato. Lo conosco, e mi ci sono affezionata. Ho anche una sua foto se vuole vedere, ho portato la macchinetta apposta e...»
Lei si poggia con le mani sul bancone, e mi guarda. Mi studia un poco poi scuote la testa. «Descrivimelo tu.»
Mi sento un po' in soggezione, non lo nego. Ma quella signora ha qualcosa negli occhi grigi e tempestosi che mi convince a descriverglielo. «È un ragazzo alto, con i capelli neri e gli occhi blu. È schivo, e complicato. Lavora in un bar, adesso, e abita da solo in un palazzo in centro...»
M'interrompo, perché sul suo viso compare uno strano sorriso, ma lei mi fa un gesto con la mano, come a dire "vai avanti". Allora proseguo: «...Io vorrei capire come si chiama, perché nessuno sa il suo nome, e da quanto ho capito, anche lui lo odia. Per questo si fa chiamare "man". Ho bisogno di saperlo per capire se... posso aiutarlo.»
La donna mi guarda quasi con gratitudine, e posso giurare: i suoi occhi sono lucidi.
Si volta, e urla: «Isabel? Mi puoi coprire un'oretta? Ho da fare, torno un attimo a casa e poi arrivo.»
Si sente una voce provenire da dietro uno scaffale. «Va bene, Al. Vai pure.»
La donna raccoglie le sue cose, si infila il giaccone e mi guarda: «Vieni con me. Credo tu debba sapere delle cose. Ma questo non è il posto adatto.»

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top