Cap 5
Sul treno verso Lecco, non mi siedo mai vicino a Paolo. Lui ha la sua compagnia, oltre a me. Sono tutti maschi, tranne Ester. A Paolo piacerebbe che io mi unissi a loro, ma io preferisco ascoltare musica o fare i compiti che non ho concluso il giorno prima. Questa mattina, per esempio, sto tentando di finire la versione di latino. Paolo chiacchiera con Ester. Stanno scherzando sui capelli di lei, ma non riesco a capire se lui le fa degli apprezzamenti. Lei ride. E' carina, Ester, con tutti quei ricci. Però non fa molta luce. Le persone speciali irradiano una luce visibile, per me. Lei non è speciale.
«Laura?»
Samantha mi dà una gomitata.
«Siamo quasi arrivati», mi dice, «hai finito con quella versione?»
Samantha copia sempre le versioni di tutti. Sospiro e le passo il foglio. Non sono sicura che sia giusta. Ho messo qualche frase che non ha un vero e proprio senso logico. Ma tanto a lei importa solo di prendere la sufficienza.
Mentre camminiamo tutti verso il Liceo, Ester sfiora la mano di Paolo. Lui si gira a guardarmi e fa una smorfia buffa. Lei non se ne accorge. Prisca mi passa davanti e va a sedersi al suo posto, in prima fila. La prima ora abbiamo matematica. Cerco di rimanere concentrata, ma continuo a guardare le sue spalle dritte sulla sedia e penso alle sue evoluzioni sul ghiaccio, così perfette.

Lei a un certo punto si passa una mano tra i capelli lunghissimi. Una volta, ridendo, mi ha chiesto perché non faccio i campionati per i non vedenti. La odio. Lei non sa nulla di me. Il sole questa mattina mi dà più fastidio del solito. Mi schermo la fronte con le mani e scrivo i numeri sul foglio. Paolo si sta passando dei bigliettini con Ester, ma il professore non se ne accorge.
Le altre ore per fortuna passano veloci. Quando consegno la mia versione la prof mi sorride e Samantha alza i pollici verso l'alto.
All'intervallo Paolo molla Ester e gli altri per venire da me. Vorrei solo bermi il mio succo senza parlare con nessuno.
«Sei tesa per oggi, vero?»
Come fa a capirmi sempre così bene? Devo essere trasparente, per lui.
«Un po'»
«Io una volta sono stato dallo psicologo», bisbiglia, e si guarda in giro, per assicurarsi che nessuno abbia sentito.
«Ah sì?», domando stupita. Questa parte me l'ero persa. Non me l'immaginavo proprio.
«E' stato tanto tempo fa, non è che ricordi poi molto», mi spiega, gesticolando. Quando è in ansia gesticola più del necessario e qualche volta rischia di farmi saltare gli occhiali dalla faccia.
«E com'è andata?»
Sbuffa.
«Ero piccolo. E' stato quando continuavo a chiedere dove fosse finito mio padre».
Il papà di Paolo è morto quando lui aveva cinque anni. Era un fumettista. Sua mamma da allora è come impazzita. A parte non uscire più di casa, ha la stranezza di accumulare le cose. Non butta via niente. Se Paolo le getta via qualcosa di nascosto, lei si arrabbia tantissimo. Non vado volentieri a trovarla. Il suo salotto mi opprime e non c'è posto dove sedersi. Forse anche per questo la nostra casa sull'albero è tanto ordinata.
«Non ho paura dello psicologo», gli dico dopo un po' «mi dà solo fastidio andarci. Dovrò saltare l'allenamento anche oggi»
Paolo annuisce. La sua pelle bianca illuminata dai raggi del sole mi scotta gli occhi. Passiamo l'intervallo a parlare della versione e della ricerca di geografia.
Quando suona l'ultima ora, esco in fretta per non doverlo vedere di nuovo appiccicato a Ester e mi trovo davanti la mamma.

Ha messo il vestito viola. Lo so perché è quello più scuro che ha, con la scollatura a v.
«Cosa ci fai qui?», protesto.
«Abbiamo l'appuntamento alle due, ricordi? Faremo prima se andiamo in macchina. Ti ho portato un panino»
«Non ho fame, adesso. Mangio sempre più tardi»
La mamma lo rimette nella borsa e mi fa salire in macchina.
«E' solo un colloquio», mi spiega, mentre ingrana la prima «sono stata da lui un paio di volte, è uno molto bravo. Ti piacerà»
«Sei stata da lui...?»
La mamma ignora la domanda.
«Tuo padre non ci sarà a cena, questa sera. Deve rimanere a Milano»
Quando lo chiama "tuo padre" e non Mario, vuol dire che ce l'ha con lui. Mio padre lavora per una concessionaria di automobili. Spesso è in trasferta e sta via anche settimane. Quando torna, la mamma gli tiene sempre il muso per un po'. Come se volesse farlo sentire in colpa perché la lascia da sola.
Lo studio dello psicologo non è come me l'ero immaginato. In realtà non è neanche uno studio, ma è il soggiorno di casa sua, una villetta affacciata sul lago. Evidentemente guadagna un sacco di soldi, con le sofferenze altrui.
Lui e mia mamma si abbracciano.
«Ross», dice lui, stringendola. In pochi chiamano mia mamma con quel diminutivo.
«Carissimo Enrico, sono felice di rivederti», cinguetta lei.
Entrambi si girano a guardarmi.
«Ciao, Laura», esclama lui. Mi sta già sulle palle.
«Allora vi lascio soli», dice Rossella. Perché è questo il nome di mia madre. Rossella. E si dilegua.

Lui mi fa accomodare su una sedia e mi si mette di fronte. Ha un abito elegante e capelli che gli vanno da tutte le parti. Più che uno psicologo, sembra uno scienziato pazzo. Nelle mani tiene un block notes e una penna. E' pronto a segnare le cavolate che dirò. Ma io non ho intenzione di dire nulla. Ci guardiamo per alcuni minuti senza parlare. Enrico continua a sorridere. Io a tacere. Mi sembra di essere davanti ad Annibale, quando facciamo il gioco di fissarci senza scoppiare a ridere. Quella che non deve ridere, ovviamente, sono io, in quel caso. Non sopporto più questo silenzio. Sospiro. Lui tace e scribacchia qualcosa sul block notes. Che cavolo scrive? Non ho detto ancora nulla. Altro sospirone.
Enrico sospira con me.
«Perché sei qui, Laura?»
«Mi ci ha portato Ross», rispondo prontamente.
«Perché pensi che ti ci abbia portato?»
Devo ammettere che le sue domande sono meglio del silenzio. Se devo passare cinquanta minuti con quest'uomo, tanto vale che parli.
«Immagino che sia perché ultimamente non ho più molta voglia di fare le cose»
«Quali cose?»
«Andare a scuola. Uscire con gli amici. Pattinare. Dormire»
«Dormi male?»
«Non mi piace dormire»
«Perché?»
«Perché amo la notte»
Scrive come un forsennato. Mi piace l'idea che non stia dietro al flusso delle mie parole e allora mi viene voglia di continuare a parlare.
«Di notte ci vedo meglio. E allora mi sento anche meglio. Dormire di notte, per me, è tempo sprecato»

«Non puoi dormire di giorno?»
Lo guardo come se fosse un idiota.
«Ho la scuola e gli allenamenti... Come faccio a dormire di giorno?»
Lui annuisce. Di nuovo il silenzio. Smette persino di scrivere.
«Se potessi...», mormoro, e mi stupisco di come esca strana la mia voce «se potessi vivrei di notte e dormirei di giorno. Ma sarei la sola a farlo»
«Pensi che saresti sola?»
«Almeno... sola rispetto a tutta la gente che frequento. Alle cose che voglio fare. Alla persona che voglio diventare»
Enrico annuisce di nuovo. Mi sento terribilmente a disagio, perché senza rendermene conto gli ho già detto più del dovuto.
Rimaniamo di nuovo in silenzio, questa volta ancora più a lungo. Talmente a lungo che gli occhi iniziano a bruciarmi.
«Qualcosa non va?», mi chiede.
«No, è che... I miei occhi si stancano facilmente»
«Come te?»
Non ci avevo mai pensato, a questa cosa. In fondo ha ragione lui. Mi stanco prima dei miei occhi malati.
«Io... non posso vedere i colori come le altre persone».
L'ho detto. E mentre ho pronunciato queste parole davanti allo psicologo, mi sono resa conto di aver firmato la mia condanna. Fin lì Enrico stava andando bene. Molto bene. Ma adesso, lo so, in lui prevarrà la curiosità di chiedere. Di capire. Ti prego, non farlo. Non chiederlo. E invece lo fa.
«Cosa vedi, esattamente?», mi domanda, preparandosi a scrivere.
Cosa vedi, Laura? Perché è così importante sapere come vedo io il mondo? A nessuno viene in mente che forse tutte le persone lo vedono un po' distorto, che quello che chiamano "rosa" è un colore che non percepiscono allo stesso modo? E che importanza ha, poi, vedere o non vedere come tutti?
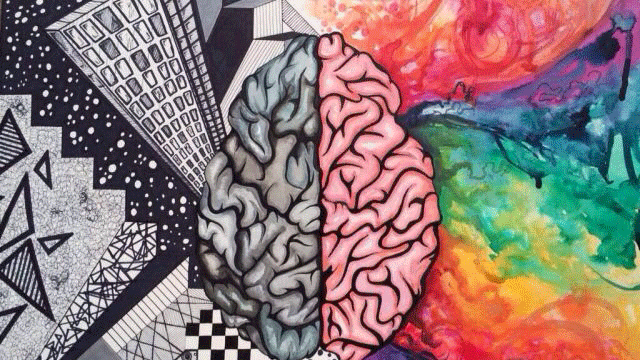
Mi alzo dalla sedia. Lui mi guarda smarrito. Non fa niente per fermarmi. Mi avvio a grandi passi verso la porta e quando la apro inizio a correre.
I colori non sono altro che luce scomposta. Illusioni, in fondo. Io vedo il mondo senza illusioni. Cosa vedo esattamente? Vedo tutte le tonalità del nero. I punti d'ombra. Le zone oscure. E quando qualcuno è luminoso, io me ne accorgo. Quando c'è purezza, io sono lì, ad abbracciarla, perché è la luce che crea il colore. Ci sono nata, col buio addosso. Ho studiato i colori perché gli altri non sapessero, non capissero che io sono diversa. Mi sono sforzata di ricordare gli accostamenti delle mode, la teoria corpuscolare di Newton, gli esperimenti di Goethe, e Jung e tutti gli altri. Ma tutte le loro teorie, tutte le spiegazioni scientifiche, su di me non funzionano. Non posso sfruttare il potere dei colori. Posso solo immaginarlo.
Non voglio piangere. Allora corro più forte. Quando sento il sapore del sangue in bocca, mi fermo. Ho percorso una via mai vista, esono davanti all'insegna di un piccolo pub. Non sapevo della sua esistenza.Entro, sperando ci sia poca luce. Mi tolgo gli occhiali e mi siedo al bancone. Respiro forte.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top