❥ 𝕴l brutto anatroccolo
Quando facevamo quelle giornate Kunta Kinte con Mannoni, non solo venivamo schiavizzati, ma quasi sempre finivamo talmente brasati che la voglia di uscire il sabato sera, era pari alla voglia di cadere in ginocchio sulla ghiaia.
A me la voglia di uscire non venne nemmeno il giorno dopo ancora, comunque. Volevo soltanto restarmene avvolta in quella crisalide di cotone rosso stinto, il mio personalissimo bozzolo di lenzuola prese in offerta alla Standa, a maledire l'universo per avermi schiaffato esattamente lì, in quel letto, in quella camera, in quell'appartamento. Il soffitto aveva chiari segni di umidità, la finestra affacciava sul panorama mozzafiato dei "complessi abitativi", il cielo era dello stesso colore delle masse informi che togli dallo scarico della doccia quando si intasa.
Fu inevitabile ripensare al giorno prima, alla sveltina in quel bagno "di servizio" pieno di ottoni lucidati alla perfezione, piastrelle di maiolica e specchi con cornici dorate. A tutto quell'abbagliante e costoso splendore che aveva avvolto me e quel tizio dal cazzo in urgenza.
Inutile, abbagliante e costoso.
Mentre io dormivo tra le offerte stracciate di fine serie del supermercato, in una stanza in cui ero costretta ad appiccicare poster alle pareti per coprire la muffa, la gente come lui pisciava nello sfarzo più scintillante.
E poi quei soldi allungati così, senza esitazione, allo stesso modo in cui io avrei potuto al massimo allungare una Brooklyn alla cannella: quasi con sollievo, ma giusto perché hanno un gusto che fa veramente cagare.
A riscuotermi da quei pensieri, fu il rumore dei sassolini lanciati ripetutamente contro la mia finestra che ticchettarono sul vetro.
E c'era soltanto una persona che con me aveva questo tipo di approccio da quando aveva imparato a usare le braccia per lanciare sassolini.
Avrei voluto, o forse avrei dovuto, far salire Luca e, magari, parlargli di quello che mi era successo. Pensai che, probabilmente, mi avrebbe fatto bene per esorcizzare quel chiodo fisso che dal giorno prima tenevo piantato nel cranio...
«Ma 'fanculo.» sbuffai tra me e me, restando tutt'uno con il materasso. «Non c'ho voglia.»
Come era prevedibile, dopo un po' i sassolini smisero di colpire la mia finestra, segno della sua resa. Mi chiesi se lui avesse trovato le forze di farsi la sua "pesca grinzosa" quando, dopo un tempo infinito, trovai la forza di sgusciare pigramente fuori dalla trincea di coperte per fermarmi di nuovo davanti allo specchio. Storsi le labbra in una smorfia amareggiata nel constatare la presenza all'appello delle tenui occhiaie che solcavano la pelle diafana del viso e ci passai il pollice sopra come per cancellarle – invano, naturalmente. Mi osservai i capelli corti e lisci, arruffati a causa del prolungato contatto col cuscino, presi una ciocca tra le dita e avvicinandomela al volto la ispezionai con cura. Anche la chioma appariva più spenta e secca del solito; a uno sguardo più attento e ravvicinato mi accorsi persino della presenza di alcune doppie punte.
Stavo invecchiando?
Le marchette facevano invecchiare?
E io, avevo davvero fatto una marchetta?
Ciabattai verso la cucina. Mi sentivo come se a malapena avessi la forza di sopravvivere, figuriamoci quella di ragionare. Aprii la dispensa e, a parte una desolazione degna della scena iniziale di C'era una volta il West, non trovai assolutamente nulla. Maledissi mentalmente mia madre e quella stronzata che non avesse neanche il tempo di andare a fare la spesa, e mi si accese come una lampadina: le mie elucubrazioni erano mere e impalpabili seghe mentali, ma le trecentomila ancora arrotolate nella mia tasca, invece, erano vere. Eccome.
In tempo zero indossai due cose a caso da dentro l'armadio e uscii di casa, immolando il mio fancazzismo in nome di una causa superiore: Pan di Stelle.
Avrei raggiunto l'alimentari all'angolo, preso i Biscotti - chè no, la lettera maiuscola non è un caso - e qualche altro bene di prima necessità, e sarei tornata a rinchiudermi nella mia tana a crogiolarmi nelle mie paranoie inutili da ragazzina disadattata finita troppo vicina a un pene.
Uno dei pochi lati positivi del vivere in un quartiere di merda come il Chernobyl, era un certo mortorio in giro, a parte gli zarri con la Golf GT e Sweet Dreams di La Bouche sparata a tutto volume. La giornata era fresca, ma c'era un sole piacevole, il vento mi scompigliava i capelli e io pedalavo giuliva la mia bici sgangherata godendomi il silenzio.
«Ehi, Pulce.»
Ecco, il silenzio aveva definitivamente fatto le valigie, sotto richiesta di sfratto. Continuai a pedalare, ignorando quel richiamo palesemente di proposito.
«Pulce?» ritentò allora Luca, più forte, dando un'altra spinta al suo skateboard consunto, le mani nelle tasche dei jeans e lo zaino mezzo vuoto impiccato a una spalla.
Pulce, che soprannome di merda.
Un soprannome che novantanove persone su cento potrebbero reputare grazioso, quasi tenero, ma che invece io odiavo, soprattutto per la vicenda che c'era dietro e che mi aveva segnato in modo irrimediabile l'ingresso in adolescenza.
Quando ero piccola, per arrotondare il suo stipendio da fame, mio padre lavorava come tuttofare per una ricca famiglia della città, una di quelle per cui tutto quello che conta è apparire, poi il resto è noia. Tuo marito potrebbe essere un serial killer, tua moglie la proprietaria di un bordello e tuo figlio un maniaco compulsivo, ma finché ti mostri adeguatamente impeccabile agli altri, allora non importa a nessuno cosa c'è sotto la patina di simulata perfezione.
Ecco cosa pensavo della famiglia Maggi quando mi capitava di fantasticare sulla loro vita piuttosto che sulla mia, che era complicata già allora. Quello che non avrei mai potuto immaginare, però, era che Serena, la minore dei tre figli dei signori Maggi, fosse una squinternata sadica e ossessiva. E posso assicurarvi che sono stata anche fin troppo buona a definirla così.
A dispetto del suo nome, infatti, era una prepotente di merda già alla tenera età di dodici anni e aveva trovato in me il bersaglio perfetto delle sue angherie. Ero più piccola di lei di un anno, con una famiglia messa come il cane in Chiesa e un corpo gracilino che di femminile aveva solo le bambole nella cesta dei giochi. Perciò Serena si divertiva proprio a tormentarmi, era il suo passatempo preferito. Non perdeva mai occasione per attaccarmi post-it dal sapore infantile sulle spalle o sbriciolarmi la crostatina di sottomarca nello zaino, e non si contavano più i segni dei pizzicotti che mi lasciava sulle braccia quando i grandi non la guardavano.
Io non battevo ciglio, evidentemente anche allora ero una sottona indolente.
Finché, un giorno, il livello di cattiveria delle sue malefatte non aveva subito un'impennata: mentre me ne stavo per i fatti miei a fare i compiti in un angolo del giardino, nell'attesa che mio padre finisse di falciare il prato della villetta dei suoi, mi aveva appiccicato una quantità spropositata di chewing-gum masticati sulla testa. Mi aveva presa alle spalle e quando avevo cercato di divincolarmi, mi ero ritrovata, senza sapere neanche io come, con lei cavalcioni addosso che mi teneva ferma.
Non so da quanto tempo conservasse tutte quelle cicche masticate, ma è chiaro che bisogna avere davvero qualche rotella fuori posto per fare una cosa del genere.
La cosa che mi ferì si più di tutta la faccenda, però, era stata sentire mio padre in primis giustificare quel gesto, minimizzarlo. «Sono cose da bambini, solo un gioco finito male.» aveva ripetuto più volte sulla soglia di quella casa che di bello aveva solo la facciata, alla madre di Serena, la sola, in mezzo a tutto quel teatrino, a sembrare davvero costernata nel vedere i miei capelli ridotti come uno scopettino del cesso, ma con le gomme sopra.
Mia madre mi aveva tagliato tutte le ciocche, una volta a casa. Nel vederle cadere sul pavimento una ad una, avevo pianto in silenzio. Il risultato era qualcosa di disastroso, perché la stronza aveva spiccicato ben bene la maledetta gomma tra i capelli e, quando mamma aveva finito con le forbici, avevo l'aspetto di uno di quegli sfigati a cui non resta che infrangere uno dei canoni estetici fondamentali e farsi il riporto. Mi erano rimasti giusto i capelli dietro la testa e niente sopra, così, alla fine, avevano optato per tagliarmi anche quelli.
Un cazzo con le orecchie, ecco cosa sembravo con la testa completamente rasata.
A Luca avevo detto di avere il raffreddore quando l'indomani e il giorno dopo ancora non ero andata a scuola. Ma il terzo giorno, nonostante le mie preghiere di starsene fuori dalle palle, si era presentato comunque alla mia porta.
Avevo provato a nascondermi dietro al battente, ma non c'era stato verso di dissuaderlo: con una spinta, l'aveva aperto e la mia immagine orrida gli si era palesata davanti agli occhi.
Luca aveva la proverbiale abitudine di sfottere le persone, ma, ciononostante, quella volta era rimasto in silenzio, con gli occhi sgranati e la faccia attonita bloccata a guardarmi.
«Devi tornare a scuola.» aveva detto soltanto, dopo qualche secondo di silenzio che interpretai come sconcerto.
«Non ci penso proprio.»
«Perché?» aveva chiesto inclinando il capo, come se non fosse abbastanza lampante il motivo.
«Mi prenderanno tutti in giro.» avevo soffiato tra i denti che tenevo stretti per non scoppiare in singhiozzi.
«Che cazzo te ne frega? Tu torna lo stesso.»
«No!» avevo letteralmente urlato. «Sono inguardabile.»
«Sei sempre tu, solo senza capelli. E domani vengo a prenderti e andiamo a scuola.»
Se ne era andato sbattendo la porta, ma al contrario di quanto detto, tornò alla carica solo due giorni dopo. Aveva piantonato casa mia finché mia madre non mi aveva costretta a scendere dal letto e prepararmi. Quando avevo aperto la porta, nel vederlo, ero rimasta di sasso, immobile come una statua di sale.
Si era rasato completamente a zero.
«Che cosa hai fatto?» avevo esalato con le lacrime agli occhi nel vedere la pelle più chiara della testa dove un tempo c'erano i suoi bellissimi capelli scuri. Quasi mi dispiaceva più per i suoi che per i miei.
«In classe c'erano le pulci. Ce li siamo dovuti tagliare tutti quanti.»
È da allora che aveva preso a chiamarmi Pulce.
Lo odiavo quel nomignolo, ma mi chiamava in quel modo così tanto spesso che ad un certo punto non avevo potuto più farne a meno. Era diventato una droga sentirglielo dire, una di quelle che mi piaceva prendere.
Pian piano, anche le altre persone avevano preso ad usarlo, era passato di bocca in bocca come un'epidemia di mononucleosi e mi era rimasto appiccicato addosso in maniera indelebile.
Anche se lo odiavo.
Tranne quando era Luca a dirlo.
«Sei diventata sorda, per caso?» la voce di Luca sfocò la bobina del film dei miei ricordi e mi fece tornare con i piedi per terra. O meglio, sui pedali, dato che ero in bicicletta.
«Ieri sera sei sparita e stamattina non ti sei fatta viva.» aggiunse quando, accelerando, mi affiancò con il suo skate scortecciato.
«Lo so.» risposi.
Non è un'osservazione molto acuta per uno scaltro come lui, pensai.
«Perché?»
Feci spallucce, lui corrugò la fronte. Non lo guardai se non con la coda dell'occhio, che alla fine è la parte migliore della vista: coglie i dettagli e ne rallenta la proiezione. A testa bassa, continuavo a pedalare con indolenza. Lui accelerò, si piazzò davanti a me e per poco non gli finii addosso. I freni fischiarono, le ruote stridettero sull'asfalto, i piedi si piantarono sul suolo, il sedere scattò via dal sellino.
Da sotto il cappuccio, lo guardai male, anche se sapevo benissimo che la cosa non lo scalfiva neanche un po'.
Luca aprì e chiuse velocemente gli occhi, come appena dopo un flash. Si avvicinò e con un gesto scortese mi tirò via il cappuccio.
«Non ti ha fatta venire, a quanto pare. Altrimenti saresti più rilassata.»
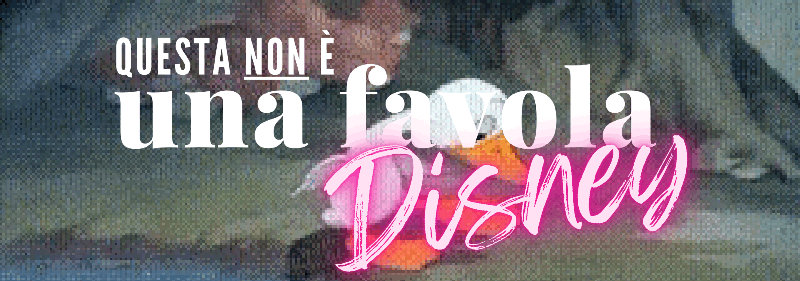
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top