67. L'estate non canta più
"Che cosa fa? Per vivere intendo?"
"Oh... sono di passaggio"
The man who fell to Earth (1976)

«Tilde, per piacere! Stai ferma un minuto, già la mia connessione lascia a desiderare, non ti ci mettere anche tu con il tuo tremolio! Il tuo viso sembra uno di quei quadri a cui sei così disperatamente devota».
Le parole di nonna Fauste, colte da un pizzicore esagitato, risuonano nelle mie orecchie scarmigliate, punte esattamente da quel tono concitato che dovrebbe istigarmi a farmi smettere. A interrompere quel fremito convulso a percorrermi i nervi dei polsi.
E le sue ciglia mordicchiate da un cipiglio arricciato riempiono lo schermo del mio cellulare, in una severità che di modulato ha ben poco.
Fosse facile.
Una parola a dirsi...
Detto da lei, che si trova così lontana da me a più di quattrocento chilometri di distanza, dallo splendore di quelle vette immerlettate di nuvole bianche e immerse nella bruma, e dagli incanti degli abeti e le loro fronde a baciare il cielo come a volergli fare dispetto. Lassù, dalla sua montagna, non può capire.
Perché mia nonna non c'è.
No... lei non è qui assieme a me, accanto.
Non può sentire i brividi intemperanti scalzati dal cuore, a sbattere come ali inavvertibili di uccellino, smaniose sui contorni silenziosi delle vertebre. O la cortina delle palpebre, le ciglia perlate d'ansia, scosse da un tremore così sbiadito che sarebbe stato sciocco spiegarlo a parole. Cercare di far vedere l'invisibile a qualcuno che, probabilmente, non l'avrebbe mai intravisto.
Non nel modo che avrei voluto io, almeno.
Mia nonna non potrebbe nemmeno adagiare una mano sulla mia scapola, premuta per intero, e percepire il respiro aritmico a cogliermi il fior dei nervi, così scabro da scivolare attraverso un pertugio irrisorio delle labbra anziché dalle narici.
Un'agitazione spasmodica mi divora in un lento declino, e nemmeno lo sfregarmi le guance macchiate di vermiglio — fievoli strinature di sole — mi aiuta a dissipare quel manto oscuro d'inquietudine.
Perché a stagliarmi ritta in piedi ai limiti dell'entrata del Caravaggio ci sono io, con le caviglie tremule, i talloni a picchiettare nervosi per terra e il display del cellulare colto dallo sfarfallio febbrile dei miei movimenti, non lei.
Nell'attesa dei quadri finali, il voto fatidico dopo lacrime di sangue e fatiche titaniche, schiene ricurve sopra i libri e capelli a segare la vista, separando noi dalle tentazioni.
Da una qualsiasi tentazione.
«Nonna... c'ho l'ansia, va bene?!», dalle labbra mi esce un'esclamazione tinta di accento toscano così marcata che lascia sorpresa anche a me per degli istanti che paiono infiniti.
«Eh ma così, cara mia, l'ansia la fai venire anche agli stambecchi quassù in montagna. Stai serena un momentino, tanto ormai il più l'hai fatto, no? Gli esami sono passati. Di cosa ti preoccupi? È solo un voto, non ti hanno mica bocciata come quello lì. Il tuo amico di classe... com'è che si chiama?» recita nonna Fauste infilando le mani fra le ciocche cortissime dei capelli lambite dal sole, fresche di taglio.
«Ma, nonna, Rainer non ha mai aperto un libro in tutto l'anno scolastico! Si rifiutava persino di farsi interrogare e consegnava costantemente i fogli delle verifiche in bianco, nemmeno la briga di inserire il nome si prendeva. E le assenze superavano di gran lunga le presenze... il suo banco mendicava affetto... E poi è stato già bocciato due volte, una terza per lui non fa la differenza, anche se stavolta sarà senza Sara. Lei è stata finalmente ammessa a questi benedetti esami di quinto» chioso tutta impettita, mascherando un vuoto d'ansia con un colpo di tosse.
«...Non tutti possono essere come il tuo Leonardo» sillaba piano, in un sorriso che la dice davvero lunga, disegnato di un'intenzione che lascia ben poco alla fantasia.
E il ricordo di non essere sola — ma in compagnia, qui fuori in attesa — mi piomba addosso in un'onda gelida di realtà. Sale a invischiare le ciglia di consapevolezza, schiuma a pizzicare le caviglie di assennatezza. Quella razionalità, quella logica che tanto io ho odiato, mal visto con i miei occhi costellati di sogni, e il mio animo leggero, di piuma, che indossa scarpette di cristallo in un tappeto di piombo.
Eppure... oggi quella razionalità e logica hanno una sfumatura quasi accettabile per me.
Una veste più... ammissibile, quel guscio opprimente abbandonato da una parte, lì, dimenticato nel suo scheletro di regole e leggi. Non più a guardarmi di traverso, come il piglio di una bestia pronta a volermi fare a pezzi.
Perché ora ha un significato rivoluzionario, un sapore diverso, un profumo dolcissimo. Sinonimi che assumono le sue fattezze.
Leonardo per me è il risultato di un'equazione incomprensibile, misteriosa, di quei segreti illeggibili anche per le menti più brillanti.
Ed è reale, qui accanto a me, distante pochissimo dal mio viso profilato e l'affermazione della nonna a rimpinzare quel silenzio dipinto dal vento. È la mia realtà che posso trattenere in punta di dita.
E tra i miei sfarfallii di ciglia, i capelli ricresciuti, caotici colti da un moto frenetico, e le pupille a guizzare in lampi sfocati dalla facciata del Caravaggio sino al volto ovale e scolorito di Fauste, attraverso quel vetro anonimo, tutto si tinge come una tela appena sfiorata da un pennello.
È l'accettazione; che scava, si fa strada fra gli ultimi dedali della mia adolescenza, del mio essere "bambina", che estirpa le erbacce, strappando il brutto per lasciare spazio a qualcosa di migliore. Qualcosa in attesa di me, di me soltanto.
La fine e l'inizio di tutto.
A distanza di pochi minuti, tutto si sarebbe trasformato. L'aria punge, affollata di caldo, quell'alito rovente aggrappato all'estate e che divide le persone in due metà di odio e amore.
L'estate è una stagione intera, piena e levigata nei suoi pregi e nei suoi difetti, non è come la primavera e l'autunno — le mezze misure, le stagioni timide, tinte di quei modi riservati e discreti che solo chi fa sbocciare e poi appassire può capire, e possedere —, e si sa che le cose solo bianche o solo nere non mettono mai d'accordo nessuno.
L'estate ha addosso quell'odore di passato rappreso e futuro strappato.
«Che tra l'altro non mi hai nemmeno presentato come si deve. Me ne hai sempre parlato come fosse una divinità scesa in terra!» brontola di gentilezza, marcando su quella mia grave mancanza che mai sono riuscita a colmare, o per un modo o per un altro.
Ed è forse il momento migliore, questo. L'attimo perfetto per mostrargli chi è stato a svuotare le mie iridi stanche, opache, da quelle nuvole invecchiate di angosce, una coltre di grigiore, per poi colmarle di... azzurro. A macchiare il mio castano di una sfumatura così celeste, con il semplice guardarmi, a perdersi e lasciarsi andare.
Di distese di azzurro e fili dorati.
E mi distorcono ogni volta, ma è un disordine di cui non riuscirei a farne a meno, un disordine che ogni volta accolgo in me con beatitudine. Che non scambierei nemmeno con la pace più idillica.
Di farle conoscere colui che ha avuto quel raro potere... la capacità di trasformarmi facendomi restare me stessa.
Un sorriso s'inerpica sino a collimare sui contorni delle mie labbra, distendendoli piano, quasi di timidezza. Per poi svanire con l'abbassarsi delle palpebre, l'istante di un sospiro.
«Hai ragione» mormoro mentre le mie dita scivolano sull'avambraccio di Leonardo, ad accostarlo a me, sino a che il suo viso e la sua espressione orpellata di impazienza mescolata alla confusione non spicchi al di là dello schermo, ripreso dalla videochiamata, «nonna... lui è... be'... lo sai. Lui è Leonardo. E Leo... lei è mia nonna Fauste».
Le ciglia della nonna tremano appena quando scorge il riflesso di lui, del mio ragazzo; così più alto di me tanto da sembrare un gigante, così elegante nella sua camicia bianca e la pelle che pare alabastro finissimo anche in un giorno così pieno di sole. Sono costretta a piegare il cellulare verso l'alto, per riprenderlo meglio, e farle vedere, per la prima volta, la meraviglia della persona che ho scelto di tenere accanto senza rimpianti.
Un silenzio affatto scomodo ci circonda, quel tacere che non crea disagi e non fende crepe che a tutti i costi dobbiamo riempire, inutilmente.
In quell'attimo, Fauste contempla Leonardo con espressione ammaliata, uno sguardo rapito che soltanto io riesco a scorgere fra le pieghe della sua fronte increspata e la bocca contratta in una linea precisa.
Perché lei non è mai stata una nonna comune, come le altre, colma di dolcezze e caramelle incartate di delicatezze. No, la mia è sempre stata una nonna nata fra i rigori della neve e del freddo, temprata fra le cime degli abeti e il respiro condensato — sempre stata tutta d'un pezzo, come i suoi capelli mai portati più lunghi di quel modo, cortissimi rasenti gli orli delle orecchie.
Ma gli occhi... gli occhi costantemente accesi, a brillare di ogni emozione per quanto si ostini a tenerli nascosti alla penombra della sua tanto amata montagna.
E un po' ho preso da lei — io li ho sempre trattenuti celati fra i colori sgargianti di una pellicola da cinema, o impigliati fra i marmi di opere dimenticate, bellezze appartenute a tempi cui ora ci infondono malinconia.
«Il piacere è tutto mio, signora Weiss. La sua somiglianza con Adele è così discernibile» modula Leonardo con quel timbro conducibile a educazione esemplare, e mi domando, forse per la centesima volta, di come faccia.
Di come ci riesca. Di come ne sia capace, a essere mirabile e algido in questa sua effigie aggraziata, ornata di raffinatezza, e a essere anche... il mio Leonardo. Quello che si è mostrato solo a me.
Una poesia di contraddizioni, vene di estro scolpite nell'incarnato.
«Non farti ingannare, ragazzo. Lo pensi solo perché portiamo lo stesso taglio di capelli... ma-... Matilde? Perché questo signorino parla come se avesse inghiottito un vocabolario intero di lingua italiana senza nemmeno averlo masticato?».
E inaspettatamente le pupille della nonna declinano su di me, assieme a un cigolio di cardini, una porta a chiudersi dall'altra parte della videochiamata.
È appena tornata nella sua baita, rientrando dall'esterno, così lontana da tutto, così lontana dalla mia realtà. Uno spicchio di luce fa da alone ai suoi tratti incurvabili e per un attimo labile assume una forma quasi irreale.
Attraverso lo schermo, le iridi di Leonardo ridono insieme alla sua bocca, e bucano quella distanza irrisoria che separa noi — me e lui — da lei di una beltà che mi spezza il respiro. Inchiodandomi immobile, il mio sguardo a convergere su di lui come una calamita potentissima.
È il suo fascino di velluto, maliardo e incantatore, quello che fa capitolare ogni persona a passargli vicino... nel bene, e nel male.
«Lui è semplicemente... fatto così. Ma ti posso dire che quando si esprime in questa maniera, è come armonia per le orecchie... dovresti sentirlo quando legge un libro ad alta voce. Potrei starlo ad ascoltare per ore» le spiego dopo aver trattenuto un sospiro, incagliandolo fra i denti.
«Be' sì, sarebbe stato carino e interessante averlo potuto constatare dal vero. A Natale, magari. Ho sperato in una vostra visita... o almeno nella tua, come quella che fai ogni anno».
«Nonna, ti ho già chiesto scusa per non essere venuta! E tu mi hai perdonata. Cos'è, mi stai portando rancore? Siamo a luglio, diamine...» mastico interdetta, una ruga di stupore a solcarmi la fronte.
«No, ti sto solo ricordando che hai ancora tua nonna viva e vegeta, e che ti aspetta sempre qui a Livigno. E hai anche un nonno, uno zio e tre cugini. Manchi a tutti noi, non solo a me» rimembra con un tono punto di ovvietà.
"Come se a me non mancassero, loro".
«Magari potremmo fare così» s'interpone Leonardo con quella sua gentilezza piena di decori a contraddistinguerlo da chiunque, la voce serbata di riguardi, aggiustandosi gli occhiali appena comprati, sempre dorati, come quell'aura ad avvolgerlo, a inghirlandarlo per l'ultima volta, come quel dio che tanto incarna, «una piccola vacanza a Livigno, io e Matilde. Dovrei studiare per il test d'ingresso all'Università ma... lo faccio con estremo piacere. Almeno potrà... sentirmi leggere, e magari stringermi la mano come si deve».
Incastro la lingua fra i denti, di sottecchi lancio un'occhiata al riflesso della nonna.
«Magari sì. Potreste fare davvero così. Che ne dici, Tilde? Sei d'accordo? Tanto lo sai, la montagna in estate è una fiaba» mormora concisa, accantonando quei convenevoli che tiene debitamente a distanza.
Resto ammutolita, in tralice con le iridi intrappolate negli spigoli della mandibola di Leonardo, tesi al di là dell'incarnato. L'attesa silente, il tempo di uno sguardo d'intesa fra me e lui.
«Direi che può andare» acconsento.
E vorrei aggiungere dell'altro.
Chiederle come va la vita lassù, che pare davvero racchiusa in una sfera di cristallo lasciata a impolverare sulla mensola d'un camino, fregiata di fiocchi di neve, in un universo a sé stante, unico. Domandarle come nonno Abner sta lottando contro i suoi reumatismi, e di farla restare ancora un po', al telefono con me, fino a quando i quadri con i risultati non saranno appesi nella bacheca del Caravaggio.
Ma la notifica di un'altra videochiamata che porta il nome di zia Angelica splende di riflesso nelle mie pupille scure, dove un grumo di sole si annida nei loro dedali castani. Ed è tanto che non sento anche lei.
Un altro membro della famiglia troppo lontano da me, che non può starmi vicino in un momento così importante e delicato come questo.
L'istante dopo sono costretta a tagliare la videochiamata con nonna Fauste, titubante e rattristita. La saluto, raccomandandomi mille e mille volte di salutarmi tutti lassù, di baciarli sulle loro guance piene e tinte di rosa, di abbracciarli sino a stritolare le ossa, finché non scricchioleranno di affetto. Le rammento di aspettarci, ormai ho promesso — abbiamo promesso.
E, poi, finalmente:
«...Ciao, zia».
«La mia nipote preferita! Sentire la tua voce mi fa... felice così tanto».
L'effigie posata e austera della nonna viene rimpiazzata nell'arco di pochi secondi da un rovo che pare ardere selvaggio, una corona indomita di capelli a contornare l'ovale d'un volto familiare, pupille d'edera spiccano condotte dalle movenze di un sorriso.
Oltre gli orli delle sue spalle rivestite di una camicetta d'organza, verdissima come i suoi occhi, in quei piccoli spiragli che permettono lo schermo rimpicciolito del cellulare, si srotola un tappeto smagliante di lavande.
Ed è uno sfavillio di colori, strappati per poi costellarne le forme di quella sua arcata di sorriso. Un quadro dove vi è incisa indelebile l'estate, un canto rigoglioso e un soffio di vento a smuovere come dita fra steli d'erba.
«Wow... nei miei diciotto anni di vita non credo di averti mai sentita rivolgerti così a me. Cosa ti succede? È l'aria francese a fare effetto su di te? Oppure è la vacanza che dona benefici?» chioso sollevando un sopracciglio, percependo lo spigolo del mento di Leonardo attraverso la stoffa della blusa attorcigliata in un fiocco.
Chinandosi a schiena curva alla mia altezza per guardare meglio, a posarsi delicato sopra il costone della mia clavicola.
Poi è una staffilata scura di ciuffi, mossi da una folata d'aria, l'eco di una risata e infine lo schiocco di un bacio. Proprio lì, nel punto preciso all'angolo della sua bocca.
«Titòu» le sento spingere fra i denti, le fossette a scivolarle via, spronate dal fervore di una smorfia indispettita. Il tono con cui marca il nome del suo compagno... sì, pare quasi inasprito... ma è proprio per quello che capisco.
Che il sincero interesse, e amore, di Angelica è legato esattamente a quello.
«Salut, Matildà. Comment ça va? E i tuoi esami? Come sono andati quelli?» mi chiede con una naturalezza che riesce a sfumare ogni traccia di tensione, assieme a quel suo accento francese, a disgregare i muscoli che sino a prima se ne stavano inchiodati alla carne, percorsi da fitte di gelo.
«...Orale migliore non avrei potuto desiderarlo. A storia dell'arte sono andata una bomba, ho ricevuto i complimenti persino da Lunanuova e dalla Pancrazio, non poteva mancare alla maturità dei suoi studenti preferiti. Sai... Lunanuova è stato il professore che ha mi ha fatto da supplente per tutto l'anno e ora che Alba è diventata mamma credo proprio che dovrà farsi da parte, purtroppo. Ma vedeste... vedeste che bimba meravigliosa... ha certi occhioni che ti fanno innamorare al primo sguardo. L'ha chiamata Celia, perché quando l'ha guardata negli occhi ha detto che le hanno ricordato l'infinità che solo il cielo regala».
«Mati...», mia zia solleva il viso, la mano libera dal cellulare ad aprirsi a ventaglio dalla fronte in su, scostando quei fili di fuoco all'indietro, liberandosi da quella cortina impigliata fra le ciglia, «a proposito di madre, io devo dirti una cosa».
E per un istante quel timbro punto dalla titubanza e di discrezione, finezze che non fanno minimamente parte del cuore d'uragano di zia Angelica, mi fa dimenticare di Marta, Diego, Thalìa e Ludovico dirimpetto alla facciata del Caravaggio. Ad aspettare che quel portone venga aperto ancora una volta, un'ultima volta.
Riesce a macchiarmi di un'importanza nuova, aguzzando i miei timpani come se nulla di tutto quello fosse più di rilevanza — il voto, i miei amici, l'addio che avrei dovuto dare al mio liceo, l'ultima occhiata al mio riflesso a scrutarmi dal vetro della bacheca.
Una parte di me, di Matilde, che non avrei più incontrato, che avrei salutato, forse, fra cristalli di lacrime.
«Dobbiamo dirti una cosa» marca meglio Titòu, facendo passare un braccio sulle spalle istoriate di lentiggini di Angelica, e a quel punto le mie sopracciglia scattano all'insù, senza che io possa controllarle.
Lancio un'occhiata furtiva a Leonardo, in ascolto come me, calmo.
«Avete deciso di trasferirvi del tutto a Parigi? Credevo che Arles vi piacesse» commento perdendomi in una risatina pallida.
«Oh no, nessuno si vuole trasferire. Stiamo troppo bene lì. E se dovesse succedere, torniamo a Firenze, altro che Parigi!», la zia tronca sul nascere quell'ipotesi ben lontana dalla sua prospettiva di vita.
«...Allora? Sputate il rospo! L'ansia ce l'ho già di mio, stamattina», tamburello con la punta della scarpa sul terreno, impaziente, ancora un'occhiata al portone della scuola, serrato.
«Noi... be', noi...» inizia incerto Titòu, la voce tremula dalla... gioia?
E in quel momento, quando la mia attenzione è scolpita precisissima, gli occhi come due biglie rilucenti al fior delle ciglia, pronta per ascoltare, l'urlo di qualcuno straccia quel silenzio di vetro, artefatto, plasmato unicamente da me per isolarmi dal resto del mondo.
Rimango imbambolata, secondi di smarrimento, le palpebre che si muovono convulsamente, un gesto involontario. E un rollio di voci riempie l'aria, parole masticate e mormorii rimestati.
L'inizio della fine.
«Hanno aperto le porte! Possiamo entrare! Ragazzi, possiamo entrare!».
L'effigie minuta di Ottavio Gandolfo emerge dai contorni bui emanati dal rumore del portone, cardini che cigolano per aprirsi. Galleggia all'interno di una tenuta da trekking, coi calzoncini rasenti le ginocchia ossute e scarponi da escursione, la suola ancora impeccabile. Nessuna traccia di uno dei suoi rinomati completi, cravatta a sbuffo compresa.
Ma i suoi occhietti vispi sempre a sbattere dietro quei baffoni canuti, candidi e folti.
«Miei cari ragazzi» esordisce con le mani puntellate sui fianchi, a sfiorarsi la cintura di pelle a stringergli il busto, «il dado è tratto. I quadri sono finalmente a vostra disposizione, ma mi raccomando... entrate ordinatamente e non come una mandria di bufali dopo aver esagerato con il vino. Io sto partendo per l'Africa, per davvero, finalmente. Vi manderò tante belle cartoline».
«Signore, il suo volo è domani. Non capisco perché si è conciato in questo modo, non si sente un po' fuori luogo? Siamo ancora a scuola» lo rimbecca il vice-preside sdrucciolando alla sua sinistra, vestito in maniera più consona.
«Nobilis, è da due giorni che sono vestito così. Non trova che mi dia un'aria temeraria e di qualcuno che affronterebbe uno stuolo di coccodrilli? Magari... ecco...» proferisce Gandolfo con gli occhi ad abbassarsi, come a cercare qualcosa, «...ho dimenticato il mio binocolo. Me l'ha rubato quella bidella del malaugurio, quella Amelia!».
Ma Nobilis sembra non starlo a sentire, tanto socchiude le palpebre come a mascherare un moto di disperazione, a ficcarlo in luoghi che è bene lasciare inesplorati, il palmo a collimare sulla fronte.
«Ragazzi, prestate attenzione a me. I quadri sono appena stati appesi, potete entrare a guardare. Con ordine, senza schiamazzi e risatine folli» si riscuote poco dopo, stirando l'angolo della bocca come a farsi coraggio.
«Ci siamo», inghiottisco con voce spezzata, un rantolo a morirmi fra le mura della gola.
«Ci siamo» ripete Leonardo con lo sguardo incuneato al di là di Gandolfo, oltre quel portone spalancato.
L'erba si abbassa sotto il morso delle mie scarpe, suole rovinate. E io mi raddrizzo piano, l'arco della schiena a dolere, i muscoli delle scapole che tirano per l'ultima incrinatura di inquietudine tagliente.
«Mati...», ma la voce di zia Angelica sbeccata di turbamento mi inchioda sulle caviglie, uno spostamento d'aria dovuto a un colpo di vento e i miei capelli cascano serici rasenti ai contorni del viso, scampando alla costrizione dietro le orecchie.
All'angolo delle pupille, la scena dei miei amici che quasi prendono la rincorsa per farsi inghiottire dal Caravaggio, totalmente, mi sfiora vivida, reale come è.
L'unico a non muoversi di un sol millimetro, l'unico a non scostarsi è Leonardo.
Incatenato alla mia spalla da un filo finissimo, invisibile, legato in un laccio fra le nostre iridi.Il rumore preciso di tanti movimenti a fondersi in uno solo, voci e parole sconnesse amalgamate tutte in quell'attimo di euforia. Ogni cosa, al di là di quei quadri, ha perduto di significato nel mondo.
"...Ancora quell'inflessione anomala a pitturarle il tono".
C'è qualcosa... uno scintillio affilato, particolare, immerso nelle pupille di Angelica e Titòu.
Qualcosa che mi sfugge, che non riesco ad acciuffare nemmeno se lo volessi.
«Sì?» modulo gonfiando i polmoni, il polso fermo, come cementificato nei suoi stessi nervi.
«Non ti ho chiamata solo per chiederti degli esami, in realtà» scandisce lei, fissandomi dritta in faccia, «ma... per dirti anche... sì, insomma... io e Titòu, vogliamo che tu sia la prima a saperlo. È successo, noi aspettiamo un bambino».
Ed è l'ultima cosa che riesco a intendere, rimanendo issata in un muro plasmato dal nulla e dalla lontananza. Perché vengo inghiottita, sommersa, avvinghiata dalle braccia frenetiche come le ali di un insetto di Thalìa. Una presenza inavvertibile mi raschia il palato e io strizzo le palpebre, le ombre che calano su di me.
Mi ritrovo a udire un branco impreciso e informe di grida, risate a trasmutarsi in fischi.
Ne colgo poche e semplici parole. Scoccate come frecce nei timpani in un mormorio fra lingua e denti; Thalìa pare che non si ricordi più come si formuli un discorso sensato.
«...Tutti... andati... promossi... Anche tutti voi del quinto D... promossi, abbiamo ammazzato la maturità. L'abbiamo... uccisa».
Il mio volto si distacca appena dalla giugulare morbida e rovente di Thalìa, il suo profumo a solleticarmi le narici, e osservo tutto intorno a me.
Quello sfondo inconfondibile a pietrificarsi fra attimi labili, intensi di felicità.
Ce l'abbiamo fatta.
Noi... noi abbiamo fatto breccia nel cuore del futuro.
Intravedo la sagoma profilata di Ludovico, Laira incastrata fra le sue braccia, in punta di piedi, a ricoprirlo di baci. Diego che marcia con aria trasognata verso di noi, le pupille grigie attraversate da guizzi di estasi, e la bocca dischiusa, orpellata da un sorriso irriconoscibile, che non gli ho mai visto.
«Cento... ho preso cento, cazzo... sono uscito con cento...» mastica con quelle parole a sconfinargli oltre le labbra, come una dolce melodia.
Ho superato gli esami, sono stata promossa, sono maturata e... avrei avuto un cuginetto, o una cuginetta, tutto per me.
Una sensazione indicibile inizia ad albergare dentro di me per la prima volta, calda... gentile... che formicola.
Sento che potrei sciogliermi qui, fra l'abbraccio e i dreadlocks di Thalìa, e nella dolcezza degli occhi di Leonardo.
Ma quel torpore è destinato a durare poco, troncato di netto.
Le t-shirt di Alberto e Giulio spiccano il volo, atterrando a pochi metri da noi.
«Ora è il momento di andare a festeggiare, cazzo! È il momento di bere fino a stare male, voglio che il ricordo di quei libri assuma le forme di un sogno!» esclama graffiante Giulio, battendosi un pugno sul petto nudo, imperlato dai nastri del sole.
«Tutti al mare! E chi non viene è sfigato. Sfigato, sfigato, sfigato per sempre» gli dà corda Alberto sollevando le mani, ad afferrare il cielo, lasciandosi rimirare da Marta, svuotata di ogni parola e pensiero.
Tranne uno, trascritto a grafia elegante e leggibile nelle iridi: che il suo ragazzo è proprio uno scemo, e forse è proprio per quello che si è innamorata di lui.

Il rumore secco del portone che si chiude alle mie spalle e lo stropicciare zigrinoso delle punte dei capelli a scivolare sul raso del vestito sfregano l'aria, riecheggiando in un eco che si sarebbe propagato sino in fondo alle scale del palazzo.
Il pomello dorato appena mangiato dalla ruggine ancora stretto fra le mie dita, il clangore metallico degli anelli contro quell'effigie fredda e marmata.
Prima di uscire dall'appartamento non ho mancato di scoccare il bacino che riservo sempre alle guanciotte grinzose di Marsellus Wallace, il nostro rituale segreto, e il buffetto delicato che spetta all'esile ciuffo di piume di Vivaldi.
Ho salutato la mamma qualche ora fa, sapendo che avrebbe trascorso il resto di quel sabato in compagnia delle sue vecchie compagne di Università.
Nello zaino a comprimere contro le scapole, vicino alla borsetta appesa una catenella finissima, percepisco il peso irrisorio dei sandali con il tacco che mi sono rifiutata di allacciarmi ai piedi, categoricamente, non prima che avessi percorso la strada a separare me dal luogo in cui a breve sarei dovuta andare.
Una pulsazione febbrile mi coglie inaspettata al fior dei polsi, un guizzo elettrico, quell'eccitazione smodata che scava a fondo, inesorabile, quando sai che è arrivato il giorno che tanto stavi aspettando.
E nemmeno l'alito rovente a spirare fra le rampe delle scale, lambendo il corrimano e le inferriate delle finestre, riesce a far placare il battito violento del mio cuore, scagliato fra pareti di costole e sangue.
"Fa' caldo... diamine, se fa caldo...".
Ma è il 4 luglio, dopotutto. E Firenze, in estate, attrae a sé ogni sospiro di fuoco, ogni fascio di sole, sigillandolo nei comignoli dei palazzi, nelle persiane a battente, nei fregi raffinati e nel pizzo del ferro, nel cemento ruvido dei marciapiedi e nel marmo dei ponti. Divora tutto quel calore come fosse un drago in cerca del suo fuoco. E noi non siamo nient'altro che all'interno della sua gola.
«Matilde, buonasera. Qual buon vento».
Alzo lo sguardo, scostando una ciocca dietro l'orecchio. Il cerchietto dorato agganciato al lobo, pendulo nel vuoto, che pizzica nel suo tintinnio, scintillando a un sole baciato dal tramonto, filtrato dal vetro pulito della finestra ad affacciarsi sulla strada.
Le mie iridi studiano per un istante la figura solenne a stagliarsi in piedi dirimpetto a me, dura pochissimo prima che le mie labbra pitturate di malva si distendano placide in un sorriso che porta con sé il significato di tante parole.
«Cornelio... ciao» mormoro con un'amabilità che solo lui riesce a strapparmi ogni volta, senza volerlo, con naturalezza, «un vento rovente, direi».
Mi accorgo che la porta del suo appartamento è semi-aperta, talmente persa nei virgulti dei miei pensieri neanche avevo sentito il solito cigolio dei cardini, e nemmeno mi sono resa conto che la mia sagoma è inabissata nella penombra della sua mole.
L'ombra che si slancia al di là della mia, un flutto nero scaraventato nel vuoto. E io sommersa sino alla testa.
«Ti faccio i complimenti per il vestito, ti sta d'incanto. Non ti avevo mai vista con il lilla addosso» parla con calma, con quel timbro lento e mite che tanto lo contraddistingue, sfilandosi gli occhiali per strofinare le lenti in un fazzoletto sottile, d'un bianco immacolato.
Mossa da un istinto inesprimibile, abbasso le ciglia, a calamitare le pupille in quel tessuto di raso a cascarmi dolcemente nei contorni del mio incarnato. Increspature piccine a danzare, mosse dal minimo movimento.
Ho scelto quel vestitino non solo per il suo colore, il lilla, ma perché intessuta in quella sfumatura così delicata e fioca vi è una semplicità incantevole. Nelle sue spalline fini a sfiorarmi le scapole appena tinte di sole, nella morbidezza levigata affatto invadente con cui mi carezza la pelle.
E nonostante i sandali con il tacco all'interno dello zaino, che avrei indossato in un secondo momento, più consono, devo ammettere che nemmeno le Dr. Martens — gioie dei miei occhi — ci stanno poi così tanto male.
«Grazie davvero... piace tanto anche a me. Trovo che si accosti bene ai miei capelli», la mia risposta scivola nel silenzio del pianerottolo, fievole, resa in quel modo da una sbavatura di timidezza.
Mi fissa, Cornelio, da sotto le sopracciglia cineree, stinte dal tempo, «I tuoi capelli non più rosa... finalmente, dopo tantissimo tempo, riesco a vederli per come sono. Hai un castano bellissimo, mi ricorda tanto il bistro. Perché ti ostinavi a nasconderli sotto un colore che non era il tuo?».
«Perché...» comincio a pronunciare con le labbra che vibrano, pensierosa, stringendo la pelle del giacchetto fra le dita, «perché forse non mi sono mai piaciuta davvero per come ero. Mentivo quando dicevo che lo facevo perché volevo ostentare originalità, diversificarmi dagli altri, dal resto del mondo. Come se al resto del mondo un gesto come quello del tingersi i capelli di un colore strano fosse precluso», la mia voce fa una pausa celere, sostituita dal pizzicore di una risata, «ma ora ho capito una cosa. Non è qualcosa come colorarsi i capelli a renderti unico, ma è quello che sta qui dentro», e mi puntello un dito contro la fronte, «e qui... soprattutto qui», infine il petto, gabbia del cuore. «Non mi sono mai sentita più stravagante e alternativa di così».
«Oh, hai proprio ragione. Ci hai messo un po' a capirlo, eh?».
«Però l'ho capito, è questo l'importante, no?».
«È la cosa più importante» asserisce lui, piegando l'angolo del mento annuendo, «ma dimmi, dove vai di bello vestita tutta elegante?».
«Alla festa che hanno organizzato tutti i quinti del mio liceo. Festeggiamo la fine della maturità, all'agriturismo Il Casale delle querce. Abbiamo deciso di fare le cose per bene, in grande» chioso scostando il peso da una caviglia all'altra mentre gli restituisco la risposta alla sua domanda.
«Un posto davvero splendido, immerso nel verde. Un'ottima scelta, già già già. Però mi raccomando, Matilde, fai attenzione. La strada è piuttosto impervia e rovinata, guida con prudenza e vai piano» recita Cornelio con le palpebre ad assottigliarsi, lento, ma carico di apprensione per me.
«Quello sempre, tengo continuamente in considerazione i pericoli» dico in uno schiocco di denti, e un tono conforto, assieme a uno strano tremore a piccarmi le ginocchia, «adesso devo andare, davvero. Sono giusto appena in ritardo».
«Fai pure! Anche io devo andare. Ho una cena con un amico di vecchia data che non vedo da troppo tempo, e ho scoperto che è meglio farle in anticipo le cose prima di avere rimpianti. Abbiamo la stessa età, non siamo più dei giovincelli, noi...», la porta dell'appartamento di Cornelio si chiude sotto la pressione della sua mano, accompagnato dal clangore della chiave a girare nella toppa.
«...Oh, brutta cosa i rimpianti» convengo anche io, abbassando il piede sul primo gradino a scendere.
«Vero? Trovo che siano così passati di moda... non li vuole più nessuno, e stonano con tutto» mi dà corda in quella tranquillità delicata occupata soltanto da noi due, «e ora, mentre scendiamo, non facciamo troppo rumore oppure mademoiselle Rossini... be', lo sai».
Ma ho parlato troppo presto. E anche il signor Cornelio.
Perché quando entrambi, camminando l'unico affianco all'altro, discendendo le scale, ci avviciniamo al pianerottolo di mademoiselle Rossini, la donna dal naso lungo e arricciato di pettegolezzi, la incrociamo guarda caso nell'esatto momento, mentre lei pare uscire dalla sua porta.
Dicevo bene: naso più lungo e arricciato di così si muore!
Io e Cornelio Terrazzani ci scambiamo un'occhiata fugace, velocissima, quasi inavvertibile. E ci capiamo al volo.
«Buonasera, signora Rossini», è il nostro eco all'unisono. «Una bella serata per uscire a passeggiare a quest'ora».

Quando arriviamo all'agriturismo il cielo è una chiostra di colori attorno al sole. Calante, là in fondo, in una Firenze che par piccina vista da quassù, divorato dalle creste dei palazzi e dal crinale morbido delle colline.
Venature aranciate e pervinca graffiano quella distesa così celeste, matasse di nuvole a ingemmare come fosse una corona preziosa, e i loro contorni indorati, macchiati da un tramonto che spezza il fiato.
Laminato d'oro anche il verde ad affollare i dintorni, e gli orli del casale, mattone dopo mattone, che pare brillare a ogni battito di ciglia. Quei fili luccicanti incagliati nei torrioni d'edera a inerpicarsi verso l'alto, aggrappandosi a fessure attraverso la pietra.
Tutto scintilla, in quel momento, sotto le nostre ciglia incurvate, le iridi piene di stupore. Nell'istante in cui io, Marta, Costanza e Diego smontiamo dalla mia auto.
E un sorriso smagliante a cimare nei nostri visi.
Un profumo zuccherino e pungente spira fra il sentiero lastricato di piccoli ciottoli, quell'odore sferzante di libertà a mescolarsi fra le piante e le fronde degli alberi. È la fragranza dell'estate... una grazia maliarda, gremita di magia.
Come se cantasse.
L'estate che canta per noi, in uno strepito silente, ascoltabile solo se vogliamo sentire. Sentire davvero.
Mi sento pervadere da una contorsione di gioia appena voltiamo all'angolo di quella stradina deliziosa, orpellata di boccioli di begonie e cascate di gonfrena. Un ciliegio proprio lì, a svettare all'angolo in fondo al giardino.
Alla soglia del retro del casale, assieme a una melodia caotica a foderarmi le orecchie, vedo uno stormo di ragazzi tutti dai visi familiari. Che ballano, le labbra premute ai drink versati in bicchieri di cristallo, che ridono come se fosse la loro ultima notte sulla Terra, gambe e braccia che non stanno ferme, che non osano neppure; qualcuno ha osato a scivolare dentro un costume e a tuffarsi nella piscina.
Un tramaglio di spensieratezza si annoda in ognuno di loro, una felicità così tanto sospirata, affusolata nella sua forma più delicata.
Marta si ferma accanto a me, e solo in quel momento mi accorgo che le mie caviglie si sono arrestate rifiutandosi di proseguire, incerte e in equilibrio in quel tacco dieci.
Costanza e Diego fluttuano oltre di noi, superandoci, pronti a gettarsi in quel tafferuglio di vita.
«Sarà una serata indimenticabile questa» mormora Marta poggiando il lato della tempia sulla mia spalla, combaciando dolcemente, i ciuffi a cascarle serici, penduli sulla valle delle clavicole.
La morbidezza dei suoi capelli mi solletica piano, e io profilo appena il volto verso di lei, osservandola al di sotto del pizzo delle ciglia inghirlandate di nero.Un urlo esilarato spacca per pochissimo quella pace surreale.
«Ogni cosa è indimenticabile, purché sia con voi» chioso attraverso il guscio della mia convinzione, «con tutti voi», e il mio sguardo crolla in una maniera disgregante, avida, sull'effigie dorata come quel tramonto a danzare su di noi.
Stagliata laggiù, a risaltare in tutto quel grumo esaltato di persone, la spiga di grano in mezzo a un manto d'erba.
L'unica.
Lo guardo. Carezzo Leonardo con ogni mia delicatezza annodata alle iridi. Lo ammiro con cuore e anima, io incastrata nel mezzo, fra due metà inscindibili.
Marta mi dà un colpetto alla sommità della guancia, la bocca piena di allegria, «Allora che aspettiamo? Andiamo a divertirci come gli adolescenti che ben presto non saremo più. Mi concedi questo ballo, signora Tarantino?».
Mi scappa una risata appena sento chiamarmi in quel modo. «Molto onorata e molto volentieri, mia lady dei Sith. Ma prima vorrei salutare una persona... mi aspetti?».
«Non più di dieci minuti, altrimenti automaticamente mi riterrò offesa». E lo pronuncia come se davvero avesse paura, che potessi rifiutare un ballo con lei per Leonardo. Poi scivola da una parte, a suo agio con i suoi décolleté di qualche centimetro più alti dei miei.
«Be'...» cinguetto tutta pimpante dopo aver notato qualcosa a pungermi l'attenzione, «questi dieci minuti dovranno prolungarsi di un po' visto che qualcuno sembra ti stia cercando...».
Mi allontano quando scorgo Alberto avvicinarsi a noi, i ciuffi scuri a cascargli sulle sopracciglia folte, una corona d'ombre ad accendergli quelle iridi chiarissime. «Ciao, Alberto» lo saluto piegando il capo.
«Signore mie, bene arrivate» modula con un garbo fuori dalle righe, la camicia nera abbottonata sino alla gola, il colletto perfettamente stirato, e un frastaglio di cuore ad affiorare nei suoi occhi.Così somigliante al mio, mentre il mio sguardo s'intreccia alla forma di Leonardo.
«Ti sta aspettando», il tono di Alberto con cui si rivolge a me mi riscuote da quel torpore di sogni, e di scatto l'attenzione saetta su di lui.
«Allora vado» esalo con gratitudine, ed è come se il mio pigolo innocente e candido giungesse sino a Leonardo, a scuotergli l'udito e a farlo deconcentrare dalla sua conversazione con Riccardo Cherubini, a farlo voltare verso di me in un unico, elegante movimento.
Lo fisso senza un attimo di esitazione, stringendolo con il solo rimirarlo, provando ad avvolgerlo anche indirettamente in quella maniera.
I polmoni si gonfiano di adorazione, e aria che sento profumare di lui man mano che divoro la distanza fra di noi.
Lo fisso come se avesse attinto le fattezze di un dipinto; curve armoniose e spigoli proibiti, e la decisione dei colori, delle sfumature, delle sbavature che spetta a me soltanto.
Io sempre a incarnare quel frammento di ombre... a incastrarsi d'incanto con il suo, terso, e di chiarore a bramarlo quel buio... a desiderarlo così tanto.
E forse capisco. Capisco perché mi sono sempre ostinata a portare fra i ciuffi colori che non mi sono appartenuti e che mai lo avrebbero fatto. Capisco perché ora ho finalmente detto loro addio.
Perché l'ho trovato finalmente.
Ho trovato il mio colore.
«Ehi...» pronuncio dirimpetto a lui, piccola, a scomparire dentro i suoi contorni divini, «sono arrivata».
Leonardo inclina il viso, l'incarnato pallido quasi a brillare dove s'incontra con la bordura della camicia bianca. «Ti stavo aspettando».
Il battito del mio cuore sobilla dalle palpebre, e io mi ritrovo a socchiuderle, senza volerlo. A occhi chiusi, la mano di lui si fa spazio sullo spigolo della mandibola, e lo lascio fare.Mi lascio condurre, attirare sino a che non mi solleva appena, senza fatica, sino alle sue labbra.A convergere in uno schiocco, che dà vita a un torciglione nello stomaco, il gesto cristallizzato nella beatitudine più ancestrale.
Come se fosse sempre, e ancora, la prima volta.
Con l'altra mano a fasciarmi la vita, mi abbandono totalmente, bambola di pezza.
«Manca qualcuno...?» gli chiedo discostandomi di poco, con un'indolenza che quasi mi fa male.
«Mancano Diana e Camillo, ma loro sono partiti in vacanza, per cui non contano. Stiamo aspettando Giordano e Thalìa, a Midorin è andata l'auto in panne, sfortunatamente. Sono andati prenderla» mi spiega senza lasciarmi andare, dando una frettolosa occhiata all'orologio allacciato al polso, «anche se... è da un po' che sono partiti».
«Arriveranno» rispondo con una punta decisa di sicurezza a intridermi le labbra, mescolandosi al sapore di cui lui mi ha appena macchiata, «ma...» scandisco poi, osservandomi intorno, smaniosa di togliermi un dubbio a graffiarmi dietro le pupille, «non vedo Ludovico. Sai dov'è? È arrivato?».
Perché nelle espressioni rilassate, nei sorrisi sfolgoranti e in quel clangore di esuberanza, non riesco a riconoscere il suo cipiglio burbero, le sopracciglia a disegnargli quella fermezza con cui l'ho conosciuto, scivolandogli al centro preciso delle iridi.
No, lui non è qui. Non c'è.
«In realtà non l'ho visto arrivare. Hai ragione... non c'è. Sarà per strada», Leonardo sbatte le palpebre, realizzando che effettivamente torto non ce l'ho.
«Lo chiamo, così sento in che parte si trova. È una frana con l'orientamento» statuisco con il telefono già fra le dita, a comporre il suo numero.
E quella sensazione scomoda di preoccupazione viene immediatamente scacciata. Perché Ludovico risponde al quarto squillo, la voce di roccia, ruvida come granito purissimo.
"Sempre il solito, nemmeno Laira è riuscito a smussarlo più di quel tanto".
In poche parole, conciso come di regola, mi rassicura che è in viaggio, sta arrivando. Ha fatto tardi perché non voleva lasciare Celeste a casa da sola, è rimasto in attesa che sua madre tornasse dal lavoro.
«Per favore, vai piano» mi raccomando con il cellulare premuto all'orecchio, invischiando il mio respiro in un sospiro sollevato, «la strada è veramente brutta. Non ti dico che peripezie ho dovuto fare per evitare le buche. Per poco che Diego non vomitava».
«Andrò piano come una lumaca. E tranquilla, Celeste mi ha impostato la destinazione su Google Maps. Non mi perderò».
Riaggancio dopo averlo salutato, il cuore più leggero.
«Sta arrivando» pronuncio a Leonardo, che nemmeno per un secondo ha smesso di sondarmi, gli occhi affilatissimi, curiosi.
«...Che ti dicevo? Ultimamente sei sempre in ansia...» ringhia chinandosi su di me, inghiottendomi nella penombra a lanciarsi oltre la sua effigie come un'estensione, una proiezione opaca.
«Farei lo stesso anche per te, bamboccio» pigolo finendogli addosso, allacciandomi ancora al suo petto, i capelli a impigliarsi fra le ciglia.
«Per me potresti fare qualcosa di diverso...», e mi bacia di nuovo, saggiandomi come fossi il liquore più buono del pianeta, bramandone sempre di più. Incontentabile.
Ma la bellezza di quell'istante frammentario impallidisce sotto lo squillare maledetto del suo telefono. Sfiorendo come un fiore essiccato nel deserto. Scegliendo il momento più sbagliato per sbocciare.
«È Giordano» articola calamitando le ciglia verso il basso, «devo rispondere. Almeno si è degnato di farci sapere qualcosa».
«Fai pure. Tanto abbiamo tutta la notte», sorrido con voluttà amorevole, retrocedendo di un passo per concedergli un pizzico di libertà.
«Giordano, finalmente! Ma dove-...» gli sento dire.
E io resto lì, con i tendini pietrificati sotto la pelle, le caviglie immobili. In un intervallo di emozioni.
Una voce convulsa sporge dalla cornetta, che non riesco a decifrare, nemmeno a intuire minimamente.
Ma basta quello. Quel dettaglio che par insignificante a far calare la maschera beata e orpellata di felicità a Leonardo.
Gli casca dal viso in un suono silente, un rumore che avrebbe allacciato a sé uno stridio orribile se solo avesse la capacità di graffiare le orecchie.
È come se sull'espressione di lui apparisse fioco, lentamente, il disegno del mondo che crolla. Deturpandogli i lineamenti fini, delicati, che da sempre lo hanno elevato come una bellezza illegale e da ingabbiare gli sguardi degli altri.
Ma adesso... in quella bellezza, in quell'incanto... appare il disegno inestricabile del terrore.A sfigurarlo inesorabilmente, in un modo che deteriora i pensieri, un pugno in pieno viso. A istigare a voltarti, a non guardarlo mai più.
«...Leonardo?». La mia voce tracima da sola, attraversata da un timbro che quasi non mi riconosco.
Un rollio di voci in sottofondo, al di là della chiamata. E la faccia di Leonardo si spacca in mille pezzi.
La sua bocca si spezza nelle crepe di un tormento inesprimibile. Una lacrima a segargli la guancia, a strabordare dallo scrimolo.
E poi... è come se la realtà avesse deciso di oscurarsi, rovesciandosi d'improvviso. Un'eclissi inaspettata, insperata.
Il terreno si straccia sotto di me, me lo sento mancare sotto i piedi. L'equilibrio che si sfalda, le ossa che sembrano liquefarsi assieme alla pelle.
Tutti siamo fragili.
Delicati fogli di carta macchiati d'inchiostro. Fiori d'inverno colorati d'estate, come quella che vorremmo durasse in eterno. Insetti minuscoli, animi incompresi.
Ci crediamo forgiati nel marmo e nel fuoco... ci illudiamo. Ma siamo tutti fragili.
«...Un incidente...?».
Spesso ce lo dimentichiamo. Come un mazzo di chiavi di casa. Perché siamo fragili per quanto siamo pieni di disincanti, torri di sogni ad albergare in noi... a volte a impolverarsi, a volte per prendere forma.
«T... Th...alìa...? Cosa... c-cosa...».
Siamo. Dannatamente. Fragili.
Vetro a scontrarsi con l'alabastro.
Perché ce lo dimentichiamo così? Perché non riusciamo proprio a capire?
Noi nasciamo fragili, e moriremo fragili.
Siamo fragili, spesso ce lo dimentichiamo... e alcune persone ce lo ricordano meglio.
E non nel modo in cui vorremmo.
«Thalìa è... morta?». E così muore anche la voce di Leonardo.
L'estate ha smesso di cantare, ormai.
L'estate non canta più.
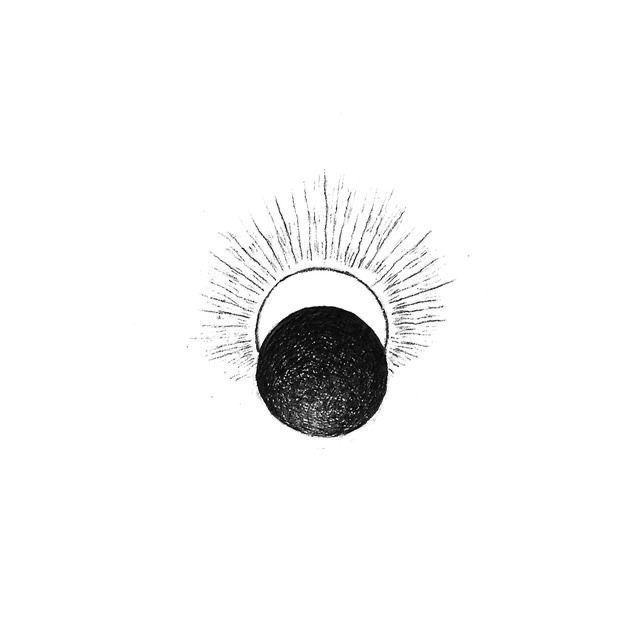
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top