60. A mani nude
"Quando compro un libro io leggo l'ultima pagina per prima, così se muoio prima di finire so quello che succede. Questo, amica mia, è il lato oscuro."
Harry, ti presento Sally (1989)

Il tintinnio stridulo della campanella m'invade i timpani, e in quella follia a durare un misero e gramo secondo — a inaugurare quel docile, familiare quarto d'ora di pace e assenza, leggerezza e tenue discostarsi dai libri e dalle materie scolastiche per un tempo definito — io divengo corda di violino.
Tesa, pronta a contorcermi su me stessa al primo tocco di dita, con i nervi a pizzicare al fulcro della nuca.
L'intervallo che si intrufola fra di noi, in ognuno di noi, come un nastro sottile, invisibile, d'ombra, maneggiato dal sole nascosto chissà dove. La familiarità con cui si torna a respirare senza fatica, in modo naturale, gettando l'ansia di verifiche e interrogazioni in un angolo buio... sperando poi di non ritrovarla più. Smarrita, perduta.
Quell'attimo di intermezzo che affiora nelle iridi con una mitezza dettata dalla fame o dal bisogno di fumare una sigaretta — o dall'esigenza di risolvere una faccenda in sospeso.
Quando mi rizzo in piedi, con il rumore della sedia a stridere alle mie spalle, mi accorgo che c'è un impeto esorbitante in ogni mia movenza. Nelle dita che incuneo contro il banco, imprimendo i polpastrelli sulla superficie fredda, nelle braccia rigide, tremolanti nei loro muscoli increspati e morsicati da una smania incontrollabile, sconosciuta, nelle ciocche dei capelli che si vanno a impigliare nelle ciglia.
E quel contrasto di pallido rosa sulla cornice nera delle mie pupille, avrebbe potuto essere anche qualcosa di bello da osservare. Avrebbe potuto... ma una collera arcana e violenta ne deturpa ogni colore, ogni frammento di beltà, ogni tratto grazioso.
...e lo sento.
...lo vedo.
Un sorriso mordace, pungente, a tagliarmi le labbra, un coltello che scintilla. Lo strano fremito che si percepisce prima di ponderare un pensiero sbagliato, nero, che fa gonfiare il petto e i polmoni di un ossigeno che non si dovrebbe respirare. Mai. Cancerogeno.
Un sussulto involontario che fa sollevare gli angoli della bocca in un ghigno da diavolo.
E io un pensiero sbagliato l'ho ponderato, dagli orli sporchi e corvini, le costole della gabbia toracica si sono mosse in un movimento a dilatarsi... il respiro di chi sa che, ormai, non si può più tornare indietro.
E Olivia, incarna lei quell'ossigeno nocivo, imbrattato di una poltiglia rivoltante, a infestare ogni mia estremità, scavando negli organi con una ferocia perversa. Uno squilibrio di unghie a graffiare.
Schiudo le labbra dopo essermi accorta di aver accumulato troppo fra lingua e palato, lasciando che un ansito deciso e tremulo al tempo stesso ne esca libero, e illeso.
«Mi raccomando, vi ricordo di portare l'autorizzazione firmata prima di versare la quota. Almeno ci facciamo un'idea di quanti siamo» la voce di Marco esorta ancora una volta i miei compagni di classe, ricordando loro che la gita si avvicina e che è meglio fare le cose per bene, senza lasciare nulla al caso.
Ma le sue parole si disperdono in un vocio sfocato e capriole di risate, depositandosi sui capelli di ogni ragazzo, come polvere. Quasi nessuno ad ascoltarlo.
«Va bene, Esposito, va bene. Contaci» lo punzecchia Tommaso Cavallacci attraverso una sigaretta incastrata fra i fastigi delle labbra.
«Vorrà dire che spunterò il tuo nome dalla lista. Tommaso Cavallacci sta a casa, ha deciso di non venire a Berlino con la sua classe» recita l'altro scarabocchiando con la penna, premendo la punta contro un foglio spiegazzato.
Sento le gambe vibrare, mosse da un'entità propria, estranea al mio cervello, e d'improvviso mi ritrovo a ignorare il minuscolo bisticcio fra Marco e T1, e persino il tentativo di Marta di parlare con me.
Tutto inutile.
Le mie orecchie è come fossero foderate dalla stoffa più pesante, timorose di un gelido inverno a nascere fra le vertebre.
Ogni cosa mi giunge smorzata, nebulosa, di una sbavatura che io stessa sono l'artefice. Di dita sporche, impiastrate di nero, sono le mie. Mie, e basta. Mie, di cui soltanto io posso scorgerne l'impronta cupa e che non andrà via tanto facilmente.
Le parole di Marta scorticano quell'attimo sospeso nell'aria, avviluppato in quei miseri quindici minuti d'intervallo... i suoi ciuffi d'argentite risaltano di meraviglia silente all'angolo delle mie iridi.
Qualsiasi cosa sta dicendo, io non l'ascolto.
Troppo presa da intimi pensieri contorti, il solito vorticare di riflessioni inquiete, che possiedono mani, e dita. Mani e dita che vanno a soppannare occhi e bocca e orecchie. Non vedo, non parlo, non sento.
I miei polpastrelli scivolano via dal banco, seguendo obbedienti il volere delle caviglie, ridestate da un torpore durato anche troppo a lungo.
«Mati, mi stai ascoltando?».
Piego lo spigolo del mento all'ingiù, lasciando che i miei occhi vengano adombrati dal disordine della mia frangia... ciocche brunite a grondare in uno sguardo affatto mite, disseminato di tutto meno che di sentimenti cedevoli, concilianti.
No, non ti sto ascoltando, Marta. Non voglio ascoltarti. Qualsiasi cosa tu voglia dirmi, io non starò a sentirla. Perché le vie di mezzo, io, non le conosco.
È sempre stato un qualcosa che ha danzato sulla punta delle mie dita, mendicando attenzione e desiderio di essere afferrato con delicatezza. Il saper arrendersi, la docilità dell'accondiscendenza, l'addomesticarsi — chinare il capo — nella metà delle due misure, arrestarsi lì su due piedi e poi respirare. Lasciarsi avvolgere da una lama di luce non troppo calda, non troppo fredda... tiepida, debole... come una delle prime mattine primaverili ancora troppo legate all'inverno.
Non fa per me, sento di non essere io.
Gli spiragli, le mezzelune, da cui guardare sono sempre stati troppo piccoli, troppo limitati per i miei occhi grandi, vividi e anelanti di curiosità.
Lo faccio di scatto.
Lasciando che le gambe si muovano da sole, sfuggendo al mio controllo.
Assumono nei loro lambelli di pelle l'inclinazione della fretta, e l'esigenza in ogni tendine arricciato.
Velocemente, esco dalla mia classe in un atteggiamento poco cortese, senza prestare attenzione a finire addosso a chiunque. Poco m'importa.
Non vi presto chissà quale accortezza quando m'imbottiglio con carica sfrontata nel corridoio del mio indirizzo — le dita strette a pugno chiuso, una morsa di nodi, pizzicano d'un bisogno doloroso. Bramano la collisione, con qualcosa, qualunque cosa... loro, che hanno fatto del dolore una via di fuga, una valvola di sfogo.
Assumo le fattezze di un animale selvatico mentre il mio camminare si tramuta in correre, le labbra increspate in un ghigno a tagliare, e le ciglia a mezz'asta, unite alle pupille scure... connubio del predatore pronto ad attaccare.
Non mi fermo quando volti conosciuti mi salutano con cenni delle mani o movimento del capo, non mi arresto dinanzi a sorrisi amichevoli, non potrei e non riuscirei mai.
Le pareti avorio del Caravaggio le vedo come le lastre di un labirinto, e le espressioni pacifiche e benevole degli studenti come dedali dai quali fuggire, mettere la distanza maggiore.
È l'aria che cricchia di spensieratezza e vacuità a stridere con la mia sagoma. E mi sento percossa a ogni metro a separarmi da lei, il ringhio che mi muore in gola, affaticato.
I capelli che compiono volteggi aggraziati, oltre le orecchie, gli stessi che pungono il cuore imbrigliato da ossa e organi.
I richiami di Marta, di Diego, di Ludovico ammassati dietro di me come steli spezzati, uno sopra l'altro, lasciati a morire.
Non ascolto.
Mi muovo celere, il fiato impigliato fra i denti, attenta a non incespicare; non ci faccio troppo caso quando vado a sbattere d'improvviso contro la spalla di una ragazza. Niente e nessuno può fermarmi.
Quando la caccia inizia, finisce solo quando il predatore ha fra gli artigli la sua preda, certo di poter mangiare.
I corridoi dell'istituto si riempiono di vita e di sorrisi vivaci, io l'unica macchia d'inchiostro a stonare.
Dove sei?
Dove ti nascondi?
Tu e i tuoi capelli di bronzo...
...Vieni fuori...
I gradini delle scale li percorro due a due, le mie gambe inarrestabili. La rabbia che monta e si aggrappa a ogni mia consapevolezza, vacillante... e poi... piano piano... a solidificarsi come pietra, di granito.
E poi... come uno spillo a bucare sulla pelle... mi colpisce in pieno viso la cognizione che, forse, devo cercare nell'angolo più remoto.
«Il Banco del Re» mormoro a me stessa, in uno schiocco di denti e di lingua, un lento sfregare di un'arcata contro l'altra. Rumore che graffia i timpani e scuote ogni emozione come burrasca invisibile.
Fletto le ginocchia, un'ultima volta, con un'avidità aberrante a fluire nei polsi. Quella smania di averla a un soffio di ciglia da me, di osservarla dall'alto della mia crudeltà minuscola e impotente. Implorante... come la prima volta che pianse vere lacrime amare senza alcun ritegno.
Corro verso la caffetteria, sicura. E mi chiedo... mordendomi il labbro soffice... chissà che faccia farà appena mi vedrà, appena saprà che io sono lì per lei, soltanto per lei.
E io lì la vedo.
Lì, fra occhiate rivestite di artefatta cortesia e maschere di cera imbrigliate di sorrisi — ghigni a grondare come miele —, si staglia l'effigie di Olivia, aggraziata, di quell'eleganza che ti fa stringere le palpebre se la ammiri per troppi secondi, quella bellezza che ti fa sentire sbagliata, in un modo così pungente e cupo, e che esorta, che alimenta pensieri proibiti e inadeguati. Dal contorno preciso e diritto della mandibola, agli spigoli delle ginocchia, appuntati su gambe definite, sottili. Le gambe di una bambolina.
I suoi capelli, fili bronzei intrecciati all'apice della nuca, si cuciono addosso alle mie pupille con una naturalezza quasi poetica.
Sembra una visione paradisiaca, lei, in quella cornice di estremo potere, la statua dei due angeli avviticchiati in un abbraccio a torreggiare sulla sua figura rilassata, e su Giulio, Camillo e Isabella. In mezzo a tutto quel turbinio di voci e visi colmi d'allegria, è come se si muovessero a rallentatore, ogni gesto studiato con accortezza e battiti di palpebre misurati.
Mi avvicino, dopo un attimo di esitazione. Quel baleno di titubanza che si scaglia in nome del buonsenso e di quel briciolo di saggezza a prevalere sulla stoltezza.
Ma dura poco.
...un istante stentato, gramo, e prosciugato di ogni logica e razionalità.
Vengo colta da un sentore di carità, la commiserazione che s'inerpica dappertutto quando ti ritrovi a osservare qualcuno che ci impietosisce, grazie a reminiscenze passate.
Olivia premuta contro il muro, la mia mano ad avvolgere il suo esile collo... Olivia a sondare il cellulare di Leonardo e a trovare il mio nome ovunque, dopo avergli riversato addosso tutto l'amore a ristagnare in lei come la più incresciosa acqua alterata, statica — quando un sentimento tagliente e violento come quello rimane intrappolato al pari di una bestia selvatica, si corre il rischio di venirne feriti, graffiati fino all'osso... si rischia di venirne mangiati.
Le farfalle a divorare lo stomaco che le ospita.
E Olivia distrutta, strappata a metà, perché lui ha scelto me, ha sempre scelto me... e Olivia che diviene fantasma di se stessa, accogliendo l'affetto sbagliato dalla persona sbagliata, Claudio.
E mentre la guardo, con le pupille piantate in quei capelli dannatamente impeccabili, realizzo che la mia carità non viene raccolta in nome della tenerezza, candida e placida... ma in nome di una commiserazione superiore, una sufficienza incorporea quanto affilata.
Olivia insieme a Leonardo, ieri pomeriggio. Lei che gli ha detto qualcosa destinato a rimanere segreto, lui che non mi ha ricercata la sera stessa.
E no, niente tenerezza ad albergare nel mio animo... la pietà immediatamente viene spazzata via.
Attraverso il corridoio della caffetteria, stavolta evitando le spallate e le gomitate che gli studenti non hanno timore di scoccare... e solo per far sì che arrivi prima il loro turno per comprare la merenda...
I capelli lunghi sino agli orli delle spalle dondolano aggraziati, non più lo sfarfallio dettato dell'impeto della corsa.
"Non mi vede", penso. "Lei ancora non mi vede". È voltata di schiena, la colonna vertebrale composta e ben eretta. Un mulinare di pensieri imperversa dentro di me, assieme alla fragranza carezzevole dei cornetti appena sfornati.
Solo uno riesco ad acchiappare: Questo è... questo è da parte di Matilde.
E lo faccio sempre con il respiro trattenuto di quella che ero, e di quella che abbandono all'infuori in caprioli di refoli, per andare avanti, di quella che sarò.
Questo è da parte mia.
La suola delle Converse che sdrucciola sulle mattonelle del pavimento, le palpebre spalancate e...
...e bruscamente vengo trattenuta per un polso.
Tranciando di netto quel tentativo di fare le cose a modo mio, con il fervore dettato dall'istinto, di quella rabbia sopita, dormiente, come a guardia di un tesoro prezioso.
Di colpo la visione di me e Olivia, l'una di fronte all'altra, a parlare si sfuma come sangue nero a tuffarsi nell'acqua.
In un gesto disperato, le mie dita si accartocciano sul braccio di chi mi sta frenando — e, in un certo senso, tagliando le ali — e sento. Il profilo delicato, la freddezza della pelle, lo spigolo dell'osso a guizzare oltre l'incarnato... quei dettagli piccini assumono una figura imponente, definita, nella mia fantasia, di astratti pensieri.
Zigomi conosciuti si disegnano, prendono vita, all'apice delle mie pupille, senza che io mi volti un singolo attimo a guardare.
«...n-no...» sussurro in un filo di voce, senza smettere di fissare le spalle gracili di Olivia e quel sorriso sicuro, celato, che le orpella le labbra.
Smarrita, vengo trascinata via, e non riesco a oppormi. Ogni mio tentativo, patetico puntellare i talloni contro il pavimento, viene smorzato con una semplicità aberrante e annichilente.
Un ghigno straziato e infelice mi deturpa quelle fattezze che dinanzi alla superficie di uno specchio mi hanno sempre fatto incurvare la piega della bocca all'insù, quegli occhi a mandorla ora me li sento pizzicare, di lacrime amare, di una sconfitta a campo aperto.
Insisto, e ritento, provando a scappare. Ma la presa è troppo forte... e io troppo tremula di sentimenti opachi e avversi.
«Io devo...», uno squittio convulso tracima oltre i miei denti, sfumandosi inesorabilmente, morendo come è nato.
Un senso di panico si aggrappa ai miei vestiti, strappandoli per poi attecchire sulla pelle, e tra le figure a passarci vicine io scorgo uno scintillio dorato, uno stridio avvilente con i colori di cui mi vesto e con le sfumature che accolgo, conciliante.
Sempre troppo scure.
E quando una consapevolezza calda e schietta si sedimenta fra le mie vertebre, tanto da farmi capire l'esito di quella fuga — rapimento — non calcolata, già è troppo tardi.
Perché la porta di un bagno serrata e chiusa a chiave divide me e ciò che avrei voluto farne di Olivia.
"Ho un déja vu".
Sento le guance bagnarsi di rivoli di ciò che impone la mia rabbia immota, sferzante negli artigli con cui si aggancia senza chiedere il permesso. Lacrime di fiele sono le mie, un pianto nervoso, e non ne rimarrei stupita se al posto del chiarore del cristallo ci fosse il tenebrore della pece a scavare sulla carne, di un crepuscolo lasciato in solitudine dalle stelle.
Il bagno dei maschi... questo è il bagno dei maschi. E ne sono intrappolata, qui dentro, insieme a lui. L'odore del sapone e dell'acqua del gabinetto a pungere attraverso le narici.
...e il suo profumo... sempre mordace, sempre ammaliante, di cui solo a Leonardo si può associare. Socchiudendo le palpebre a rivestire gli occhi, potrei riconoscerlo ovunque. Poiché ormai si è mescolato al mio, e ai miei sensi, con una semplicità così dolce e inaspettata...
Qualcosa si ritorce nella gabbia di ossa dove albergano i polmoni... un po' più al centro... ora più a sinistra... ecco... il cuore.
Quando sollevo le ciglia, un inghirlandarsi armonioso assieme al folto delle mie sopracciglia, lo vedo. Nello stupore dipinto al fior delle mie iridi scorgo il suo volto abbassato, le ciocche d'oro a plasmare una corona preziosa, dall'effigie morbida e setosa, a scivolare all'ingiù, alla ricerca disperata dei suoi occhi così mirifici. Le sue braccia tese oltre le mie tempie, e i palmi delle mani puntellati alla parete del cubicolo.
Mi sento ancora più intrappolata...
Lo ascolto ansimare, un refolo scosso frizza sino ai timpani, e non ci metto troppo a intuire che deve aver corso a perdifiato pur di cercarmi, pur di trovarmi.
Un silenzio gracile, ragnato, prospera come l'edera più rigogliosa fra i nostri petti. Ma poi Leonardo fa schioccare la lingua fra i denti, e lo spacca come vetro finissimo.
Ancora non mi guarda... non solleva il suo sguardo per piantarlo sul mio.
...e forse fa bene... potrei bucarlo, non ho due pupille ma le estremità acuminate di due spilli. E lo reprimo, quell'impulso di puntare le mani sul suo petto, chiuse a pugno, per poi colpire, colpire e colpire.
"Sei un dannato, Leonardo!".
Il suo viso si solleva appena, in una maniera irrisoria, sino a collimare attraverso la spianata del mio collo, scoperto, indifeso. La sommità del naso, soffice, a sfiorare in lenti ghirigori.
«Che stavi facendo?» mormora contro la mia gola, uno stuolo di denti scoperti dal labbro arricciato a sferzare l'incarnato, delicati. Un arrancare affaticato di parole.
Non riesco... a nascondere quella maledetta sensazione di beatitudine nell'averlo qui, così vicino... così per me.
«Mi hai portata nel bagno dei maschi?» chioso con il respiro spezzato, cercando di sfuggire come una gazzella impaurita a quel dolce richiamo, il suo odore a mescolarsi con il mio, ancora.
«Non cambiare discorso. Qui non ci romperà nessuno-...».
Un fievole rintocco di nocche alla porta rovina quel folle incanto, un rumore a riempire le orecchie e a strapparci via da un qualcosa che, forse, sarebbe precipitato... in un turbinio di tulle e maniche a sbuffo, le stesse che indossava Alice quando ha fatto troppo la curiosa.
...Come non detto...
«È occupato», un ringhio fa vibrare gli spigoli delle spalle di Leonardo.
«Leo...». Una voce familiare viene scoccata oltre quella porta a dividerci. «...so che sei impegnato. Ma ho finito le sigarette. Me ne daresti una?».
«Alberto... stai scherzando, spero» modula Leonardo con un timbro incredulo.
«Chiedilo a Marta. Un drum lei te lo farà volentieri» intervengo mossa da un istinto naturale, i capelli a solleticarmi le guance ancora irrorate, certa che Alberto Del Bianco non si sarebbe scandalizzato nel sapermi lì, insieme al suo migliore amico, nel bagno dei maschi. Ma gli occhi, perlomeno, si sono acquietati.
La mandibola di Leonardo si contrae deliziata sulla mia gola, provocando un ricciolo di brividi.
Una risatina oltre l'uscio risalta nitida.
«...non la trovo. È sparita. Nemmeno sulle scale anti-incendio con suoi amici l'ho trovata...» asserisce piano, il sentore di risata ancora deciso, per niente smorzato.
«Cerca meglio» mi ritrovo insistere, consapevole, in cuor mio, di farle un favore e al tempo stesso sicura che si sarebbe senz'altro incazzata per la mia lingua lunga.
V'è un attimo sottile di silenzio ad accartocciarsi come un foglio di carta stracciata, a spirare in quel piccolo perimetro di pareti bianche e porte pervinca. L'esitazione di qualcuno che sta decidendo cosa fare.
Finché un rumore di scarpe a picchiettare sul pavimento solletica l'aria, sino a svanire in lontananza, piano piano — come Alberto supera la soglia del bagno, le pupille di Leonardo, finalmente, si sollevano a collidere con le mie.
Rimango sospesa in quello sguardo il tempo d'un battito di ciglia, rapita dagli intrecci dorati a ornargli quegli occhi così eterei... puri... da angelo.
E per qualche misero, patetico, secondo, mi dimentico di quello che volevo — dovevo — compiere. Rivestita di tutto quel celeste, un misero, patetico secondo che mi costa caro.
Perché è proprio nell'azzurro infinito del cielo, dove picchi di cobalto e blu alice giocano a fare le capriole, che si scorgono brillare le nuvole, inchiostrate di nugoli di luce, dove i primi puntini di stelle fanno capolino di astratta timidezza.
Nell'intimità di quell'angolo solitario, finalmente Leonardo decide di parlare.
«Cosa volevi fare, Matilde?» chiede ancora, come se la prima volta non avessi prestato troppa attenzione. Ed è lì che mi ritrovo a sollevare le sopracciglia, un guizzo veloce e modulato da un lampo di vaga perplessità.
Le braccia a scivolare lungo i miei fianchi, inerti, immobili.
Un sorriso non troppo benevolo sboccia sulle mie labbra, «Volevo andare ad ammirare quel vostro Banco del Re del cazzo... secondo te? Volevo parlare con lei, mi sembra scontato!».
E nel pronunciarlo muovo la nuca in uno scatto — uno scandaglio di provocazione che non riesce a restare incastrato fra le pieghe dei miei gesti —, le ciocche a cascarmi per i profili delle guance; non faccio nulla per ricacciarle indietro.
«Non era una buona idea, le avresti staccato la testa a morsi...». Nella frase appena pronunciata v'intravedo una flebile accusa di avventatezza.
...stoltezza, forse.
«Non...» modello con la bocca a schioccare, per poi fermarmi, riflettendo che probabilmente sì, qualcosa di stupido e insensato l'avrei fatto, «...le avrei staccato la testa... a morsi. Avrei dialogato con lei con amabile e cortese crudeltà».
Mi aspetto che ne rimanga colpito, di vedere uno scintillio sorpreso a nascere sul lindore dei suoi occhi, ma Leonardo abbozza un sorriso raggrinzito, quasi disegnato a fatica. L'amarezza a rovinarne la linea spezzata.
«Volevi parlare con Olivia e non con me» dichiara, inclinando il capo.
Le mie palpebre divengono immobili, imitando i gomiti tesi, gelate delle sue stesse parole — quella a essere incredula sono io.
«Io volevo parlare con te... ieri» marco con urgenza quelle lettere contornate di un bisogno incalzante, il presentimento che entrambi siamo dalla parte della ragione. L'uno che non può prevalere sull'altra. «Oggi tempo scaduto».
Ma, forse, fra i due è Leonardo che ha la possibilità di dominare, colui che trattiene la spada dal lato dell'impugnatura. E ne percepisco il codolo acuminato della lama a imprimere sulla giugulare, appena deglutisco. Gli basta veramente poco.
«Quindi non vuoi sapere cosa mi ha detto...?» domanda affilato come quell'arma incorporea. Deciso e rapido, un taglio netto, da parte a parte. Lui vince.
Pianto le mie pupille per terra, arresa. Un sospiro che muore incagliato fra i denti. Sento un briciolo di razionalità cascare via, gocce a plasmare rivoli d'abbandono.
«Leonardo... io voglio sperare per te che non sia... che lei non...». Ora le mie labbra sono tirate, contratte di quel nocciolo che non riuscivo ad estirpare, turpe e sbagliato in ogni forma.
Non è facile.
I polsi vengono colti da spasmi incontrollati, coscienti di tutto quello che sciama nella mia mente, pensieri bui.
Leonardo è sempre in piedi, a torreggiare su di me, ma stavolta fa scivolare un braccio, le dita ad aprirsi come i petali di un fiore per poi coincidere con i tratti morbidi del mio mento. Stringendo con delicatezza e riportando i miei occhi ad allacciarsi con i suoi, cucendoli dei fili del cielo.
E lo fa senza fretta, come se avesse tutto il tempo del mondo e non quei poveri minuti di un intervallo qualunque. Lo fa con il movimento di chi sa tutto e può osare tutto.
«...cosa?» modula inumidendosi la bordura del labbro inferiore, infrangendo il suo respiro quieto sul mio volto.
Sento il sangue di quella ferita grondare con la crudeltà di una morte lenta, e dolorosa.
Mi accorgo solo dopo un istante che pare senza fine che ho innalzato il viso verso di lui, un girasole in cerca della luce. Mi rendo conto che la bellezza angelica e dannata di Leonardo non sfiorisce nemmeno in un bagno scolastico, contornato da scritte sui muri e incisioni da taglierino.
Poi un coraggio primitivo e una stizza soffocante mi afferrano per la gola, costringendomi a sputare ciò che penso davvero. «Lo sai! Come io so che quando stavate insieme non giravate i pollici... io non... io non potrei reggere se sapessi...», mi mordo il labbro, i denti che affondano senza il timore di lacerare, provare altro dolore, «Spostati. Leonardo, spostati. Mi sento troppo stretta qui dentro. Fammi uscire».
La vicinanza fra di noi trema, e il bisogno di andarmene e di scappare via da lì martella al centro del mio petto col fervore della tempesta. La tempesta che ero e che dovevo riversare su di Olivia.
E vorrei fosse facile... vorrei fosse facile quanto masticare qualcosa di morbido per poi mandarlo giù.
Le mie vertebre s'incurvano sotto il peso della mia decisione di andare via, e le ginocchia cigolano, senzienti.
«Lei non è quello che tu pensi», la voce di Leonardo interrompe il mio tentativo di fuga, spezzandolo di brutalità, e avviticchiandomi con il calore delle sue braccia, incastro da fiaba.
La mia schiena che s'imprime sul suo petto e i suoi polsi ricamati attorno alle mie spalle. L'ultima cosa che vedo sono i contorni confusi delle mie ciglia, lunghe e nere, incurvate di... sollievo. Poi stringo le palpebre in miriadi di pieghe, strette in una morsa di lacrime che probabilmente mai verranno fuori.
Mi basta una sola certezza.
Parole come chiodi a conficcarsi sulla carne.
«Olivia non è incinta».
E mi sento morire in quella speranza concreta, che sta prendendo vita. Leonardo continua, sussurrando attraverso le ciocche, sino all'orecchio, «Hai ragione... non ci siamo girati i pollici, ma sono stato più che attento».
Le mie mani, che fino a pochi attimi fa si stavano gettando nel vuoto, in un guizzo vanno ad aggrapparsi alla stoffa della sua maglietta, io che ruoto il busto per potermici tuffare in quel porto sicuro ampio del suo costato.
Il suo profumo che penetra di infinita dolcezza negli orli delle narici.
Artiglio il tessuto con disperazione, graffiando con quelle unghie rovinate dal mio mordicchiare nervoso, dipinte di smalto e mille colori. Una sensazione di liberazione che gronda di polpastrello in polpastrello.
«...e non potevi dirmelo ieri sera? Non ti rendi conto... non hai idea di come sono stata. Se non fosse stato per Giovanni sarei crollata» ringhio abbacchiata contro la stoffa pesante. Mi quieto appena quando le sue braccia tornano ad ammantarmi.
Il suo corpo a sovrastarmi, sempre e comunque.
«Dopo ho parlato un po' con mia madre, sai... dopo la visita di Olivia voleva qualche spiegazione, e giustamente. E poi ho pensato che sarebbe stato meglio dirtelo di persona».
«Neanche un fottuto di messaggio, per dirmi che dovevo stare tranquilla e che mi avresti raccontato tutto a scuola...» insisto difendendo il mio punto di vista.
«Mi dispiace. Molti lo pensano di me, ma io non sono perfetto» mormora piano. C'è della contrizione a tingere quella frase, un dispiacere palpabile. Una colpa che sa che mai potrà porvi rimedio.
"Ma, Leo... tu che covi in te l'intelligenza e la sapienza, tu che sei erudito... dovresti saperlo. La perfezione non è mai esistita, siamo noi che la imprimiamo a forza nelle persone, vedendola nei difetti più in rilievo. Le cicatrici hanno questa peculiarità, si adattano solo agli occhi di pochi eletti".
«Posso sapere che cazzo voleva quella, ancora, da te?».
«Voleva convincere Lucrezia che tu non sei quella giusta per me. Credeva che lei sarebbe stata dalla sua parte, ma... mia madre è una persona molto... particolare».
«...e?» insisto. Il cuore ad arrancare in gola, e ad affiorare nelle iridi. Tutto il mio cuore a grondare indifeso attraverso il buio dei miei occhi.
«...e le ha detto che se ha avuto la mia attenzione una ragazza dai capelli rosa e dalle idee rivoluzionarie, c'è ben poco che lei possa fare. Che ha le mani legate, che lei non intende intromettersi nelle mie decisioni, soprattutto quelle sentimentali. E che gradirebbe essere avvertita prima di ricevere visite in quel modo» racconta Leonardo dando conforto a ogni mio dubbio, la consolazione dopo tutto quel dolore a imperversare come schegge di ghiaccio.
«Fammi indovinare... mi ha dipinta come una drogata fattona nullafacente...».
«E anche ninfomane, fra le righe, sì... però lo ha fatto intuire abbastanza bene. Ma... Lucrezia conosce bene i tuoi genitori e poi le ho raccontato come realmente sei, una volta che Olivia se n'è andata, e della facilità con cui sei entrata in me... dapprima con una violenza inaspettata per poi sedimentarti nel modo più dolce e silenzioso. Io dovevo solo accettarti», Leonardo fa passare le dita sui fili sottili delle mie ciocche, districando piano piano.
«Io... tu... ciò non cambia che ho una voglia incredibile di strangolarti» inciampo sulle mie stesse parole, la lingua a incastrarsi fra i denti, «non hai idea di come mi sono sentita tutto ieri sera...».
«Ma mi hai ripagato con la stessa moneta, ignorandomi volutamente stamattina. Credi che ne sia stato contento? Vedere Marta venirmi incontro a scuotere la testa, il segno che non avevi accettato di volermi vedere» modula con voce cheta, «testarda».
«Insensibile...» replico decisa a non dargliela vinta.
«...crudele», e nemmeno lui sembra voler cedere.
«Stronzo».
«Mh-hm... sono il più stronzo...» chiosa Leonardo in una sorta di ridicolo contentino, la sommità dell'indice a percorrere la linea della mandibola soffermandosi sulla punta delicata delle mie labbra, «io dico che ci somigliamo».
E quando sto per formulare qualcosa con cui ribattere, ancora un rintocco di nocche alla porta ci provoca un sussulto, lo stridio di qualcosa che s'interrompe... di nuovo. E stavolta in maniera poco cortese.
Leonardo imprime i polpastrelli dell'altra mano contro le palpebre increspate, «È occupato, dannazione... è occupato! Il Caravaggio è un istituto immenso, vi siete innamorati di questo bagno oggi?».
«Fammi entrare, devo pisciare».
Ma che...
«Scusa...? Cos'è che hai detto?», Leonardo finge di non aver sentito, ma io ho capito benissimo.
«Cos'è che ti risulta complicato da capire? Il fatto che debba entrare o il fatto che debba-...».
«Sì, ho capito cosa vuoi fare!» interrompe quella voce senza gentilezza alcuna.
«Ludovico... ma che ci fai qui dentro...?» proferisco con le pupille sollevate al cielo.
«Devo andare in bagno. È urgente e voi mi state bloccando il passaggio. Lui mi sta bloccando il passaggio», il ringhiare di Ludovico arriva dritto ai miei timpani con l'intensità di spilli appuntiti.
E quando Leonardo fa scattare la serratura, aprendo la porta, finalmente la figura adombrata e possente di Ludovico si staglia dinanzi le nostre pupille. I riccioli a grondargli come sbuffi d'inchiostro attorno all'ovale del viso. Occhi di pece, e l'orecchino a cerchio che brilla nella penombra del bagno, a inghiottirlo e ad accoglierlo come fossero un tutt'uno.
«Questi sono i bagni del Classico. Lo sai, sì?» pronuncia Leonardo a un soffio dal suo naso, per nulla intimorito, lui, occhi di ghiaccio.
«E quindi? Mi scappa uguale e, per quanto mi riguarda, il cesso c'è anche qui», il tumulto agitato e per niente amichevole si riversa nel timbro di Ludovico.
Gli angoli delle labbra di Leonardo si piegano appena di un sorriso abbozzato, salace. «Prego», lo invita a entrare con il movimento della mano.
«Ora non mi scappa più», Ludovico si stringe nelle spalle, un gesto affrettato quanto colmo della sua irriverente indifferenza. «Vieni a fumare, Matilde?».
«Cos'è che volevi fare, tu?» mi domanda Leonardo, tagliente nella sua cesellata tranquillità, «Volevi dialogare con Olivia con amabile e cortese crudeltà? E avresti da ridire se io volessi fare lo stesso con lui?».
«Non... non è proprio il caso», stringo gli orli della bocca cercando di non mettermi a ridere, «vieni a fumare con noi? ...con me?» chiedo titubante, nonostante il desiderio che lui risponda di sì a dipanarsi in fili d'alabastro.
«L'ho chiesto a te, non a lui» la voce di Ludovico si riduce in un sibilo, nel modo cupo e intenso di cui si è orpellato lo sguardo.
Poi Leonardo distoglie l'attenzione dal mio profilo, impuntandola su quello del mio amico. Inclina percettibilmente lo spigolo della mandibola, la sensazione che sta riflettendo.
Infine un ghigno fulgido, una mezzaluna di coltello, gli scinde le pieghe della labbra, resecando l'armonia di quei lineamenti silenti. «Perché no. Sì... vengo».
E in quell'espressione io vi scorgo la vera intenzione, la reale finalità: tutto pur di dare fastidio a lui.

Marta.
Una lama di luce taglia in due l'effigie del mio viso, un filo preciso, mosso da una volontà di appartenenza, i miei lineamenti ad anelare una rifinitura così impercettibile, e così tangibile — lo smeraldo dei miei occhi imprigionato su quelle ciglia di trame brunite, ingentilito da quelle cordicelle terse e pulite.
Mi beo di quel tepore inaspettato, macchiata del sapore della sigaretta e del veloce galoppare di istanti troppo brevi.
Osservo tutto, osservo niente.
E mi ritrovo così, sola con me stessa e nugoli di fumo a compiere capriole su capriole, volando via. Le gambe distese, avvolte dalle calze costellate di miriadi di ghiande — un regalo di Emma —, incuneate l'una sull'altra, e la punta degli stivali a danzare in una muta melodia, il ritmo del silenzio.
Avvolta dai filacci del sole, mi sento tanto cristallo di ghiaccio... a sciogliersi mentre splende.
Per una volta, dopo un tempo che non riesco più a trattenere fra le dita, io mi sento serena. Di una pace intrinseca e inesplicabile. Nel mio occhieggiare senza una meta precisa vi regna la tranquillità, i muscoli delle braccia, inerti, non li sento tesi.
Lì, in quella nicchia fuori, all'esterno, raggomitolata fra gambe e pensieri, scaccio ogni cattivo presentimento allacciato al pomeriggio precedente. Trascorso con Ilda.
Sembra quasi che non sia successo davvero, che tutto sia appartenuto a un sogno lontano, caro amico delle volute della notte, avverato sotto la coltre di due palpebre chiuse. E invece, quando con perseveranza vado a pizzicarmi la pelle all'altezza del profilo del polso, capisco che mi sbaglio.
Capisco che ero ben sveglia, ben attenta, ben accorta... il mio non aver bevuto nemmeno una goccia di tè ne è la prova più schiacciante.
Inghiottisco una sensazione di incredulità silente assieme al respiro, e poi l'ombra di un sorriso ad affiorare. Senza volerlo, vado a sfiorarmi la morbidezza delle labbra, tracciandone il contorno, delicata... e, come ieri, modulo l'inaspettato, «A...lberto...».
Lentamente. Senza fretta.
Saggiandone ogni lettera, scoprendo che modellato attraverso l'arcata dei miei denti e lo schiocco della mia lingua ne acquisisce un suono aggraziato, docile... pieno di un fascino nascosto che soltanto io sono in grado di comprendere.
Come se stesse d'incanto solo se intrappolato nella mia voce.
...eppure... è un nome come un altro.
Ma allora perché?
La mia incapacità di cognizione dell'ovvio è aberrante...
Perché mi sento così leggera solo perché un nome viene pronunciato dalla mia bocca?
Forse, nei miei diciotto anni stentati, sono ancora troppo giovane, troppo in erba, per poterlo capire... troppo riempita di esperienze che non ne valgono nemmeno una... troppo sazia di un sapore che, nel tempo, ho scoperto essere amaro.
Ho divorato ogni sensazione credendola la più dolce del pianeta, e adesso nel palato non ne resta che un cattivo mordente.
Per questo mi costringo a masticare piano, senza aver paura di andare troppo lenta, intorpidita, l'indolenza fragile di una lumachina... non posso rischiare di rimanere intossicata. Troppo amaro, troppo dolce... fa lo stesso. Calcare su qualcosa fino all'esasperazione non è mai un bene, non fa mai bene.
Quando spingo il filtro del drum verso le labbra, qualcosa all'angolo dei miei occhi vibra di un movimento distinto. Lo scricchiolare di suole contro il pavimento mi punge all'orecchio, costringendomi a ruotare il busto e guardare in quell'esatto punto, curiosa. La porta anti-incendio che cigola fino a sigillarsi su se stessa.
Restando voltata, non avrei potuto notare le sue dita affusolate sporgere dal contorno asettico dell'imposta, a incagliarsi sulla maniglia tirata all'insù, percettibilmente.
Due pupille vivide risaltano in quei coaguli di luce, gli stessi con cui mi stavo dilettando in solitudine, credendoli, per un momento, soltanto miei. Lì per me.
Due gemme che brillano di una sfumatura limpida, incagliati di silenzio cortese sulla mia sagoma seduta a ginocchia distese per terra. Ciocche argentee s'impigliano delicate fra le ciglia pastello, tenui — il soffio del vento a innestarsi nei miei capelli e a modellare tumulto di spirali.
E così, accettando senza timore una compagnia che non avevo premeditato, ben consapevole che un lasso di tempo come l'intervallo non è infinito, insieme a boccoli di fumo butto all'infuori un timido «Ciao».
Mi stringo appena nelle spalle, voltandomi di nuovo.
«Ciao... ti disturbo?».
Abbasso il mento, schiudendo appena la bordura delle labbra. «No, affatto. Siediti pure. Tecnicamente nemmeno io dovrei essere qui, è vietato stare in questo angolo del Caravaggio» affermo rizzando il collo, beandomi di quel minuscolo brandello di sole.
Aumento la morsa dell'intreccio delle mie ginocchia, premute in un nodo su se stesse, tentando di soffocare quel sentore di essere un'intrusa a mordicchiarmi le gote.
«Intendi... non mi offendo se mi dicessi che ti do fastidio, con la mia presenza. Preferisco una solida verità che una sciocca menzogna», e la presenza segue il mio suggerimento, sedendosi accanto a me in un movimento lieve dell'aria, «è solo che oggi non mi andava... di stare in mezzo alle persone».
«Non ti preoccupare, non mi dài fastidio... te l'assicuro, Thalìa. Non avrei problemi a dirtelo, penso tu lo sappia bene». E un roveto di dreadlocks distesi e dolcemente annodati come giunchi riempiono i miei occhi con una semplicità affatto invadente.
Occhiaie simili a lividi risaltano nella pelle scura a contornare gli scrimoli delle pupille, ogni traccia di dinamismo e spirito d'esuberanza sembrano svaniti dai gesti che Thalìa era solita a esercitare.
Ma il profumo... il suo profumo così dolce e pungente è sempre con lei, a carezzare pensieri e sguardi.
Un intreccio di gambe dritte, magre, e dalla parvenza infinita, avvolte da un jeans a sigaretta costellato di strappi, va ad accostarsi alle mie, un po' più brevi.
«Ma io lo so bene, certo. Dopo quello che è accaduto con Diego capisco alla perfezione il tuo punto di vista e la tua avversione nata per me» recita Thalìa dopo essersi accesa una Marlboro, «sto cercando di smettere di fumare, sai? Ci stavo riuscendo ma... dopo quello che ho visto l'altra mattina... Laira... mi sento aggrovigliata, e costantemente tesa. Accumulare nicotina mi aiuta».
In un guizzo di labbra mi ritrovo a sorridere, guardando oltre di me, oltre la chiostra di metallo a fungere da parapetto.
«Hai un modo di guardare le cose veramente acuto» sussurro senza vergogna, neanche l'esitazione più sottile ad arrestarmi le parole, consapevole che con Thalìa si può davvero parlare di tutto senza esser giudicati, «...ma... se prima criticavo il tuo atteggiamento, di restare sua amica nonostante ciò che lui prova per te, be'... adesso non sono più nella posizione di farlo. Mi sento di capirti, in qualche modo».
«Mi sopravvaluti, Marta. Le cose palesi, evidenti agli occhi di tutti, si notato bene. Soprattutto quando non cerchi nemmeno di nasconderle» ammette Thalìa increspando la bocca, sorridendo, «e comunque, mi sento di essere davvero un'ipocrita dopo aver assistito a... quella povera ragazzina disperarsi per un interesse non corrisposto. Con quale diritto, io, continuavo a stare vicina a Diego? Con quale pretesto?».
«Nessun diritto, nessun pretesto. È semplicemente nella tua natura, elevare tutti allo stesso modo, senza distinzioni. L'amicizia non la confondi con l'amore, è ovvio», e stringo fra le dita quel drum quasi finito, consumato d'aria. «Io ho fatto qualcosa del genere e quindi... wow... chi è senza peccato scagli la prima pietra!».
Sporgo la testa oltre lo spigolo della mia spalla, osservando Thalìa di sottecchi, e noto che ha le iridi rivolte all'ingiù, a collidere con le dita aperte a ventaglio, a rimirare le costellazioni di anelli a ornargli la pelle morbida.
Un mutamento percettibile nei suoi zigomi.
Un sorriso di malinconia.
«Chi è senza peccato scagli la prima pietra» ripete lei, a bassa voce.
E delle sue parole mi rimane un eco a riecheggiare fra le pareti del cervello, cospargendomi della cenere del dubbio, come ad aver rapito il colore artefatto dei miei capelli senza chiedermi il permesso.
«...però... si vive una volta sola, no?» azzardo, titubante.
Non avevo mai parlato così con Thalìa a quattrocchi e a mani nude. Come il cuore... con la differenza che quello lo trattengo al sicuro, stando attenta, prestandogli cura.
«...si vive una volta sola» acconsente Thalìa, muovendo la testa in un gesto d'assenso, «io amo Italo» pronuncia poi, con una sicurezza decisa a impiastrarle quei vocaboli, «e mi dispiace per Diego e per Laira... in un modo che non so nemmeno spiegarmi, a contemplarlo come possibile, io ho fatto soffrire entrambi».
«Certo che lo ami. Le persone come te lo fanno in silenzio, senza doverlo urlare per forza al mondo intero... siamo stati tutti noi degli sciocchi a non averlo capito», un sospiro mi si accartoccia nel palato. «E Diego... Diego sopravvivrà, lo ha sempre fatto. In un modo o nell'altro lo facciamo tutti, non ti pare? Sopravvivere...».
«Sopravvivere per vivere. Sì, penso che abbia senso» conviene Thalìa steccando la sigaretta in uno schiocco, «solo che non tutti troviamo "utile" quel sopravvivere. Ci serve qualcuno a dargli un senso per noi».
«In quel caso si è davvero fortunati» ridacchio imprimendo i polpastrelli contro la fronte, consapevole verso a chi è scoccata quell'affermazione.
«Io voglio bene a Diego» asserisce lei d'improvviso, sollevando il mento verso il cielo, la linea della mandibola che si contrae sotto l'incarnato, precisa, «come un grande amico. Pensi che sia egoista a volermelo tenere vicino così?».
La luce si mischia di ombre, uno sbuffo di nuvole a ottenebrare il sole. E i nostri visi pare quasi che s'incupiscono.
Increspo la fronte, le impronte delle dita a pigiare appena, in un movimento involontario vado a scostarmi i ciuffi dei capelli dietro gli orli delle orecchie. A quel punto mi volto verso di lei, le sopracciglia sollevate.
I minuti che sgocciolano via, lasciando spazio alla terza ora di lezione. Matematica con il professor Astri — lasciate ogni speranza, o voi ch'entrate.
«Io penso che non si è mai egoisti abbastanza».

Thalìa, non appena la campanella di fine intervallo aveva iniziato a trillare, mi ha chiesto con infinito garbo se oggi volessi studiare insieme a lei, sapendo che i miei genitori avrebbero lavorato tutto il pomeriggio, lasciandomi sola.
Ho declinato.
Perché lei non sa che nella solitudine, in mezzo a mille colori impressi nelle mie amabili tele, all'odore del caffè a mischiarsi con un principio di sonno e il sapore del dentifricio, costellata dal verde fiorire, rigoglioso, delle mie piantine, io mi ci perdo di incantevole volontà e familiarità.
Dalla sfumatura trifoglio dei germogli teneri, al vermiglio violento delle nuance sfuggite al mio pennello.
E il cinabro delle mie iridi, incuneate alla pagina piena di sbavature di penna, le mie dita a completare gli esercizi di matematica per la settimana prossima.
Gli occhi cozzano sull'orlo della tazzina sporca del mio rossetto, un alone di caffè a scivolare sul profilo d'impeccabile ceramica, ma poi, rapidi, ritornano in quegli schemi razionali, confini sicuri, dettati dai numeri.
Il piccolo orologio appostato all'angolo della scrivania, accerchiato da spuntoni di candele consumate — una infilata sul collo di una bottiglia di Becks —, segna le tre passate, e il suo lento ticchettio rimbomba delicato e affievolito sostenendo il palpitare ovattato del mio cuore.
Un rumore che tiene compagnia, che rilassa.
Lì, con una gamba impilata sull'altra — la prima a penzoloni, dondolando cheta, imperturbabile nella sua scandita armonia, la seconda immobile in una piega insolita —, io resto china sui libri in una maniera così pulita e rilassata che nemmeno sento di essere sola davvero.
Il viso ad alzarsi ogni tanto, a guardarmi intorno, pizzicata di una curiosità inintelligibile, smorzata sul nascere non appena gli occhi si scontrano con le pareti tinte di un colore leggero.
La semplicità dell'intimità, che non tutti sanno cogliere.
...che non sanno sopportare, piuttosto.
Quando si è soli... i pensieri fanno rumore. Sbattono dappertutto come farfalle spaventate.
Ma non per me, io che nel silenzio ho ritrovato me stessa più di quando stavo in compagnia di altre persone.
E a mani nude io mi tolgo il cuore dal petto, svestito di ogni metallo a tagliare e di ogni acciaio a difendere.
Finalmente sono denudata.
E sussulto nelle ossa quando il campanello trilla per un tempo che pare infinito. Il rumore acuto, il ronzare indistinto che indica quanto possa essere antico, rimbalza in ogni angolo sino al mio udito, affinato.
Guardo ancora l'orologio, smarrita. Le tre e sedici.
Chi può essere mai alle tre e sedici?
Poi l'illuminazione mi punge le corde della memoria: la mamma mi ha lasciato un biglietto dicendomi che sarebbe passato il corriere con un pacco.
Mi rizzo in piedi affondando la testa nelle spalle, balzando dalla sedia come un uccellino tutto allegro.
L'estremità del citofono a premere contro il mio lobo, oltre il soffice dei capelli. «Chi è?» modulo di una tinta di semplicità, naturalezza a imbrigliare la mia voce.
Conto a mente i secondi che trascorrono prima che una voce prorompe dall'altra, a così poca distanza.
Uno.
Due.
Tre.
Quattro.
Cinque.
...sei.
«Sono io. Mi apriresti?».
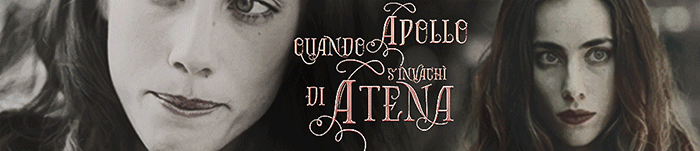
Io so, con una certezza a scavare trionfi di fosse e di buche fra le ossa del petto, che la vita a volte riserva sorprese inaspettate.
Spesso crudeli, acri nel loro avanzare con insistenza e tinte di quell'inaspettato sgradevole, raramente ad assumere le forme gentili e graziose di quei libri a cui sono tanto devota, o all'imponenza dei quadri sepolti nei musei a strapparmi il respiro con dolce violenza.
L'abitudine, il tarlo, la facciamo per le cose brutte, così assuefatti ad aspettarci il peggio della realtà che quando ci passano vicino, quasi a sfiorarci, le piccole gioie, felicità piccine come insetti, non ce ne accorgiamo. Le ignoriamo, la maggior parte delle volte.
...e non ci pentiamo, affatto, di non averle afferrate in tempo, sapendo, dentro di noi, di non meritarcele davvero.
Ma... c'è un momento in cui finalmente succede, che le palpebre si sollevano e vedono quello che devono vedere. Senza filtri, senza uno stuolo di mura ad allontanare.
«Cosa ci fai qui?» domando lentamente, l'ossigeno a gonfiarmi i polmoni di una felicità così grande, a comprimere come se quello spazio fosse troppo stretto.
...e li comprendo... poiché nelle mie pupille sto tentando di smorzare ogni sfumatura che lo faccia intuire.
Stringo le ginocchia contro il petto quando i suoi occhi si soffermano sui miei, attenti, vivi di ogni parola. Il timore che il minimo movimento possa apparire incerto... spaurito, quando altro non è che beatitudine in tremolii.
La metà della mia stanza a dividerci — io seduta sopra la trapunta del letto, lui seduto dove poco fa stavo svolgendo i compiti.
Schiocca le labbra compatte, senza alcun segno di screpolatura dettata dai rigori dell'inverno, prima di accontentare la mia curiosità.
«È molto semplice... ti avevo sentita parlare con la Obi Malek, all'intervallo, e quando ho capito che saresti stata sola per tutto il pomeriggio ho pensato che sarebbe stato... carino venire da te e farti compagnia. Magari studiare insieme. Sai, gli esercizi di fisica non si svolgono da soli».
Carino... sarebbe stato carino...
Quei tre vocaboli si conficcano nel mio cranio con un'intensità tale da farmi stringere le palpebre.
Quando si tratta di lui non è — mai — solo qualcosa di carino!
«...e hai pensato bene di non avvertirmi per nulla. Nessuna chiamata, nessun messaggio» suggerisco mentre lo guardo attraverso lo strato sottile delle calze a rivestire le ossa delle ginocchia. Sempre a mani nude, il cuore un po' più vestito.
Alberto si staglia nei suoi ciuffi scurissimi a ornargli il volto da angelo ormai privato delle sue ali, tagliate di netto, grondanti di illusioni appassite e sangue rappreso. E in quegli occhi gelidi dove, per chi sa guardare, si cela la fiamma più rovente.
Le dita intrecciate, composte, posate sullo stomaco.
«Altrimenti che gusto c'era?» recita con dell'insolenza in pillole al fior dei denti, scintillanti, studiandomi attraverso le punte delle ciglia estese.
Esito appena, mal riuscendo a nascondere una punta di brividi in ogni dove, l'eccitazione scatenata da un timbro rauco, profondo, che appartiene a filigrane di buio.
Mi si arriccia la pelle del naso involontaria.
«Ma è chiaro... sono proprio una sciocca sprovveduta, eh?», mi fingo offesa, roteando le pupille.
Poi Alberto si mette a esaminare la mia camera con l'interesse di chi mette piede per la prima volta in un posto nuovo.
«E così questa è la tua stanza...» pronuncia tranquillo, affatto teso come lo sono io.
«Così sembra» gli vado dietro.
«È carina...». Carina... ancora... con quella voce...
«Faccio del mio meglio», il controllo che vacilla, appeso a un filo di ragno.
«...ci sono molte piante. Tutte verdi e... fiorenti».
«Non te l'aspettavi da colei che sempre ha proclamato il ghiaccio e la neve come unico Credo, eh? Non ti piacciono?».
«Sono... rigogliose» mi fa notare Alberto, le palpebre assottigliate, predatrici, ora è ritornato a mordermi con gli occhi, «traboccanti di vita. Da sempre a me hanno attratto le cose decadenti. Parole immiti, dalle incurvature ferine in punta di labbra, dove sentimenti mordaci puntellavano delle loro spine. Scheletri di fiori appassiti, annichiliti dallo scorrere crudele del tempo e della brutalità con cui la natura si scagliava sui loro petali».
Alberto si erge in piedi, muovendo un passo stentato, tremolane di frenesia, verso di me. Poi ritorna a parlare, e io ascolto, rapita, soggiogata, ridicola perdente.
«Sfioriti, a grondare l'atroce grazia delle gioie che furono, consumate fino all'osso, che mai più saranno. Lacrime elevate a cristalli, memorie perdute soffiate lì dentro. Persone dal contorno nero, dove più c'era quel nero, più sentivo montare selvaggio il bisogno disperato di passarvici sopra le dita, sbavature a orlare come ricami tetri».
E lui si avvicina, ancora un altro passo. Ho smesso di respirare, i refoli impigliati alle pareti della gola.
«Le cose calanti, come il sole a tramontare, si sono aggrappate addosso a me attecchendo con una delicatezza straziante e inaspettata. Lacerando, di sangue, sdrucendo, di amore. Quella rovina lenta — e incalzante nel suo essere, nel suo dipanarsi con il silenzio della ragnatela — a trattenermi per i confini del polso, incantevole. E mi sono sempre chiesto perché... perché i miei occhi si riempissero di stupore guardando una rosa morta anziché quella viva, a stillare certezza. Poi ho capito. Con la consapevolezza che si acquisisce da soli, senza l'aiuto di nessuno, dove più che di vittorie si brilla di sconfitte. Il velluto nero ha sempre avuto una bellezza tutta sua, immota. Forse... perché nel nero risaltano anche i dettagli più minuscoli e irrilevanti, sicuri del loro essere insignificanti agli sguardi degli altri».
«...cosa hai capito?» pigolo esitante, impigliata nella sua effigie a torreggiare su di me, ora, in ogni lettera e in ogni ghigno a separarne le parole.
«Ho capito, io, che non dovevo più avere paura. Dentro di me, ormai, avevo racchiuso quella decadenza ospitandola con la gentilezza e venerazione che si riserva a una vecchia amica. Ho capito perché lo facevo, in qualche modo, come alla costante ricerca di una droga... quando accogli il buio negli occhi... poi smetti di averne terrore».
E i segni sbiaditi, allacciati a giorni passati, sulla sua gola, bluastri, s'imprimono nelle mie iridi.
Ora Alberto vortica dentro di me, raggiungendo il mio cuore.
«Io... ti avevo soltanto chiesto se ti piacessero le mie piantine...» esalo senza distogliere lo sguardo da lui.
«...se ti dicessi cosa mi piace davvero, Marta». La sua mano aperta a ventaglio si solleva, le dita a collidere sulla punta del viso. Un tocco a striare.
«Vuoi...» mormoro con un coraggio ad arrancare da un punto remoto, «...vuoi...», poi non si torna indietro, «vuoi stenderti qui vicino a me?».

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top