49. Di filo spinato e di zucchero filato
"Ma tu, figlia mia, tu ti trascinerai nell'oscurità e nel dubbio come la notte d'inverno che arriva senza una stella. Qui tu dimorerai legata al tuo dolore, sotto gli alberi che avvizziscono, finché il mondo intero sarà cambiato e i lunghi anni della tua vita saranno consumati."
Il signore degli Anelli – Le Due Torri (2002)

Orlo di spalle premuto contro la parete dura, anonima nella sua identità, fredda, noncurante. Ali inavvertibili ed eteree vengono schiacciate implorando pietà, le percepisco spezzarsi, interrotte da quella recisione netta distaccandole dalla mia effigie, dall'apice della schiena.
"Perché? Perché noi umani dobbiamo per forza essere privati delle nostre ali? Perché dobbiamo sopportare questa condanna?".
Forse, perché siamo troppo ingombranti per essere issati su, nell'aria? Forse, perché siamo aggravati di un fardello troppo eccedente... quale la nostra entità, nucleo di pensieri, riflessioni, sensazioni?
I fili di tendini, i fasci di muscoli, la ramificazione di vene, il rivestimento di pelle, il fluire del sangue — l'ancoraggio che contorna il mio corpo comprime ogni lambello delle mie ossa, quasi a manifestare la tangibile volontà di stritolarmi, rompermi in una moltitudine di pezzi minuti. Singolare volere, volere vitale.
È il peso dell'essere questo che sento premermi addosso con eccessivo fervore, un numero che varia costantemente e in assenza di inutili rumori, un numero che può rasentare un qualcosa di sopportabile – sostenibile dall'intelaiatura dello scheletro –, quasi vacuo, un numero che può trasformarsi al pari di un'incudine – opprimente e che spezza quando ci si distrae troppo –, colma di tutto.
E in questo istante mi sento appena spezzata, appena piegata, è venutasi a formare alla luce una piccola quanto fastidiosa cavillatura, proprio all'altezza della mia essenza. Salgemme impiastrate di rimorsi, sensi di colpa e contrizione s'insinuano dentro i pori della mia pelle, alla ricerca del punto migliore per attecchire, ambendo a distruggere il lindore che vi si cela.
Quel tenue che ero riuscita ad adunare con impegno, abnegazione e altrettanta arrabbiatura.
Perché lui si bea delle disgrazie altrui. Perché lui tutto ciò che offre è nient'altro che filo spinato. Filo spinato che avvolge e strozza, che attorciglia e ferisce, che aggomitola e rende il silenzio in urla disperate, che avviluppa e ti porta via.
A lui piacciono le urla disperate, anche quelle che non si sentono — soprattutto quelle che non si sentono. Le urla che riecheggiano da una parte all'altra della psiche, che scatenano burrasche impetuose e senza fine nell'animo. È il suo pane, morbido per i suoi denti, per le sue zanne grondanti di tossine, carezzate ogni dì di parole, frasi; e più quest'ultime le sfiorano, più divengono infettate, perfette per spiccare il volo dalle sue labbra e per seminare sofferenze, triboli dal quale è impossibile sfuggire.
A lui piace rovinare, poiché la sua indole – deturpata dal filo spinato stesso che scaglia contro gli altri – è ciò che gli impone.
Oltre che al peso dell'essere – improvvisamente divenuto insostenibile per le mie gracili ossa, cheto come le zampe di una volpe contro un manto di neve, impossibile da farlo librare in alto nel cielo –, adesso percepisco la realtà, l'effettività che mi gira intorno, inesorabile, piombatami addosso in tutta la sua crudezza e con ferocia. Nessuno schizzo di zelo, nessun abbozzo di attenzione.
Zampilli di acqua di mare, salati, troppo salati, e gelidi dritti in volto — le dita di Claudio, granito al posto dei polpastrelli, lontani intere Ere da quelle di Leonardo.
E il mio cuore ha preso a battere con insistenza come appena questi avevano raggiunto la sommità delle mie gote, a ogni battito qualcosa dentro di me si demoliva, cadeva, brandello dopo brandello. Poiché consapevole che c'era — c'è ancora — qualcosa di sbagliato, di erroneo, di dannatamente proibito. Vietato a prescindere.
Oscar Wilde questo non lo aveva raccontato nelle sue opere. In Dorian Gray. Il proibito attrae, stregandoti con nastri foschi e promesse fatte di fumo e miele, dando quell'effimera illusione – convinzione – di immortalità e grandezza; e subito dopo, come egli dà, egli prende. Funziona così, è la regola. I conti alla fine vanno fatti, le somme tirate e le valutazioni illustrate. Il prezzo va pagato; di poca rilevanza che sia equo o che sia inferiore.
Io e Leonardo l'abbiamo saldato il nostro debito e a un caro costo perfino, poiché entrambi ci siamo crogiolati in ciò che lo era eccome di proibito.
Ne abbiamo colto i fiori, gambo dopo gambo, scegliendone accuratamente i più belli, i più colorati, i più delicati. Ce li siamo incastrati nei capelli l'uno con l'altra, senza affanni, senza assillo dettato dal futuro. E dio... quanto mi è piaciuto farlo...
Ho pagato quel prezzo con gratitudine e senza trapelare minimo senso di colpa. Perché mi è piaciuto, nella maniera più impudente che avessi immaginato.
Il proibito mi è piaciuto, mi piace — ma messo in atto con la persona giusta.
È questo che Oscar Wilde si è dimenticato di trascrivere.
Claudio è infinitamente proibito, estremamente illegale, e con lui sento qualcosa che stona, che non deve essere. Un accento di troppo in quel di una poesia, quell'accento che le fa perdere di bellezza e di armonia, che la rovina.
Le sue labbra mi rovinano — mi mordono crudeli —, il suo respiro ansimante che va a scontrarsi contro la punta del mio naso mi rovina, la sua fronte che va a calcare sulla mia mi rovina, le sue dita di granito, che anziché carezzare hanno il compito di graffiare, mi rovinano, il suo filo spinato mi rovina.
Filo spinato in ogni dove su di me, centimetro di pelle, soffio d'anima.
"È insopportabile. Non riesco a sopportare. È talmente gelido che sembra quasi fuoco. Brucio e non di diletto".
Più Claudio affonda la sua bocca sopra la mia, più il filo spinato stringe, bucando, perforando fino a far fuoriuscire tutto di me, tutto quello che custodisco gelosamente. Paure, ansie, gioie, eccitazioni, pensieri gentili, teorie buie, flebili ricordi, intarsi di rabbia e di passioni.
"Quanto fa male... troppo male".
Sta aprendo la mia gabbia, e io non voglio dargli il benvenuto all'interno della mia gabbia, non voglio che lui entri.
Senza che ne me rendo conto — ora come ora non sarei affatto in grado di scindere il tangibile dall'intangibile con acume necessario —, alzo le braccia, che sino ad ora erano rimaste ferme e immobili, intrappolate nel limbo dello stupore e del terrore, e le sguaino alla volta di colui che sembra incarnare le fattezze di Ade, in mia difesa.
Pianto le mie mani tremule sopra il rivestimento della sua pesante giacca, abbottonata sino alla gola; distrattamente un bottone è saltato alla scia che sarebbe potuta essere perfetta. Faccio pressione sopra il suo petto, attraverso la sua gabbia toracica, sperando in qualche modo di arrivargli ai muscoli del cuore corrotto e fargli capire che mi sta facendo provare tanto dolore.
Non quello fisico, oh no... forse sarebbe stato più tollerabile.
È nient'altro che dolore emotivo e basta. E lui mira proprio a quello.
Rovina me — sciupandomi più di quanto abbia fatto io nel corso degli anni —, e in maniera indiretta, quanto infida e micidiale, rovina Leonardo, ciò che io gli ho portato via.
Gioia non gli è bastata, Olivia non gli è bastata, il Caravaggio non gli è bastato... chissà se gli basterò io. Claudio riuscirà a essere in pace con se stesso, prima o poi? È un'ipotesi così folle da pensare?
Spingo contro di lui con tutta la volontà che sono in grado di attuare, ben poca rispetto a quella della norma, ma purtroppo sono succube del momento, succube di quel proibito nocivo e di quel filo spinato acuminato e asfissiante.
«C-Claudio...» bisbiglio con la voce spezzata, stelo di una rosa senza spine troncato in due.
E spingo di nuovo, con maggiore audacia, con la baldanza che fin da sempre mi ha accompagnata attraverso i corridoi della scuola, sotto gli sguardi di tutti, combattendo le differenze, opponendomi alle divergenze; la stessa che mi ha fatto guadagnare l'identità di Atena.
La bordura delle sue labbra solca la mia — onde contro scogli —, implacabile, spoglia di quel garbo cortese che hanno contraddistinto i miei baci antecedenti. Non ne colgo la morbidezza — non pare che ne abbiano la confidenza —, non le sento levigate. Si dimostrano amarognole, impiastricciate del sentore di una sigaretta appena fumata e di un liquore appena consumato, è il sapore acre dell'errore. Di un qualcosa che non doveva accadere.
E con le dita, mani che smuovono quelle fibre di filo spinato quasi vi fossero marionette alle sue sommità, mi artiglia le gote, non vuole farmi scappare. E come potrei scappare, anche volendo?
Costretta così, con le spalle al muro, senza via di fuga. La vita di Firenze che scorre, la notte che fa capolino piano piano. Io che vengo rovinata con un'impazienza che scortica e non dà scampo.
«...Claudio, b-basta...» riprovo un'altra volta, riprovo a farlo smettere, riprovo a scansarmelo via di dosso, con urgenza disperata e le mie grida afflitte e sconvolte palesate attraverso le iridi brune.
Le ascolto, sono nitide e di un intrinseco orrore dentro di me. Quanto vorrei farle sentire anche a lui... ma forse — consapevolmente — lui già le sta avvertendo. Dopotutto, se si bea delle disgrazie altrui, un udito fine, in grado di sentire, deve averlo.
Sì, Claudio sta ascoltando le mie urla tacite, occultate a metà.
All'improvviso egli sogghigna, la sua bocca vibra di un sorriso macabro allontanandosi percettibilmente dal mio volto. Un velo di carta soltanto potrebbe essere in grado di passarci attraverso, fra le estremità dei nostri nasi. Si discosta, finalmente si allontana interrompendo il tormento che con greve volontà stava esercitando su di me.
Allenta la presa del suo filo spinato.
I riverberi di un tramonto ardente, sfavillante di tinte viola rimestate con un vermiglio infuocato ornato di parvenze nere, gli vanno a vezzeggiare lo spigolo della mascella sino a risalire alla fessura della pupilla, illuminandogli mezza faccia. Lo stesso vale per me, mezza faccia al cospetto del bagliore, mezza faccia celata dal buio — come se mi avesse corrotta unicamente a metà, il lavoro incompleto.
Claudio sogghigna di candida estasi, e più osserva — più mi divora —, più sembra sentirsi allietato.
«Uhm» emette deglutendo un groppo invisibile, il pomo di Adamo che si muove come una sfera sotto la pelle bianca, poi va a mordersi il labbro inferiore, concedendosi un attimo per prendersi gioco di me, «Matilde, Matilde, Matilde... ora lo capisco un po' Leonardo, sai? Le tue labbra hanno proprio il sapore dell'Eden. Nemmeno quelle di Olivia potrebbero competere con le tue».
«Sei... sei un essere nauseante, Claudio» dico in un sottile soffio di verità, incollandomi all'estremo contro quel dannato muro, pregando mentalmente che mi inghiottisca facendomi volatilizzare. Volto il capo verso destra, chinando il mento all'ingiù, gesto impellente per mettere distanza fra me e lui, quanta più lontananza possibile.
«Perfino il mio nome, dapprima sfiorato e infine ammatassato della tua voce, risuona di un idillio tutto suo... potrei paragonarlo a un Carme di Catullo. Scommetto che un complimento del genere Leonardo ancora non te l'ha fatto» replica Claudio ignorando la mia offesa, o forse non l'ha proprio udita di proposito.
Leonardo... ma cosa ne sa lui di Leonardo... si è proclamato — si proclama tutt'ora — suo fidato amico, ma cosa ne sa? Di effettivo quanto ne sa di Leonardo? Di colui che ha fatto sua la nobile quanto inesplicabile e cupa arte del non far trapelare nulla di sé; dissimulare ogni scheggia dietro una finzione costruita con le proprie mani, fissandola con vernice di apparenze, dietro una posa di buone maniere, cortesia e infinità di sorrisi atti a compiacere.
Leonardo ha confinato fuori tutti dalla sua fortezza dorata, lui unico abitante. E quelle rare crepe dalle quali era possibile intravedere la bruma della sua interiorità tuttavia c'erano, qualcuna glien'è sfuggita.
Claudio nella maniera più assoluta non è stato in grado di sapervici guardare attraverso. Gli è bastato quello che aveva all'esterno, si è accontentato delle briciole che Leonardo gli ha offerto con sfrontata beffa.
Perché Claudio null'altro si merita di Leonardo, solamente le briciole. Fin'ora non ha fatto altro che soddisfarsi dei suoi granelli fatti cascare con parsimonia, e lui, nelle vesti di patetico bisognoso, ne ha raccolti uno a uno.
«Allontanati da me» sento le mie corde vocali fibrillare, «allontanati da me, adesso». Lentamente ritorno a posare i miei occhi sulla sua figura, riversandogli addosso sdegno a fiotti e provando a liberarmi da quella prigione di filo spinato.
Districando piano piano, con cura, facendo attenzione a non ferirmi.
«Sono un essere nauseante, tu dici» celia lui sogghignando — allora mi ha sentita eccome —, mi fa dono di uno sguardo sghembo, come se avesse dinanzi una bambina capricciosa, «eppure...» e va a incastrare il mio mento in mezzo al suo indice e al suo pollice, «non credo proprio di soddisfare la definizione di tale vocabolo».
E ancora mi tocca, e ancora mi rovina, oltraggioso danno, oltraggiosa beffa.
«Gioia non era di questo avviso» continua egli con tono spensierato, talmente spensierato che quasi non riesco a comprendere se faccia o meno sul serio. Vacilla la mia convinzione che sia del tutto... sano.
«Smettila di tirare in ballo quella ragazzina, falla finita» sibilo fra i denti e decidendo di reagire una volta per tutte.
Serro la mia mano attorno al suo polso, attorno al lembo di pelle che fa capolino dalla manica del suo giacchetto. Il mio tocco fa tremare la sua morsa di tendini contratti, arpionati a me.
«Ora ci sono io con te. Matilde, nessuna Gioia» insisto senza smettere di fissarlo con sguardo traboccante di acredine, la medesima che non mi sono mai risparmiata di rovesciare addosso a Leonardo, quando ancora aveva a trascinare dietro l'etichetta del nemico, «cosa ti fa pensare che in qualche modo tu rovinerai Leonardo con questo?».
Il bacio di Giuda.
In un brusco strattone improvviso, Claudio mi attira a sé, e per fortuna che pianto appena in tempo i piedi per terra altrimenti sarei finita completamente addosso al suo petto, addosso alla sua corona di filo spinato.
Io ho il suo polso stretto fra la mia presa, lui ha il mio stretto fra la sua. Un pareggio all'apparenza, ma sappiamo con chiarezza entrambi che quello che sta per avere la meglio è lui soltanto.
Il ragazzo dalle iridi smeraldo infettate da scaglie plumbee si piega sino a chinarsi all'altezza del mio orecchio coperto dai capelli — non raggiunge i valori dell'altezza di Leonardo, tuttavia rimane comunque più alto della sottoscritta —, sporgendosi in avanti, superando il mio profilo, si avvicina. Si avvicina e preme la bocca contro la tempia, assicurandosi che quello che ha da dichiararmi arrivi dritto a destinazione. Il cerotto che ha appiccicato sulla linea del naso preme contro l'epidermide.
«Vuoi sapere come lo so? Vuoi sapere perché io ne sono così sicuro?» bisbiglia come se mi stesse raccontando una fiaba preziosa, esclusiva, non per le orecchie di chiunque, voce lontana e misteriosa.
Rabbrividisco, provo tremolii di pura angoscia, timorosa che il filo spinato ritorni ad avvinghiarmi. Claudio non è un ragazzo come gli altri, è un calappio letale. Tuttavia non cedo all'impulso vorace di scrollarmelo di dosso, resisto e lascio che m'intrappoli, lo devo ascoltare.
«Lo rovinerò perché correrai da lui, presto o tardi, correrai da lui come un coniglietto impaurito e glielo dirai. Gli racconterai quello che ho fatto, saprà che ti avrò contaminata. La sua Matilde... la sua piccola e dolce Matilde profanata da colui che odia di più. Perché Leonardo mi odia... oh sì se mi odia... È doppiamente incredibile, risultato sorprendente!».
Infine Claudio si allontana, torna indietro con la spina dorsale e riacquista una perfetta postura eretta, elegante. Tipico signorino sprezzante.
Abbandona il mio polso, lascia cascare entrambe le mie braccia contro i fianchi, un movimento da impeccabile bambola di pezza, vuota. Dopodiché infila le mani all'interno delle tasche del proprio giacchetto e innalza la sommità del mento in un gesto di totale egemonia, sicurezza di vittoria. Il trionfo su Atena.
«Non vedo l'ora» proferisce di eccitazione, negli occhi una saetta di follia risplende in lontananza, ciononostante si scorge alla meraviglia, «da quando avete iniziato a scambiarvi patetiche effusioni del cazzo, al Caravaggio la vita è diventata così tanto noiosa... roba che quando apro gli occhi la mattina maledico il giorno appena sorto. No, no, no, così non può andare. Almeno prima, quando vi odiavate, era tutto più divertente. Gioia mi faceva comodo per alimentare questa sorta di guerra tra di voi, tra i due indirizzi. Quasi mi era sorta la speranza che avremmo affrontato la maturità con spade e scudi, all'ultimo sangue. Ma poi avete distrutto tutto quanto, tu hai distrutto tutto quanto, tu ti sei messa in mezzo come la peggiore delle gramigne. Hai fatto cedere il pilastro per eccellenza e a me questo non sta bene per niente».
«Ma ti senti quando parli, Claudio?» replico con le sopracciglia sollevate verso l'alto, dannatamente piegate tanto da provocarmi fitte alla fronte, ma lo sgomento è troppo grande per farlo rimanere imprigionato, «Non ti rendi conto di aver appena toccato il fondo? Ne stai parlando come se Leonardo fosse una tua proprietà...».
«Perché lui lo è! Lui era mio. Eravamo composti della stessa insoddisfazione verso la vita, verso le persone, verso la scuola, verso il futuro! Ce la intendevamo, aveva più intesa con me che con Alberto. Qualsiasi cosa io gli proponevo avevo sempre il suo appoggio. Eravamo noi contro il tedio e l'entropia, noi soltanto, noi e basta. Poi sei arrivata tu, sei sempre stata tu... e lo hai ghermito con quegli artigli affilati incatenandolo a te» esclama Claudio quasi sofferente, alzando la voce di qualche buona ottava, tanto che sobbalzo sul posto seppur con il dovuto contegno.
«Io non ho incatenato proprio nessuno. E poi si vede, si vede lontano chilometri che tu, della mente di Leonardo, ancora non hai capito un emerito niente. Fumo. Nebbia. Per te la sua mente è un totale enigma, mai riuscirai a venirne a capo. Perché solo chi è caduto nel baratro, nella nera voragine dove Alice stessa capitombolò, può riuscire a capirlo, a carpirne i suoi segreti» parlo lentamente, aprendo con flemma le palpebre, lasciando che le scure ciglia immerlettate di ribrezzo facciano intravedere il mio piglio infausto, due spilli scuri con una sola priorità: bucare giù, giù, giù, sempre più giù.
"Tu sarai filo spinato, ma anche io ho la mia arma segreta".
«Dacci un taglio, perché a lungo andare diventi tu stesso noioso».
Ed è quando pronuncio "noioso" — un'offesa verso di lui — che l'attenzione di Claudio pare zampillare oltre galassie lontane.
«Tu dici? Oh... ma vedrai quando tutti gli altri sapranno di quello che ti ho fatto. Fremo di eccitazione al pensiero di come la prenderà anche quel bestione del tuo amico, il fratello della piccola Celeste. Non ricordo il nome, ahimè, non me ne farai una colpa voglio sperare» ridacchia spostando il peso da una gamba all'altra, arricciando nel contempo il naso non ancora ritornato in sesto.
Un soffio di vento gli va a scompigliare i capelli, non troppo corti, non troppo lunghi, ignaro di passare attraverso le spire di un serpente.
Ora non vacillo più, Claudio Patriarchi è a tutti gli effetti insano.
«Sì, sei noioso. E quando te ne renderai conto sarà troppo tardi» esordisco alzando il mento a mia volta, strofinando la stoffa del giacchetto contro le labbra, in quello che vorrebbe essere un flebile tentativo di togliere via di lì il sapore, l'essenza di Claudio, la sensazione del suo filo spinato ancora sulla pelle, «adesso scusami, ma a differenza tua io devo occupare la mia vita con azioni utili e produttive. Il lavoro mi chiama, intanto ritorna a giocare con le tue marionette, ammesso che ancora tu ne abbia. Anche il più stolto, alla fine, rinsavisce, segnatelo».
Sguscio di lato, approfittando della distanza che ci separa, le spalle che strusciano contro il muro del cinema. Le ali invisibili che, nonostante siano state già recise, hanno una voglia irrefrenabile di volare.
«Hai finito con Leonardo, lui stesso ha tagliato via i fili» parlo un'ultima volta, tombale, mentre mi avvicino all'entrata dell'Arcadium, la colonna sonora della Famiglia Addams giunge flebile alle mie orecchie.
«È stato bello, comunque, il bacio, dolce Atena» dichiara alle mie spalle Claudio con aria beffarda, «colmo di passione e travolgente come il teatrino di stamattina con il tuo amato. Chissà... magari domattina è il mio turno».
E prima che la figura di Violetta mi venga incontro al fine di darmi il cambio turno in via ufficiale vengo colpita con il colpo di grazia, vengo trafitta per l'ultima volta da quel filo spinato con una sola e semplice frase.
È stato bello il bacio.
Perché io ho baciato Claudio Patriarchi. E su questo non esiste menzogna che sia in grado di ammantare un errore del genere.

La cornice si restringe su Marta.
Alzo gli occhi dalla tavola che avrei dovuto consegnare il giorno seguente per discipline progettuali, uno schizzo ancora implorante di essere portato a termine, bisognoso di conoscere una fine — possibilmente più in fretta vista l'urgenza — mi osserva timidamente dalla liscia carta immacolata, a tratti ornata da qualche stella di macchia scura.
Sbavature d'imperfezioni trascinate dalla bordura esterna della mia mano, impiastricciata di pulviscolo di mina, che mi sarei preoccupata di cancellare a lavoro ultimato; quando si tratta di disegnare, soprattutto una tavola per la Francisi, entro in modalità Sith che non accetta giustificazione alcuna. Nessuna scusante, nessuna scappatoia. Avverto l'esigenza del compimento supremo, mi è intollerabile accontentarmi.
Distolgo per brevi istanti la concentrazione da quel trionfo di linee, traiettorie che altro non attendono se non la mia volontà di dar loro un senso — rimango con la mina della matita premuta contro il foglio, eccessiva pressione percorre il groviglio di tendini contratto, fino ad attraversare il contorno di quest'ultima, ferma, anch'ella in attesa.
Non ho la mia familiare chioma argentata, sottili ciocche annodate, a ricadermi oltre la fronte, oltre le tempie, cercando di imitare il fluire incantevole delle cascate; mi sono preoccupata di legarla in due trecce non troppo strette, ricamate con non troppa cura.
Dolci e delicate mi scivolano dietro le spalle, vezzeggiando le scapole attraverso la flanella del maglioncino, intrichi bianchi spiccano sopra la stoffa del medesimo colore, andando ad abbracciare quell'argenteo splendente dei capelli, magico quanto artefatto.
Forse persino troppo sbiadito, scongiurante di essere riportato agli antichi albori, di un argento più pronunciato e prezioso, e non così stinto tanto da richiamare la gloria dei Targaryen.
Il pensiero mi fa alzare il braccio verso l'alto, la mano che va a collidere contro il contorno dell'orecchio, un gesto guidato per scostarmi quelle poche ed esili ciocche sfuggite all'intreccio, fastidievole in questo particolare lasso di tempo. Effimero e incalzante.
Incateno le iridi al poster dell'Impero appeso alla parete dinanzi a me, a torreggiare sopra la scrivania dove — volente o nolente — sto tentando di fare la cosa buona e giusta quale quella dello studiare. Tento, ci provo.
Ma è letteralmente impossibile, sfiderei la persona con il quoziente intellettivo più alto a mantenere uno stralcio di concentrazione decente quando hai non una, ma ben due bocche a parlare all'unisono. Emulando a trecentosessanta gradi un pomeriggio tra pettegole alle prese con lo sproloquiare a non finire, senza sosta, ininterrottamente.
L'unica divergenza è che non si tratta di ragazze, totale assenza di toni femminili e di mormorii segreti. Oh no. Niente del genere.
Le voci tempestose e massicce di Diego, Marco e Ludovico mi stanno tormentando l'udito da quasi mezz'ora — minuto più, minuto meno. Distraendomi dal mio dovere in creanza inclemente, senza garbo alcuno.
Diego che percorre un tracciato ben definito nella mia stanza avanti e indietro, interrompendo la marcia in un punto assai delineato e facendola ricominciare nel verso opposto, senza mai smettere. Ludovico appoggiato con la spalla contro la cornice della finestra appena spalancata, a fumarsi l'ennesima sigaretta, ho perso il conto generosi minuti fa. Marco seduto comodamente sopra le coperte del mio letto, le gambe che sporgono di lato, che legge con morbosa attenzione El Gaucho di Milo Manara, ammirandone la bellezza dei disegni, gli ornamenti sublimi del tratto ineccepibile che fa di quel fumettista un maestro del suo genere.
«Ancora non riesco a mandarlo giù» tuona per la milionesima volta Ludovico, appellandosi alla vicenda di stamani, ammantando l'identità di Leonardo di coltri di fumo gettate all'infuori, dissolte entrambi in veloci istanti, «quel biondino. Proprio mi rimane indigesto».
Le sue corde vocali che vibrano di ostilità pungente e che non lascia scampo. Il che è un qualcosa di assai familiare trattandosi di lui, tuttavia si percepisce quella nota salace in più.
«Abitudine. È tutta questione di abitudine» recita Diego come fosse una formula magica in grado di fargli assimilare tutto quanto e nel minor tempo possibile, «mi sono abituato a mangiare quell'orribile sformato di carciofi che mia madre ci propina ogni venerdì. E se ci sono riuscito per una cosa come quella, perché non anche per questa? Io odio i carciofi, mi ricordano matasse di insetti».
«Forse perché Matilde e Leonardo non sono paragonabili a uno sformato di carciofi» ragiona saggiamente Marco, dopo averci riflettuto in cuor suo per qualche secondo; lo sento abbandonare con cura il libro sopra la stoffa ruvida dei suoi jeans.
«Infatti» conviene lugubre Ludovico, «perché sono paragonabili a una pedata alle palle. Lui è paragonabile a una pedata alle palle, non lei».
«Quanto sei drammatico, Ludwig...» celia Marco come un grottesco drammaturgo, con tanto di giacca dai colori sgargianti.
«Io dico quello che penso» ribatte l'altro per niente scalfito dallo scherno.
«Oppure potrei abituarmi come ho fatto con i video idioti che puntualmente mia zia m'invia su Facebook! Sì, posso farcela!» insiste Diego battendosi il pugno sul palmo aperto.
«Matilde e Leonardo non sono paragonabili ai video idioti che tua zia t'invia su Facebook, Dié! Dacci un taglio» lo riprende Marco con severità.
«Però sono paragonabili a due idioti. Anzi, lui è un idiota, non lei» e conclude Ludovico — mancando solo di dire "amen".
«State zitti!» sbotto con la fascia dei nervi che ha raggiunto seriamente un livello spaventoso, i denti che si sfregano l'uno con l'arcata dell'altro e la punta della mina che preme inclemente contro quella sventurata tavola, e l'altra mano – quella sporca di polvere grigia – incuneata alla carne della mia coscia. O lei o le loro gole.
Nella mia rimarranno flebili segni, nelle loro l'esalazione dell'ultimo respiro. Meglio evitarlo, l'omicidio di tre inetti.
E vedendo che nessuno dei tre inetti osa proferir vocabolo, continuo a far valere la mia autorità siccome siamo a casa mia, voltandomi nella loro direzione. «Siete venuti da me per studiare oppure per intavolare un comizio peggio dei politici più viscidi? Il vostro blablaparlare mi risuona nelle orecchie come il tintinnare di mille grilli! Cri cri di là, cri cri di qua! Ludovico, apri quel cavolo di libro e studia l'argomento che Lunanuova ti chiederà alla prossima interrogazione, smettila di fumare tutte quelle sigarette, hai quasi finito un pacchetto! Diego, dacci un fottuto taglio, ti abituerai, è ovvio che ti abituerai, noi esseri umani facciamo così! Non ci facciamo, forse, andare bene tutto quanto nella maggior parte dei casi? Pensa che Van Gogh si abituò a restare con un solo orecchio. E Marco, perdonami tanto, se non erro, ma tu non dovevi fare la parafrasi di Solcata ho la fronte di Ugo Foscolo?».
«Te l'hanno mai detto che, non sempre, solo rare volte, sai essere alquanto isterica, DarthMart?» mi arriva la domanda placida di Marco e per niente indirizzata a farmi caracollare in una sfuriata.
Quel suo portamento serafico e le iridi miti, ornati da quei riccioli scuri e mai composti – le regole della fisica non contano per loro –, sono da sempre stati un insolito connubio ai miei occhi. È come rimirare un albero, dal tronco fermo e costante e dalla ramificazione rigogliosa, continua schiava di sferzante brezza.
«Siete venuti a casa mia con la promessa di voler studiare, non per fare salotto. Se Matilde fosse stata qui probabilmente vi avrebbe urlato contro già trenta minuti fa, ma purtroppo è a lavorare, quindi dovrete accontentarvi di me. Nella mia isteria» enuncio ingobbendo percettibilmente la colonna vertebrale per poi issarmi in posizione eretta, l'atto di distendere e sgranchire il tessuto muscolare rattrappito per la cattiva posa, «e, soprattutto, non vi avrebbe permesso di sparare giudizi a destra e a manca».
«Sono le sei e un quarto. Io non studio mai alle sei e un quarto» recita Ludovico facendo spallucce, cadenza uniforme e invalicabile.
«Allora nelle motivazioni della tua bocciatura in tronco, a fine dell'anno, prima della maturità, scriveranno: Ludovico Auditore, non ammesso agli esami perché soleva non studiare oltre le sei e un quarto» soffio spazientita e non mancando di far trapelare veleno, lo sguardo talmente torvo che i rovi di ciglia si mescolano della sfumatura dei miei occhi, apodittica minaccia.
«Tu che ne pensi, Marta?» Ludovico scarta con estrema facilità la mia intimidazione a lettere cubitali e mi chiede senza vergogna, «Che ne pensi di loro due?».
Loro due. Ancora loro due. Matilde e Leonardo. Il legame che mai ci saremmo aspettati di vedere, nemmeno dopo il diploma. L'unione più stravagante, forse persino più stravagante di quello che sento per Emilio.
Atena e Apollo. Rosa cremisi – corolla di spine –, spiga di grano – ampolla di fiele.
"Matilde a volte crede di non averle le spine", sorrido, "ma essendo rosa deve avercele per forza, è il prezzo che impone quel fiore tanto bello quanto acuminato".
«Ho tanta, ma tanta paura di quello che penso davvero che neanche mi ubriaco più, altrimenti mi sovrasterà e io non sarò pronta» dico scorticando con fare nervoso la pellicina dell'indice a forma di mandorla, soddisfacendo la curiosità di Ludovico, «lucidità, è questo il segreto. E io penso che sono due persone che hanno preso la loro decisione, non ne occorre una terza, una quarta o tanto meno una quinta a scegliere per loro. Io non riuscirei a sopportare se qualcuno arrivi a decidere per me».
«È esattamente il mio stesso pensiero» interviene Marco chiudendo con garbo il libro di Milo Manara, «sono due persone senzienti e non sformati di carciofi. Inteso, Diego?».
«Non... io non credo di avere niente contro di loro. Dico solo di dovermici abituare, ecco tutto. Familiarizzare, insomma. E poi, a quanto pare, qui il testa di cazzo è quel Patriarchi, no? Alla fine non era lui che ne muoveva i fili, i fili di tutti noi?» risponde Diego grattandosi la fronte, sfiorando il bridge che tempesta l'estremità del suo naso.
«Io lo voglio ammazzare, stritolare le sue ossa fino a sentirlo urlare di sofferenza e implorare la mia pietà che mai gli darei» dichiara Ludovico stringendo le nocche in due pugni per niente amichevoli, i tendini che guizzano al di sotto della sua epidermide, «io non li volevo gli amici. Ecco perché. Perché portano solo rotture di palle».
«Secondo voi chi gliel'ha scattata la foto?» interviene Marco con voce tetra.
«Qualcuno che voleva fare un favore a Claudio, qualcuno che aveva piacere a crogiolarsi della disfatta di Matilde e di Leonardo, qualcuno che li odia entrambi. Studente del Classico, studente dell'Artistico... chi lo sa?» provo a ragionare.
«Olivia?» suggerisce Diego.
«Scontata» è la mia risposta, «e poi era insieme a Claudio quando Ludovico è andato a spaccargli il naso».
«Gioia?» ritenta Diego.
«Doppiamente scontata» è di nuovo la mia risposta, «e non nominarla più. Il solo sentire pronunciare il suo nome mi provoca spasmi di disgusto».
«Mi dispiace per Laira» ammette Marco con un sospiro.
«Troppa furbizia ed eccessiva sicurezza si nasconde in lei, e la troppa prodezza ne porta altrettanta di stoltezza. Cieca è stata di fronte alla sua migliore amica» faccio notare con severità.
Percepisco di nuovo l'impulso di stamattina, quello di strisciare contro il pavimento la punta della scarpa, le movenze della katana prima di sferrare un colpo letale. Talmente persa nelle reminiscenze delle mio intelletto che neanche odo il suo del mio telefono che annuncia l'arrivo di un messaggio.
«Marta, ti è arrivata una notifica di Messenger» infatti mi avvisa Diego con non troppo interesse; è come un gesto involontario, lo stesso del suo braccio che va a indicare la direzione della mia scrivania, mi mette al corrente di un qualcosa che a me è sfuggito.
E fondamentalmente così è. Nemmeno rappresenta un mio interesse, adesso, prestare attenzione a quella diavoleria quale il telefono. Tuttavia, mossa da nuda parvenza di apatia, acciuffo i bordi ferrigni dell'apparecchio, con disattenzione, senza essere morsa da quella tipica curiosità di sapere chi, a quest'ora, mi sta cercando.
Piroettando le iridi quasi a lamentarmi silenziosamente di ogni cosa sblocco il display e lo degno del mio interesse.
Torno a essere statua di gelo.
Emilio Lunanuova vuole vedermi.

E nella notte, teatro di orrori e di meraviglie, quadro di risolutezza e follie, paranoia e oblio, io vago con passo lene, cercando la morbidezza dell'erba in quel triste cemento di città.
La prima volta ci siamo incontrati al buio, e al buio lui – inconsciamente, come lo sbocciare dei fiori – mi ha mostrato quella piccola insenatura del suo mondo interiore. Forse, io ho curiosato con fin troppa morbosità, immergendomi con gentilezza e pazienza, pian piano, sottovoce.
E nuovamente il buio ci farà da testimone, aggomitolandoci di sciarpa nera e drappo stellato. Nessun sole, nessuna luce, nessun bagliore, nessun calore. È come se decidessimo senza volerlo di lasciarlo fuori, quel piccolo spiraglio. Poiché lo sanno tutti – è risaputo –, che fu preferita l'oscurità alla luce.
Dopo la cena, intorno alle nove e mezza, al termine delle sue prove teatrali, ci saremmo incontrati fuori dal teatro Don Chisciotte. Così abbiamo deciso. Così Emilio ha proposto, così io ho accettato.
Le sommità degli alberi frusciano sotto il volere del soffio del vento, aitante dominato dalle intimazioni di dicembre, mese più freddo per eccellenza. Essi sfilano ai miei lati con menefreghismo, prigionieri delle loro stesse radici, e io provo pena per loro, perché hanno cemento e non manto erboso.
Lui è lì. Lo scorgo con una nota di strabiliante giubilo, nascosta con accortezza dietro iridi impenetrabili tanto spalancate.
Ancora sento essere ghiaccio, nonostante tutto, il mio meccanismo di difesa che con non troppa facilità mi dirà addio. Non sono stata del tutto assuefatta dall'ardore dei sentimenti e dall'energia delle emozioni; fremiti di eccitazione.
Perché io per troppo tempo sono stata ghiaccio senza conoscere tepore — lungo inverno, neppure una primavera. E ora sono nient'altro che resti di silenzio di vetro e di vento.
I suoi capelli corvini risplendono di un riflesso magico sotto il chiarore della luna, pare quasi che tentino di emulare il mio argento. Gli occhi ancora non ho l'onore di ammirarli – troppo lontani –, ma già so quale splendore vi si celi dentro. Perché l'ho avuta, quella fortuna sfacciata di poterli rimirare da vicino, a distanza ridicola.
Ma le labbra... sono le labbra che sorridono soltanto a me a far mancare il mio povero cuore ghiacciato, atteso di essere sciolto dalla brina, di un solo e misero battito. Il battito della fine, della sciagura del mondo. Le fattezze di quelle labbra dannatamente candide, che ho saggiato, donano lui di quell'essenza di ginepro che tanto si congiunge divinamente con il mio essere ghiaccio, neve. Non esiste unione più bella.
«Marta», il mio nome, di sole cinque lettere, lascia quell'orlo seducente e bisognoso di essere sfiorato, che siano dita o che siano altrettante labbra. «Sei qui» racconta un fatto reale. Io sono qui, con lui.
«Perché lo voglio» recito davanti a lui senza vergogna e senza pentimento.
Egli ridacchia delle mie parole. «Non oso muovere alcun dubbio. Tuttavia un po' avevo paura».
Corrugo la fronte di perplessità, «Avevi paura? Perché?». Non ci sfioriamo, non ancora, non ci tocchiamo.
«Non lo so... sono alquanto arrugginito, la verità è questa. Ho pensato solo dopo averti scritto su Facebook di quanto avessi fatto una cavolata. Tu odi i social» spiega Emilio con quelle iridi blu che brillano della bellezza dell'oceano.
«Ho... ho apprezzato tanto il tuo messaggio, in realtà. E poi in quale altro modo avresti potuto scrivermi se non hai il mio numero?» sottolineo abbozzando un sorriso d'intesa, a tratti timido.
«Staresti suggerendo che dovrei chiedertelo?» asserisce dolcemente ironico, muovendo un passo verso di me.
«Se vuoi, sia mai che ti obbligo, professore...» raccolgo quel piccolo cumulo di sarcasmo e ne getto anche sulla mia di frase. Un piccolo botta e risposta che altro non fa se non aumentare il desiderio.
«Te lo chiederò davanti a una tazza di tè, rigorosamente senza zucchero, per te, e un cappuccino spruzzato di cioccolato per me. Conosco un Caffé Letterario che adorerai. Ti piace come idea?» propone lui stringendo il borsone di cuoio con possessività.
«È un compromesso niente male» annuisco con aria impudica.
Saremo io e lui, da soli. Ginepro e neve.
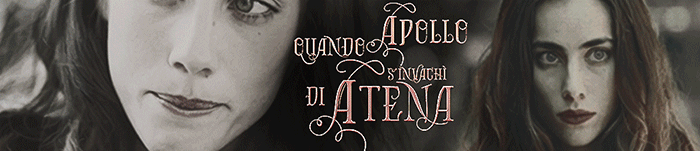
La cornice si allarga su Matilde. Ancora.
Ho accettato di venire, nonostante le dieci della sera, perché me l'ha chiesto Costanza. E Leonardo lo sa.
Ho accettato di venire perché, tuttavia, ancora percepisco sulla mia pelle i segni del filo spinato. E questo nessuno lo sa, nemmeno Costanza.
Ho accettato di venire perché non potevo – non volevo – ritornare a casa e affrontare le ferite in solitudine. Al cinema avevo Jevanni con la sua allegria e il suo solito brio a tenermi compagnia, ad allietarmi e riuscendo a scacciare l'infausto ricordo.
Ho accettato di venire perché ho bisogno della mia dose di gioia nera — di tutte le dita di Leonardo a lenirmi il tormento, i lividi prima che diventino cianotici e incurabili.
Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Tutte e dieci, una per ogni scampolo di pelle che ha subito quella tortura.
Ho accettato di venire alla cena che organizzano ogni mese al Centro Equestre di Leonardo, per famiglia e amici di coloro che si allenano al suo interno. Io e Costanza siamo più che benvenute.
E no, non ho la minima idea se vi siano Lucrezia e Furio, tanto meno Michelangelo. Ma ho deciso che poco m'importa, io voglio stare con Leonardo, ho fame della sua presenza, del suo profumo, non serve ulteriore giustificazione. Un animale ferito fa ben poco caso a chi ha intorno.
«Una cosa che amo da morire di queste cene, rigorosamente a buffet, sono i crostini alla crema di tartufo e quelli con il salmone. Divini. Ah, e ovviamente il vino che servono, pregiatissimo e buonissimo. Va alla testa che è una meraviglia» spiega Costanza al mio fianco mentre con passo tranquillo e imperioso avanziamo alla volta del Club, seconda occasione che ho modo di vederlo, «andrà avanti per le lunghe, ti avviso».
La Queen Bee del Classico, per l'evento, si è agghindata in maniera molto elegante, a differenza mia, che dalla divisa dell'Arcadium sono passata a una semplice camicia bianca, una gonna di jeans nera e degli stivali alti sino al ginocchio. Semplicità più che eleganza.
Lei è rimasta decisamente in linea con il suo stile ricercato, che le si addice alla perfezione. Una treccia le fa da corona attorno al capo, mentre il resto dei capelli le scivolano dolcemente e abboccolati lungo la schiena, oltre le scapole.
Il vestito senza maniche di tartan bianco e nero le fascia l'esile vita per poi interrompersi all'altezza delle cosce, qualche centimetro sopra le ginocchia, gambe avvolte da calzamaglia immacolate come la mia camicia, lisce e sottili, spiccano al di sotto. Un fiocco scuro fa capolino dal colletto della camicetta indossata sotto l'abito. Quasi somiglia a Blair Waldorf nella sua interezza, è il suo cipiglio altezzoso e che non ammette repliche alcune che la distanzia di poco.
Costanza è assai più cocciuta e irremovibile del personaggio di Gossip Girl.
«Non importa, grazie per avermi invitato» dico con un sospiro tutt'altro che brioso. Non devo avere il migliore degli aspetti, già...
"Perché lui ti ha baciato. Perché lui ti ha rovinata".
Cazzo... più mi obbligo a non pensarci, più quella sensazione ritorna a farmi visita, arzilla e implacabile. Marchio impresso sulla bocca, sotto gli occhi di tutti.
"Costanza, perché non te ne accorgi? Perché non riesci a vedere?".
Superiamo quei brevi e tre gradini che separano la veranda dal terreno di sassolini, il vociare delle persone inizia a farsi sentire.
«Con te sarà più divertente! Mi piace la tua compagnia, hai una forza d'animo senza pari. A differenza di quelle che mi stanno intorno non soccombi al mio carattere. Te l'ho già detto che sei stata fantastica stamani?».
«Giusto cinque o sei volte nel tragitto per venire fin qui» le rinfresco la memoria mentre lei fa per aprire il pomello della porta in legno e in vetro, piacevolmente rustica.
«Allora vuol dire che questa sarà la settima» ribatte ella con energia.
«Costanza, che tipo è il padre di Leonardo?» le domando pur di non restare intrappolata nei rovi delle riflessioni, avanzando dietro di lei.
«È un tipo di uomo che... accidenti!» esclama la ragazza all'albore della frase, morta prima di vedere la luce, «No... Ancora lei... e io che speravo che questa sera avesse dato forfait. Quella dannata».
Astio, rancore, livore trapela dalla sua voce come il miele che cola dall'alveare.
E Costanza s'interrompe proprio al confine dell'ampio salotto, addobbato interamente in onore di quella cena alla quale tecnicamente dobbiamo presenziare. Coccarde, coppe, targhe e trofei dall'aria importante e preziosa fanno da cornice in quell'atmosfera fragrante quanto altolocata; appese alle pareti, issate sulle mensole, riposte sulle teche di vetro.
Fotografie di cavalli con i loro cavalieri, in tiro sia l'uno che l'altro. Fierezza e signorilità. Fotografie nitide di gare di salto a ostacoli e di dressage, piacevoli da ammirare. Uno scoppiettante fuoco è acceso all'interno di un grande camino in pietra, rimanendo sullo stile di tutto il Club.
«Di chi parli?» le chiedo per poi seguire la linea diretta del suo sguardo inceneritore, che s'infrange dapprima sulla sinuosa effigie di Leonardo, e poi ancorarsi a quella di Ariadne, snella e slanciata. Gambe da fenicottero. Sempre incredibilmente vicini.
«Di lei» sibila Costanza fra i denti e comprendo perfettamente, senza la pronuncia di altre domande inutili.
«V-vi conoscete?» ciononostante mi ritrovo a domandarle.
«L'amichetta d'infanzia di Leonardo, colei che osò rinominarmi come La Dittatrice o la Madamigella Dispotica» mi spiega assottigliando la fessura delle iridi, oramai accese di stizza, «è sempre fra i piedi milady Ardinghelli. Non la sopporto, vorrei vederla evaporare».
Ed ecco spuntarle il cipiglio alla Cersei Lannister. Però... Margaery Tyrell e Cersei Lannister nella stessa stanza, alquanto esilarante. Anche se tutti sappiamo come sia andata a finire tra Cersei e Margaery...
«È di prassi che stia sempre incollata a Leonardo?» mi permetto di dire a bassa voce, un filo di antipatia ad attorcigliare i vocaboli, notando che anche questa sera, come la volta che siamo andati a casa sua, ella gli sta proprio a distanza di foglia d'albero. Due calamite.
«La loro amicizia è molto solida, a detta sua, quindi sì, è di prassi. Ma ora, per il bene della comunità, la vado a scollare da lui. Stranamente c'è sempre qualcosa a dividere te da lui» asserisce Costanza alzando il mento verso l'alto, postura superba e che non teme nessuno.
Pronta per partire alla carica. Pronta per affrontare di petto Ariadne Ardinghelli.
E appena Costanza si mette in marcia, lasciandomi indietro, Leonardo si muove verso di me, passo dopo passo.
Un sol fuggente attimo, ecco che la sensazione del filo spinato ritorna inesorabile a farsi sentire, come se fosse sotto pelle, intenzionata a non andarsene mai più.
"Lui ti ha baciata. Lui ti ha rovinata. Non puoi far finta di niente".
"Lo rovinerò perché correrai da lui, presto o tardi, correrai da lui come un coniglietto impaurito e glielo dirai. Gli racconterai quello che ho fatto, saprà che ti avrò contaminata. La sua Matilde... la sua piccola e dolce Matilde profanata da colui che odia di più", la sua voce rimbomba asfissiante e troppo rumorosa come se egli fosse davvero qui, a gridarmele nell'orecchio.
Serpente.
Le labbra di Leonardo si rivestono di sorriso lieto e le ferite – i buchi – iniziano a sanguinare. Che cosa ho fatto? Dio... mi sento così contaminata, infetta fino alle viscere. Malattia incurabile.
«Matilde», carezza il mio nome. Così diverso pronunciato con la sua voce, così pieno d'incanto e non trattato come nullità. «Dopo stamattina ti ho pensata tutto il giorno, per poco che non cadevo da cavallo durante la lezione. Sembrava non avere mai fine» mormora chinandosi sino all'altezza dei miei occhi, della finestra dell'animo, colui che è stato imbrattato di più.
«Oggi è stata una lunga giornata, davvero...» convengo abbassando lo sguardo, lasciando che il suo respiro carezzi i miei capelli, la mia gabbia di bambina.
Cavolo... ma la mia voce è così sofferente? Di questo passo lui capirà e io non voglio che capisca! Non voglio dare questa soddisfazione a Claudio, mai e poi mai. A costo di lacerarmi interamente dentro, a costo di sopportare l'entropia e il lento sfacelo degli organi vitali, dell'essenza di vivere.
Ha vinto con il suo filo spinato, ha vinto su di me, ma non vincerà anche con lui, non vincerà con Leonardo.
Dita gentili mi scostano la ciocca dietro l'orecchio, premura e nessuna intenzione di rovinare, dita amorevoli tracciano lo spigolo del mio viso per poi congiungerle con le labbra, schiudendone quello inferiore. Disegno un sorriso.
«Vorrei salvare le tue labbra» e Leonardo mi avvolge la vita con un braccio, incatenandomi a lui, petto contro petto, cuore contro cuore, volontà di zucchero filato, «vorrei preservare il tuo sorriso, vorrei liberare i tuoi capelli bruniti, perché si cela un colore divino sotto quella coltre di inutile rosa, vorrei togliere le catene a quelle tue iridi costellate di tormenti in petali... vorrei sottrarti alle volute dell'inverno, poiché tu fiore raro. Rosso papavero».
E mi abbandono a lui, arrendevole e con un sospiro di liberazione.
Perché dopo aver sopportato tutto quel filo spinato di altro non ho bisogno se non di zucchero filato, il suo.
«Ispireresti versi anche al più folle dei poeti» aggiunge infine mentre prende a vezzeggiarmi ciocche di capelli, infilando dita e stringendo senza fare male.
Una lacrima infida e traditrice minaccia di traboccare via dal posto che gli spetta, estremità del mio occhio.
"Rimani lì, maledetta! Ti prego...".
«Vuoi dirmi perché è stata lunga la tua giornata?» mi domanda Leonardo con quella dolcezza che forse rasenta il colpo di grazia per farmi crollare, vedendo che non azzardo risposta.
Dico "forse" perché in quell'esatto istante Costanza ritorna da noi, in faccia dipinta l'esatta copia dell'Urlo di Munch.
«Voi non potete minimamente immaginare...» parla con voce strozzata, mai sentita prima uscire dalla sua bocca.
«Cosa?» replica lui senza lasciarmi andare.
«Ariadne...» continua Costanza con le pupille allargate.
E stavolta la guardo dritta in faccia.
«Non potete immaginare che ad Ariadne piac-...».
«...Le piace Michelangelo?» la interrompo io, in cuor mio speranzosa di un esito positivo.
«No! Né Leonardo, né Michelangelo! Nessun umano dotato di un qualcosa misurabile in centimetri! A milady Ardinghelli piacciono le ragazze, cazzo... mi ha appena baciata... ha appena suggellato un bacio con me e io ho una voglia matta, disperatissima di strangolarla!».

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top