1. Graffiti
A Ila
Che non deve essere dimenticata
***
Io e Rachele avevamo marinato la scuola una mattina di settembre. Pioveva, di quelle piogge intense che lucidano gli alberi e i prati e che sono l'ultimo sprazzo dei temporali estivi.
Nella confusione della fuga sapevamo che c'era solo un posto dove eravamo certi di non incontrare i nostri genitori: la chiesa. Complesso di cemento e stucchi che rivestivano come un'armatura Made in China lo scheletro della cattedrale originale, l'interno manteneva i suoi soffitti altissimi di volte e la melodia di echi che si distorcevano a ogni passo.
Ci eravamo seduti sotto il Crocifisso Storto. Lo chiamavamo così perché il corpo del Cristo si torceva ad angolo ottuso all'altezza del bacino in modo innaturale.
Mi aveva sempre inquietato. Lo scultore sembrava aver tirato fuori dal legno un Cristo di carne. Aveva il sangue che gli scintillava contro la pelle, i muscoli cascanti e la testa piegata quasi fino a spezzarsi il collo. Quel Cristo era come Pinocchio, voleva essere un umano vero.
- La conosci la storia? - mi aveva chiesto Rachele. - Dicono che ogni anno la sua testa si abbassi e il suo corpo diventi sempre più sbilenco. Ed è vero. Una volta ho visto una sua foto di vent'anni fa, era molto più dritto, come se l'avessero appeso alla croce da poco. Forse è solo la qualità del legno che marcisce in modo particolare. O forse sono solo i peccati del mondo che gli pesano addosso. Dicono che quando la testa si sarà abbassata del tutto ci sarà la fine del mondo.
- Non me le raccontare queste storie. Le cose sante mi fanno una paura del cazzo.
Lei era rimasta in silenzio per un po'. Poi aveva detto: - È perché la fine del mondo è vicina. Lo è più di quanto crediamo.
Qualche giorno dopo se ne era andata per sempre.
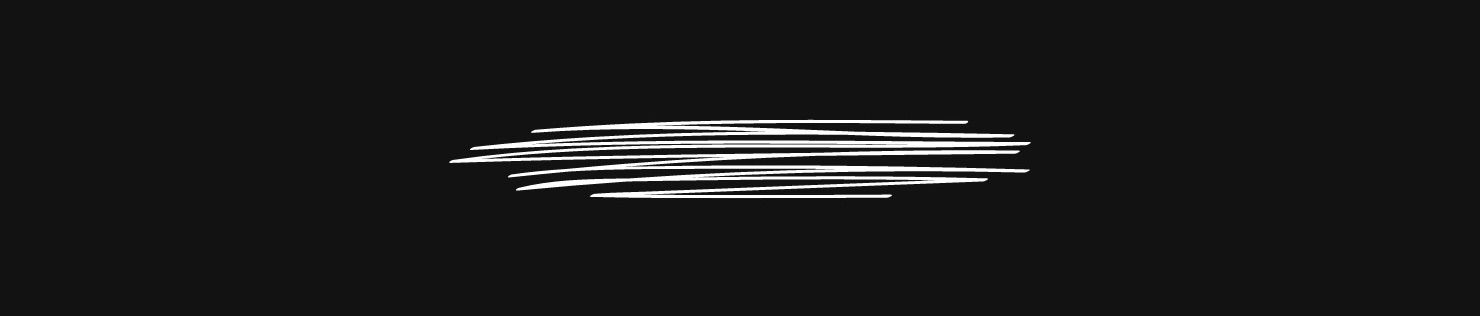
La mamma ama i miei capelli. Dice che assomigliano a delle onde.
Si attorcigliano attraverso il riflesso come alghe appesantite dall'acqua, mentre il vapore rende i contorni del mondo un po' più labili del normale.
Sembra di essere in un sogno. Il ronzio della macchinetta elettrica è una cosa che non appartiene davvero a questo posto. Neanche i miei capelli appartengono più a questo posto. Cadono a ciocche nel lavandino, in agglomerati scuri che impattano contro la ceramica.
I miei bei capelli sono un'infiltrazione di sanguisughe morte risalita attraverso le tubature.
Mi passo la mano lungo tutto il cranio, la superficie ruvida e spinosa un po' come me. Il riflesso mi restituisce l'immagine di un volto angoloso ma regolare, che ha qualcosa di sbagliato. Sono gli occhi. Occhi vecchi incastrati su una faccia giovane.
Se io incrociassi questo tizio per strada la sera, al buio, cambierei marciapiedi. Penserei che è lì lì per cacciare fuori il coltello e piantarmelo nella pancia per le cinquantamila lire che ho nel portafoglio.
Nel riflesso, la porta alle mie spalle si apre. C'è un'entità estranea che mette piede nel mio sogno. È la mamma, che ha ancora addosso la divisa del supermercato, il volto segnato da un turno troppo lungo fatto di "non ho spicci", "dove trovo gli assorbenti interni" e segrete palpate di culo da parte del caporeparto.
Mi guarda. - Sembri un bulldog - dice.
- Meglio - dico. - Così la gente capisce che mordo.

Ci sono persone che dovrebbero esercitare il sacrosanto diritto di gettare la loro vita nel cesso e tirare lo sciacquone, ma la società ti vuole produttivo, quando non ti rimpinza la testa di sogni per poi sottrarteli ridendo.
Il liceo è il mio dovere, dice la mamma, come il suo è garantirmi da mangiare tutti i giorni. Certe volte mi domando se anche lei non accarezzi l'idea di tirare lo sciacquone.
Mi rigiro nel letto in un groviglio di lenzuola che sono carta vetrata contro la pelle resa appiccicosa dall'arsura. Fuori infuria un'epica battaglia fra tortore e pipistrelli, a giudicare dal concerto che stormisce fra gli alberi.
Una luce si accende dal vialetto e il borbottio di un motore mette a tacere lo scontro notturno. Si sentono delle voci, spostati, prendi quello scatolone là, muovi quel culo secco. Oltre la finestra, nella striscia di luce verdastra che si srotola dai fari di un furgone, si muovono due ombre in controluce.
Si trovano ai piedi della villetta abusiva di fianco alla nostra. È un brutto edificio verniciato di rosa antico, l'edera stitica che si arrampica sul pergolato, la cancellata un filare di punti interrogativi di ferro arrugginito con le pance rivolte verso l'esterno.
Le ombre reggono delle grosse scatole. Una è piuttosto alta e robusta, l'altra pare quella di un ragazzo.
Perché qualcuno dovrebbe trasferirsi in questa campagna maleodorante rimane per me un mistero, ma il mio giudizio naufraga nell'indifferenza più abissale.
Chiudo le imposte e buonanotte ai suonatori, alla banda e pure al deficiente che suona l'ocarina là in fondo.

La mia bici è un drago.
La potenza della ruota motrice divora la polvere del sentiero. Ho solo una regola: mai posare le chiappe sul sellino. Bisogna sbatterle orgogliosamente in faccia a chi si aggira alle tue spalle.
Il sole è un grumo di saliva sputato nel cielo stanco, su quest'orchestra in do maggiore di cicale che si nascondono fra gli alberi e la distesa di grano.
Il lager di Monowitz è là. La scuola, l'Istituto Tecnico Agrario Statale Pier Paolo Pasolini, sorge nei campi dissestati dai trattori e dalle cacate delle vacche. Ho talmente tante storie da raccontare sulle vacche che farei notte.
Imbocco nel cortile, sgommando e terrorizzando le matricole con la forza degli pneumatici che grattano il brecciolino. Al mio passaggio, il branco di spermini si dirada come le acque del Mar Rosso. Fisso l'ingresso, la bocca dell'Inferno, con l'aria di qualcuno che ha un conto in sospeso con il mondo.
Qualcuno mi fischia dietro. È Tobia, che sta asserragliato con gli altri su quel murale che è un'opera postmoderna di cazzi.
- Ci vieni alla partita? - chiede appena mi trovo a portata di orecchio.
- Domenica ho da fare.
E dopo l'ultima sorpresa con la celere, la notte in cella e tutto il circolo bocciofilo di santi chiamati in causa dalla mamma, ho deciso di starmene buono per un po'.
- Gira voce che quelli dei Teschi Rotti stiano armando un pullman. Vogliono montare su un bel casino.
Tobia ce l'ha con i Teschi Rotti nello stesso modo in cui i Teschi Rotti ce l'hanno con i Dragoni. Sono tra le squadre di calcio più sfigate d'Italia, ma per qualche ragione nella nostra pentapoli di paesotti disseminati sugli altipiani ci piace andare allo stadio per scannarci a fine partita tra fumogeni e cori ultras.
Se devo essere onesto, del calcio me ne frega quanto dell'accoppiamento delle zanzare, ma ho pur sempre un bisogno inarrestabile di spaccare la faccia a qualcuno.
Il mio amico la chiama "la Tobi-rapia": ficcare un punteruolo nella mano di qualche stronzetto in fase prepuberale è l'unico modo che abbiamo per non sentirci dei cadaveri ambulanti.
- Il tizio con la faccetta da frocio chi è?
È un secondo. Negli occhi di Tobia si condensa una scintilla che conosco molto bene: quella del provincialotto annoiato che ha appena fiutato la traccia di una nuova preda.
Tutti ci voltiamo. Poggio Mirto è un posto piccolo, una caccola appiccicata sulla cartina, nientepopodimeno che uno di quegli orrendi microcosmi dove tutti sanno i cazzi di tutti e se il lattaio si fa la moglie del meccanico gli basta farsi un giro al bar per avere il quadro completo della situazione.
Ecco perché quando la carne fresca approda da queste parti ci tramutiamo tutti in avvoltoi in attesa che incarognisca.
Il ragazzo sfreccia verso la bocca dell'Inferno con il walkman agganciato ai jeans e le cuffie che gli tirano indietro una spolverata di capelli biondi. Pantaloni e T-shirt gli cascano addosso.
Ci passa davanti in un colpo di vento. Ha un muso da bambolina di porcellana. Mi viene da chiedermi se gli sia mai cresciuto un pelo in faccia.
Non ci guarda, come se fingere di non vederci possa in qualche modo salvarlo.
- Lo conosco - dico appena sparisce oltre le scale. - Abita nella casa accanto alla mia. È arrivato ieri sera.
- Il tizio che ci viveva non era morto? - fa Tobia, pigiando il tabacco nella cartina con la punta del pollice.
- Non saprei.
- E vi mandate i baci dalla finestra?
Ficco la mano in tasca e con l'eleganza di un prestigiatore ne estraggo il mio miglior dito medio.
Tobia ride. - Ci fumiamo una canna prima di entrare. Vieni?
- Devo prendere quel diploma di merda, e pure tu. Essere steccato una volta mi è bastato.
Tobia si ficca il filtro (un pezzo di biglietto del bus arrotolato) in bocca, roteando gli occhi. - Come ti pare, Max. Ci vediamo dentro.
Indice e medio alla tempia, li saluto e vado a incatenare la bici alla cancellata.
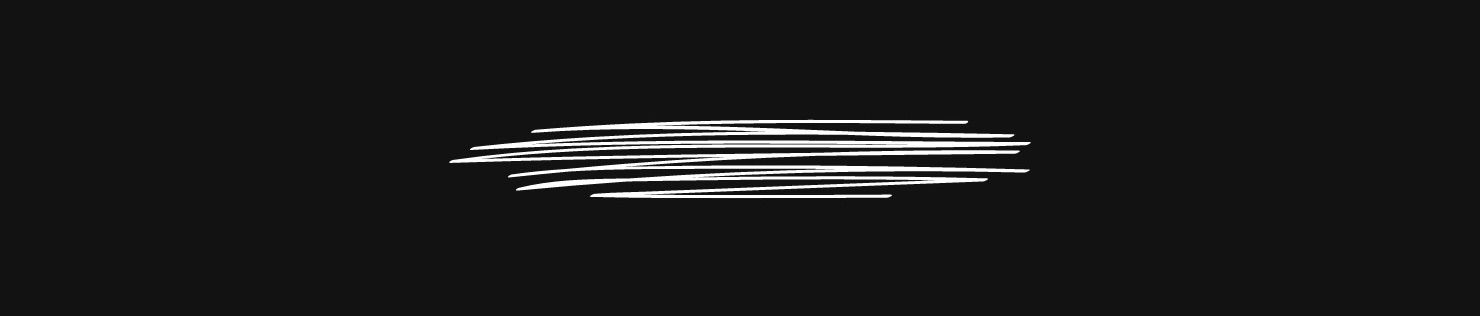
Classe, interno giorno. La Cremolini è un'inguaribile idealista, perché:
1) Ha ritenuto che insegnare letteratura in un istituto tecnico agrario fosse una buona idea.
2) La maggior parte dei suoi studenti sono campagnoli ignoranti come zappe. Probabilmente è già tanto se si sforzano di scrivere il loro nome in maniera corretta.
3) Sta spiegando Jack Leopardi.
4) Il primo giorno di scuola.
5) Convinta che qualcuno la stia a sentire.
Tobia fissa il vuoto, inebetito, e ogni tanto ridacchia tra sé. I due neuroni che abitano il vasto, desertico regno che è la sua mente staranno avendo una conversazione interessante.
Vagheggiare l'infinito dall'ermo colle con il cervello fottuto dalla THC deve essere l'ultimo stadio dell'autocoscienza.
Mi sgomita fra le costole. - Secondo te che sta facendo?
Ci metto poco a capire che si riferisce a quello nuovo. Dalla nostra postazione, l'ultimo banco della fila centrale, accuratamente scelto a seguito di complessi calcoli di triangolazione con il solo scopo di incrementare le nostre capacità di copiatura, lo scorgiamo ingobbito sul quaderno, intento ad appuntare qualcosa con frenesia febbrile.
- Scrive il diario segreto?
- La finisci con 'sta storia? Che ne sai che gli piace il cazzo? Mica c'ha un cartello al collo.
- Il tuo problema è che non hai intuito. Guardalo in faccia. Pure il nome è da frocio.
Fiore.
Un nome che mi tormenta e che cammina in bilico su una corda. Ti fa ingarbugliare le circonvoluzioni del cervello, nella sua ambiguità. Rimane a cavallo di una finestra invisibile che separa il dentro e il fuori, il maschile e il femminile.
Più lo guardo, più ho la sensazione di osservare un qualcosa che assomigli a ciò che mi aspetto di vedere. Come con i manichini o le bambole o i morti viventi, che sono umani ma non troppo.
Te li chiama dalle mani, gli schiaffi.
- Sai cos'è da frocio? Avere il radar per i froci.
Tobia mi sibila un insulto tra i denti: - Se gli metti una parrucca in testa è una ragazza.
- Può darsi.
- Vedi? Mi dai ragione pure tu.
- Lanza e Armaioli!
Scattiamo entrambi come civette addestrate (cioè, io scatto, Tobia è più sul punto di avere un prolasso cerebrale sul banco). La Cremolini ci fissa appollaiata sulla cattedra, le lunghe gambe accavallate e la massa di capelli rossicci sparsi sulle spalle. Quando la guardo mi fa pensare a una sirena mangiauomini, bella e stronza quanto basta. A volte penso che Tobia si sia fatto segare solo per poterle guardare il culo per un altro anno.
- Voi due allo stesso banco siete un errore. Ricordatevi che non voglio vedervi di nuovo qui. Armaioli, scambiati di posto con Riccardi.
L'informazione ci mette un po' ad arrivare al mononeurone di Tobia, che quando la recepisce mi scocca un'occhiata velata di feroce ironia e si alza facendo più rumore possibile con la sedia. Una spallata al ragazzino mentre ciondola verso il suo nuovo banco, poi crolla al posto con una faccia di pura innocenza che è magnetite per pugni.
Fiore Riccardi percorre il corridoio fino alla sedia accanto alla mia. Pare un animale in gabbia durante la rivoluzione dello zoo, indeciso se fuggire o meno dalla porta che è stata lasciata aperta per errore.
L'inadeguatezza alla vita, l'infanzia a puttane e una gran voglia di scopare tramutata in arte per i posteri. Io e Jack non siamo poi troppo diversi.
Fiore scarabocchia con la foga di un Baudelaire sotto assenzio. Ha le dita macchiate d'inchiostro.
... che io sia
Ciò che mi aspetto che sia.
- Che hai da guardare?
Niente. Lo guardo perché mi va. Perché se gli metti una parrucca in testa è una ragazza. Perché non me ne frega niente se la cosa lo mette a disagio, e infatti in questa tenzone epica quello che perde è lui. Il cavaliere armato di stuzzicadenti non può battere il drago.
Fiore abbassa gli occhi, indispettito, e chiude di scatto il quaderno.
A fine lezione sfreccia via come se avesse i petardi cinesi sotto le scarpe.
- Massimo.
Mi blocco di fronte alla cattedra. La Cremolini mi fissa da dietro quegli occhiali da icona della moda anni Sessanta.
- Hai un minuto?
Preferirei bere uno shot di Vetril, ma non mi va di farla incazzare proprio oggi, quindi faccio cenno a Tobia di aspettarmi fuori.
- Che intenzioni hai quest'anno, Massimo?
Solo la mamma mi chiama Massimo, e di solito lo fa quando sta per mollarmi un ceffone.
- Cioè?
- Cioè, hai del potenziale e gradirei che non lo buttassi alle ortiche come hai fatto l'anno passato. Non devi fingere di valere meno solo per compiacere gli altri. Sei intelligente, ma infinitamente stupido quando decidi di mettere in mezzo l'orgoglio.
A quel punto mi scappa una mezza risata, ma più che una risata è tipo un colpo di fucile. A giudicare dalla faccia della Cremolini devo averla centrata in mezzo agli occhi. La assecondo con un cenno: - Se non c'è altro.
La prof mi scruta per qualche secondo. Poi sospira, scuotendo la testa: - Vai.
Vado.
Non abbiamo davvero altro da dirci, se ritiene che il motivo della mia rabbia siano solo i quattro stronzi che abitano questo posto.
Possono anche andare ad affogarsi.
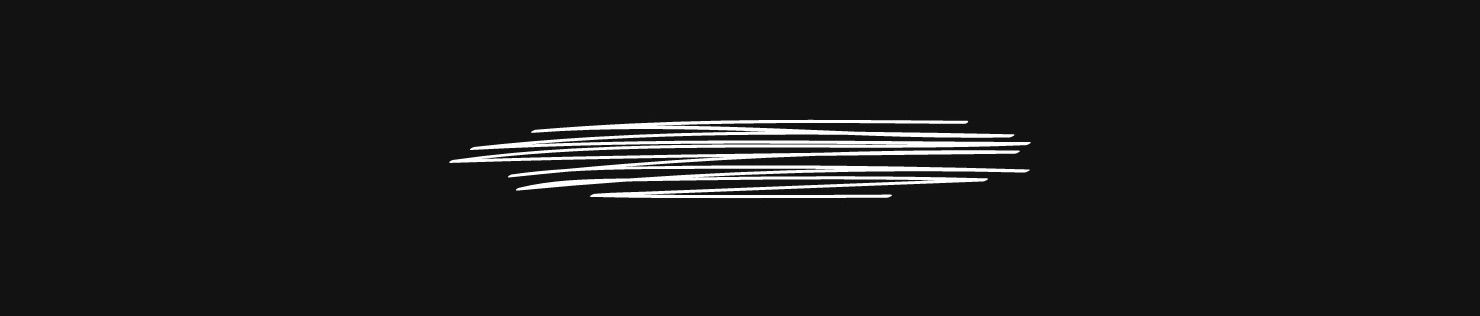
Le rovine erano il nostro regno.
Sullo scheletro del complesso industriale dimenticato nelle campagne potevamo cucire le murature di un castello, le garitte piene di soldati stremati dai turni di guardia, le torri ritorte, il ponte levatoio, gli stendardi blasonati.
Nel nostro regno si aggirano i randagi che masticano pneumatici e mangiano gli avanzi di cibo lasciati dai tossici. Qui c'è tutto quello che la gente non vuole più, gli scarti di cui si vuole dimenticare.
Io e lei eravamo la spazzatura, e qui eravamo a casa.
La fabbrica abbandonata si profila come un mostro con ciminiere e fumaioli spenti. La torre cisterna si innalza, immensa, gettando la sua ombra tra bambole rotte, auto accartocciate e divani gonfi di umidità e polvere.
La mia mano si muove agile da un lato all'altro di questa parete che è un'accozzaglia di tag scarabocchiati di fretta e poesie che non vogliono dire un cazzo, ma a quanto pare qualcuno riesce a usarle per scopare.
Mi schiaccio la bandana contro le vie respiratorie, il cappuccio come armatura a proteggermi la testa, mentre spruzzo il colore lungo la superficie.
Il suo volto non è ancora completo, ma è immenso. Coprirò tutti questi scatti di creatività che si sono esauriti in un nulla di fatto. Gli avevamo anche dato un nome: "Seghe stanche d'artista". E lo farò con qualcosa di bello, e sarà ancora più bello a confronto di un posto tanto orribile.
Dunque, eccoci di nuovo qui, faccia a faccia, io e te.
Ciao, Rachele. Si sono già dimenticati tutti di te, ma io farò in modo di rinfrescargli la memoria.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top