Chapter Thirty-Seven - Part Two: The end will come, but it won't be the end
"How can I say this without breaking?
How can I say this without taking over?
How can I put it down into words?
When it's almost too much for my soul alone
I loved, and I loved and I lost you
I loved, and I loved and I lost you
I loved, and I loved and I lost you
And it hurts like hell
Yeah, it hurts like hell"
- Fleurie, Hurts like hell
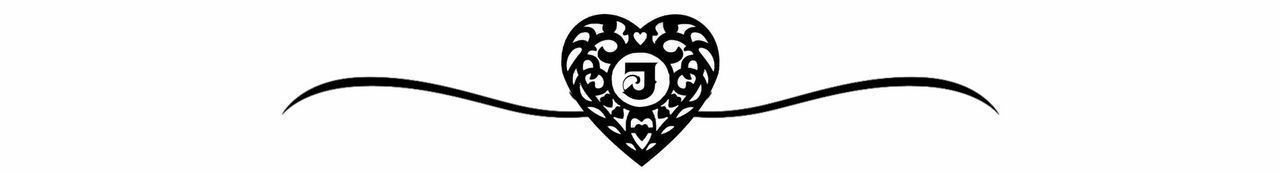
Un'ora e mezza. Questo è il tempo che Charlie mi ha detto avrebbe impiegato per arrivare sino a casa di Josephine. Novanta minuti che presto sono diventati sessanta, poi quarantacinque. Il suono del tempo che ci separa e che pian piano diminuisce sulla plancia dell'orologio ha un ché di dolce, diventa sempre più ammaliante. Il ticchettio delle lancette è una ninnananna per il mio cuore martoriato in cerca di riposo - ma resto sveglia, appollaiata su un divano in pelle che fa rumore ogni volta che mi muovo.
I miei occhi bruciano, sono ancora un po' secchi dopo il pianto fatto in bagno, eppure non ne vogliono sapere di chiudersi; perché lui sta arrivando, tra poco sarà qui.
E mentre nonna ha deciso di abbandonarsi per le braccia di Morfeo qualche stanza più in là, io passo lo sguardo dallo schermo del televisore al pendolo che gli sta dietro. Mi soffermo, faccio il conto alla rovescia per l'ennesima volta e poi torno a fissare senza grande interesse il viso di James May.
Lui parla e la sua voce rimbalza piano sulle pareti del salotto. Ogni tanto il fruscio della combustione della mia sigaretta ne copre le frasi facendomi perdere il filo del discorso - come se lo stessi seguendo! - poi torna ad accarezzarmi i timpani.
Fumo e provo a distrarmi, conscia del fatto che se mi dovessi soffermare a pensare mi ritroverei a piangere un'altra volta - perché sono riuscita a far incazzare tutti: Seth, Jace e persino Caroline, che in questa storia c'entra poco o nulla. Mi sono inimicata tutti coloro a cui voglio bene, eppure al momento non voglio assolutamente pensarci, così continuo imperterrita ad aspettare, ignorando tutto ciò che non è questa attesa.
Mentre immagino l'arrivo di Benton lo stomaco si stringe e il cuore sembra venir pizzicato. Mi umetto le labbra tirando via con la lingua il sapore del tabacco, poi le mordo e ricomincio da capo, entrando in un circolo vizioso che pare non aver mai avuto inizio e non poter trovare una fine.
Provo a supporre quale sarà la sua espressione, le prime parole che mi dirà dopo tanto tempo lontani. Cerco di ricordare i suoi vestiti, di indovinare cosa avrà indosso e quanto mi sentirò sollevata nello schiacciare il viso contro al suo petto. Sarà cambiato in queste settimane? Oppure è rimasto lo stesso di quell'ultima volta in cui ci siamo incontrati a casa di Seth? Sul suo viso si andrà a disegnare il solito sorriso sghembo, un po' imbarazzato che tanto mi piace, o a salutarmi ci sarà ancora una linea dura, severa e ben lontana dal farmi sentire tranquilla? Più ci penso, più mi agito, così alla fine butto il mozzicone e mi prendo il viso tra le mani, domandandomi per la centesima volta quanto manchi al suo arrivo.
Temo l'istante in cui saremo l'uno di fronte all'altro, impacciati a causa di tutto ciò che si è frapposto tra noi, però al contempo bramo il momento in cui i nostri corpi si sfioreranno di nuovo, trovandosi a metà strada - un po' come quel giorno in camera sua, in quel letto che ho scongiurato, solo qualche ora fa, mi accogliesse tra le sue lenzuola per placare la frustrazione.
Libero il viso, mi volto verso la finestra e dopo qualche interminabile secondo di esitazione, in cui mi domando se sia logico alzarmi adesso, decido di non poter più restare immobile ad aspettare. Il rumore lieve delle mie gambe sulla pelle del divano accompagna i movimenti che compio finché, con un sospiro, mi sollevo dai cuscini lisi. In punta di piedi, camminando lungo un pavimento terribilmente freddo, mi dirigo verso il balcone e, avvolta nel plaid colorato, mi spingo a ridosso del vetro senza però oltrepassarlo. Il respiro crea aloni lattiginosi che più volte provano a dissiparsi, ma ritmicamente vengono ricreati dalle narici, incapaci di dargli tregua - sono parte del mio conto alla rovescia, mi regalano un vago senso di pace.
Dapprima il mio sguardo va lontano, verso l'orizzonte puntellato di lampioni, insegne e lampadari privati, poi si fa sempre più vicino, arrivando all'imbocco della via da dove sono certa il maggiolone di Charlie farà la sua comparsa.
Premo le dita sulla lastra che mi separa dall'esterno, le schiaccio tanto da essere certa star lasciando il segno dei polpastrelli sudati. E aspetto.
Aspetto.
Resto immobile, premuta sul vetro, come da bambina la notte di Natale, quando piena di speranza scrutavo il cielo alla ricerca della slitta di Santa Klaus. Esattamente come allora confondo ogni luce con l'oggetto del mio interesse e, così, al passaggio di qualsiasi auto sussulto credendo che sia la sua - ma ogni volta mi ritrovo a deglutire un boccone amaro.
Il cuore accelera, poi si frena; perde il ritmo più e più volte, arrivando persino a fare male.
Dove sei?, domando a un fantasma che non può darmi risposta, seppur vorrei.
Mi giro verso l'orologio, forse sperando di trovare qualcosa di rassicurante - ma sono passati solo dieci minuti dall'ultima volta che l'ho controllato.
Charlie sarà appena entrato nel territorio londinese, si troverà da qualche parte nei pressi dell'Aeroporto di Heathrow - anche se non posso dirlo con certezza, visto che non ho idea di quale tragitto abbia deciso di fare per venire sin qui.
Ancora una volta osservo la strada, spero di vederlo comparire prima di quanto stimato, ma dopo l'ennesima manciata di minuti sprecati a fissare il nulla mi ritraggo dalla finestra, rendendomi conto che nemmeno lui può piegare lo spazio e il tempo a proprio piacimento.
Faccio un passo indietro, seppur le dita non vogliano realmente staccarsi dalla finestra, quasi avessero una propria coscienza e desiderassero restare aggrappate alla flebile speranza che una vettura tanto vecchia possa correre sull'asfalto al pari di una Ferrari - e raggiungerci prima che volti le spalle - così le assecondo ancora un po', forse gelosa della loro tenacia, ma alla fine mi decido ad allontanarle dal vetro, in modo da sgusciare in cucina e preparami qualcosa di caldo.
Con la coda dell'occhio, mentre mi faccio strada verso la stanza accanto, noto l'alone pallido rimasto a delineare i contorni della mia presenza, il fantasma di quella mano che ha cercato di trattenermi e che non avrebbe ceduto. Ci penso e mi mordo la lingua, mi punisco ancora, ma ormai sono sulla soglia del corridoio, svolto e in un attimo sono nuovamente altrove.
Accendo la luce della cappa, cerco la teiera di metallo e la riempio d'acqua quel tanto che basta per una persona, poi l'appoggio su un fornello che fatico a far partire, come sempre.
La fiamma bluastra che compare pare già essere sufficiente a scaldarmi, eppure mi stringo comunque nelle spalle mentre, un po' disorientata, cerco di ricordarmi dove nonna tenga le sue centinaia di varietà di tè.
Al primo tentativo sbaglio, ormai disabituata a trascorrere tanto tempo qui in una quasi totale solitudine, ma al secondo trovo tutto il necessario.
Prendo una bustina senza nemmeno guardare cosa vi sia scritto sopra, troppo frastornata per pensare davvero a una simile sciocchezza, la spacchetto con un'eccessiva delicatezza e poi la metto nella tazza dove un paio d'ore fa Josephine ha versato il suo intruglio al bergamotto, sperando stavolta di riuscire a godermi in totale tranquillità la bevuta.
Con il fianco mi appoggio al lavello in attesa del bollitore e intanto mi perdo a seguire un percorso immaginario tra gli arredi e le cianfrusaglie della nonna, come se le vedessi per la prima volta. Qualche foto di Jace, Liz e me spicca sul frigorifero insieme a varie calamite che le sono state regalate, mentre alle pareti piastrelle con le maioliche creano giochi di immagini floreali e psichedeliche che mi fanno totalmente perdere coscienza dello spazio che mi circonda, annullando tutti i pensieri - è il fischio lieve della teiera a farmi sobbalzare e riportare alla realtà.
Quanto tempo è passato?
Svelta spengo la fiamma, attenuo il flusso di vapore e, appena il silenzio torna a riempire la cucina, mi concedo il lusso di cercare un orologio che già so non esserci - ma certamente non saranno passati che un paio di minuti da quando ho abbandonato la finestra, non ho nulla di cui preoccuparmi per adesso. Quando si aspetta il tempo si dilata: quella che ti sembra un'eternità non è altro che un secondo. Fai decine di centinaia di cose credendo di aver ridotto l'attesa, poi invece ti ritrovi punto e a capo.
E anche per me, in questa circostanza, non sarà diverso, quindi sbuffo e torno al tè che fumante mi chiama a sé, sirena tentatrice per il nervosismo che sento aumentare con l'accrescersi della consapevolezza che Benton ormai avrà varcato le porte di Londra e sarà sempre più vicino.
Con la tazza tra le mani mi volto verso il tavolo, mi ci siedo accanto facendo scricchiolare la sedia.
Quanti chilometri gli mancheranno?
Intingo un paio di volte la bustina, provando a fingermi esperta della topografia della città e di tutte le strade che l'attraversano, ma riesco a perdermi già dopo tre incroci - se fossi stata io quella a dover correre da lui, probabilmente sarei arrivata il giorno seguente, oppure lo avrei supplicato di venirmi incontro.
Soffio sulla tazza, lo faccio un paio di volte prima di accorgermi di star sorridendo, felice. Mi piace il pensiero di rivedere Charlie: è elettrizzante e al contempo appagante, pare una soddisfazione inaspettata, una gratificazione che non avrei mai creduto di meritare - eppure arriva dopo tutta la fatica, la tensione, l'apprensione.
Sovrappensiero mi porto il bordo della ceramica alle labbra, le schiudo e bevo.
Mi ustiono.
Ancora.
Con un sobbalzo allontano la tazza dal viso, rigirandomi la lingua in bocca per farla pulsare di meno, ma non ottenendo risultato - dannazione. La mia sbadataggine non ne vuole sapere di darmi tregua, mi perseguita persino in situazioni del genere, quando il cuore è bloccato in gola e la speranza lo tiene fermo, quasi preparandolo a schizzare fuori al momento opportuno; così mi ritrovo a imprecare a fil di voce.
Mi maledico e maledico anche la decisione di bere un'altra tazza di tè pur consapevole che la giornata fosse iniziata male - e in questo susseguirsi di sibili confusi, un suono familiare cattura il mio interesse, facendomi zittire e poi voltare in direzione della soglia. Nella penombra riesco a distinguere con facilità cosa c'è nel corridoio: uno specchio a muro e un attaccapanni pieno di cappelli e sciarpe colorati, qualche piccolo quadretto appeso qua e là e poi l'ingresso, nulla più. Niente di ciò che è presente pare poter emettere suoni, men che meno vi è qualcosa che sembri essere vivo - finché un lampo chiaro mi fa ricordare della tv lasciata accesa. E James May che probabilmente avrà continuato a elogiare la sfilza di vetture provate prima della puntata di oggi a un pubblico che, in questa casa, è pressoché inesistente.
Così afferro la tazza, mi alzo in piedi e con uno sbadiglio mi trascino verso il divano che mi ha tenuto compagnia dal momento in cui sono ricomparsa dal bagno.
Stando attenta a non fare altri disastri mi faccio cadere sui cuscini, poi con la mano libera provo a sistemare la coperta e recuperare il telecomando, disperso chissà dove.
Mi pare quasi di vederlo, ma d'improvviso il suono familiare che ho sentito in cucina torna a farsi presente e, in una frazione di secondo, questa volta, riconosco la vibrazione del cellulare.
***
La porta sbatte forte, ma io non la sento. Avverto appena la vibrazione dell'aria alle mie spalle, ma attorno a me c'è solo silenzio - o almeno così mi pare al di là del fischio che inarrestabile sovrasta ogni cosa, anche i pensieri. Li mangia uno a uno, triturandoli tra i denti e inghiottendoli con foga, quasi sia troppo affamato per poter prestar loro la giusta attenzione.
Corro svelta per le scale di un palazzo addormentato, saltando di rampa in rampa così tanti gradini che se dovessi atterrare nel modo sbagliato potrei fottermi una caviglia, eppure non rallento nemmeno per un istante.
Non posso.
Non ora.
Le scarpe della nonna sono allacciate male, sento il tallone scivolare fuori ogni tre passi, ma non ha alcuna importanza, se dovesse servire correrei anche scalza.
Qualsiasi cosa per lui.
Senza rendermene conto vado a sbattere contro il portoncino d'ingresso, picchio forte il petto e per puro miracolo evito il viso, ma anche in questo caso dubito potrei sentire qualcosa più del contraccolpo. Più volte tento di tirare la maniglia nella speranza che la serratura si apra da sola, ma lei non lo fa mai, così in preda all'agitazione mi metto a picchiare il palmo su ogni tasto che trovo in giro.
Si accendono le luci dei corridoi, quelle delle scale, forse suono anche un campanello, però alla fine riesco a sbloccare questa dannatissima porta e buttarmi in strada.
Il marciapiede è deserto, oltre a me ci sono solo un signore anziano con il proprio cagnolino e le ombre non troppo fitte della sera londinese - e credo che tutti e tre si siano soffermati a fissarmi, a chiedersi da cosa stia scappano o cosa stia inseguendo.
Per un solo istante ricambio l'occhiata, conscia seppur in modo poco nitido di apparire nel peggiore dei modi al momento, poi mi riscuoto e pigiando con forza i denti nella carne del labbro mi rimetto a correre.
Devo andare.
Devo fare in fretta.
Devo arrivare prima che...
Svolto l'angolo e mi ritrovo a colpire qualcuno. L'impatto è tale che con la spalla finisco a picchiare contro il perimetro dell'edificio da cui sono appena uscita, lasciandomi sfuggire un grugnito.
L'estraneo a cui sono andata addosso sbraita, mi insulta, però non posso concedermi il lusso di ascoltarlo o di restar qui a difendermi in una qualche maniera. Ho da fare. Ciò che sto rincorrendo è più importante di qualsiasi altra cosa.
Così riprendo a muovere le gambe, forse urlandogli "scusa", o forse mandandolo a quel paese - non mi è chiaro nulla al momento, solo che ho i minuti contati, il cuore sul punto di scoppiare e un luogo in cui arrivare.
Il prima possibile.
Davanti a me ci sono due miglia di strada e persino correndo a perdifiato potrei non farcela - ma non posso assolutamente permettermi di restare ferma, di tornare a casa di nonna e fingere che la tragedia non sia alle porte.
No.
No.
No.
Con il fiato già corto inizio a guardarmi attorno sperando in una sorta di miracolo, una persona in sosta, una faccia amica, qualsiasi cosa. Ad ogni passo che compio, senza ottenere risultati, mi sento sul punto di bruciare - è come se gli organi stessero andando a fuoco, come se volessero soccombere prima di conoscere l'esito di questa notte. Però non possono, giusto?
Non hanno alcun diritto di tradirmi ora, vero?
Vero?!
Avanzo rapida tra i negozi chiusi e i passanti intenti a ridersela tra di loro, eppure nessuno pare potermi aiutare. Sono tutti a piedi, ben vestiti, sistemati per il weekend di baldoria e spesso hanno tra le mani una bottiglia di birra - non mi aiuterebbero in alcun modo, basta guardarli per capire che di una povera mocciosa come me non gliene può fregar nulla. Che io abbia bisogno di un aiuto, che sia sul punto di vomitare l'anima e impazzire a loro non interessa - sono sola con me stessa e la consapevolezza di ciò che sta accadendo.
Con i primi dolori alla milza e i polpacci che provano a sfiancarmi continuo a correre, in modo da non perdere tempo. Mi muovo come un'ossessa sull'asfalto umido di una pioggia che nemmeno mi sono accorta essere iniziata a cadere finché, quasi in risposta alle mie preghiere, scorgo una ragazza intenta a scendere da un taxi - e mi ci precipito.
Infilo un braccio nello spazio vuoto tra la portiera e la vettura, lascio che mi venga schiacciata un poco e poi, con gli occhi sgranati, probabilmente simili a quelli di un pazzo, dico: «Mi serve.»
Lei è sconvolta, quasi si spaventa nel vedermi comparire al suo fianco, però non osa pronunciare nemmeno mezza sillaba, come se nel profondo riuscisse a comprendere qualcosa, a intravedere il fantasma della paura che mi lambisce le interiora dandole alle fiamme.
Salgo.
«Queen Charlotte's and Chelsea.»
Il taxista mi guarda dallo specchietto retrovisore. Esita.
«Ho detto Queen Charlotte's!» Ringhio, i denti digrignati al pari di un animale rabbioso.
Parlo forse ostrogoto?
Non vede in che condizioni sono?
Non comprende la gravità della situazione?
Fa un movimento con la mascella, probabilmente sta masticando un chewing-gum: «Hai i soldi, ragazzina?»
Corrugo la fronte, sempre più allibita.
I soldi?
Sì, io...
I soldi, certo.
Con foga inizio a toccarmi i fianchi, dove mi accorgo non esserci alcuna tasca e men che meno una giacca - figurarsi se mi sono ricordata di prendere la borsa! -, poi nel contorcermi inizio a premere i polpastrelli sulle cosce e qualcosa, lì, scricchiola: dieci sterline.
Me le alzo di fronte al viso. Tronfia di una futile speranza le osservo insieme all'uomo sui sedili anteriori, che ancora mi studia dai suoi dieci centimetri di specchio, poi comprendo il loro reale valore - e mi maledico: non servono a nulla, penso. Con questa cifra al massimo posso arrivare alla prossima via, ma non certo farmi scarrozzare per due miglia. Il nodo che ho in gola si fa più spesso e di conseguenza gli occhi iniziano a bruciare. Con la bocca già impastata di un pianto che non riesco a fare supplico il signore di mezza età che ho di fronte: «La prego.» Il labbro trema appena, ma mai quanto la voce: «Io... io so che non bastano e... beh, mi accontento anche di qualche chilometro ma... davvero, la sto pregando.» Persino le viscere sembrano venir scosse. Per un istante il loro contorcersi si arresta e in un sollievo inesistente permette loro di soccombere a uno spasmo, facendole mugolare: «E'...»
Non riesco a dirlo.
Forse non mi va di farlo.
«La scongiuro.»
Lui mi fissa ancora qualche istante, poi afferra la banconota.
«Queen Charlotte's and Chelsea, hai detto?»
Annuisco, sorpresa da questo atto di misericordia che non mi sarei mai aspettata da uno sconosciuto intento a lavorare, che rinuncia alle sue cinquanta sterline o a rientrare a casa prima per aiutare me.
Il taxi parte e mentre mi metto composta accanto al finestrino, continuando però a torturarmi mani e labbro, sento l'uomo farmi un'altra domanda, un quesito che mi spiazza. La sua curiosità mi schiaffeggia con una brutalità tale d'improvviso mi rendo conto di quanto questa situazione sia reale, concreta e spaventosa.
«E' qualcuno di caro?»
E' ben oltre questo.
Premo i denti con un po' più di forza e il labbro si rompe, il sangue mi pizzica la lingua, scende in gola, mi nausea.
Non è semplicemente qualcuno a cui tengo, è qualcuno senza cui dubito potrei continuare a vivere normalmente.
Annuisco.
«Lui è...» però mi fermo. Lascio la frase a metà, piena di tutto e al contempo di niente.
Ho paura di quello che potrei dire ora.
Sono conscia del fatto che adesso, a questo estraneo, potrei confessare qualcosa di terribile e pentirmene per sempre, in caso le cose dovessero andare male.
Il taxista nuovamente mastica il chewing-gum: «Capisco» afferma dopo qualche secondo di silenzio - e il motore, d'improvviso, romba un po' di più.
Chissà se è vero. Chissà se realmente può capire ciò che sto provando adesso, se in questa merda c'è passato a sua volta. Chissà se invece lo ha detto giusto per provare ad alleviare il mio male, per creare un'empatia inesistente o anche lui, in una notte fredda e già claudicante, ha ricevuto una coltellata come questa, sentendosi lacerare le carni.
Chissà se c'è stato anche per lui un Jace che con voce spezzata e il fiato corto l'ha supplicato di correre al Queen Charlotte's and Chelsea Hospital, perché "c'è stato un incidente. Charlie..."
Premo le unghie così forte nei palmi delle mani che la pelle cede, mi taglio.
Charlie ha avuto un incidente.
Charlie si è schiantato.
La mia mente sembra non poter più concepire altro, solo "ed è colpa tua".
Perché è così.
Stava tornando da me.
Lui stava correndo lungo l'asfalto, sfidando il tempo, per raggiungere me.
E ha perso il controllo del maggiolone.
Per i venti minuti che ci separano dall'ospedale l'autista tace - solo la mia coscienza grida e mi graffia le orecchie; piange le lacrime che io non riesco a versare e rende questo abitacolo un amplificatore per il mio dolore. C'è solo lei a tenermi compagnia - ma vorrei che stesse zitta. Vorrei che ogni cosa tacesse, che le lancette dell'orologio tornassero indietro e che durante quella fottuta chiamata, prima che la linea ci tradisse, io mi fossi soffermata a dire: "fai con calma, ti aspetto. Mi raccomando stai attento". Invece non l'ho fatto.
E forse non ne avrò più modo.
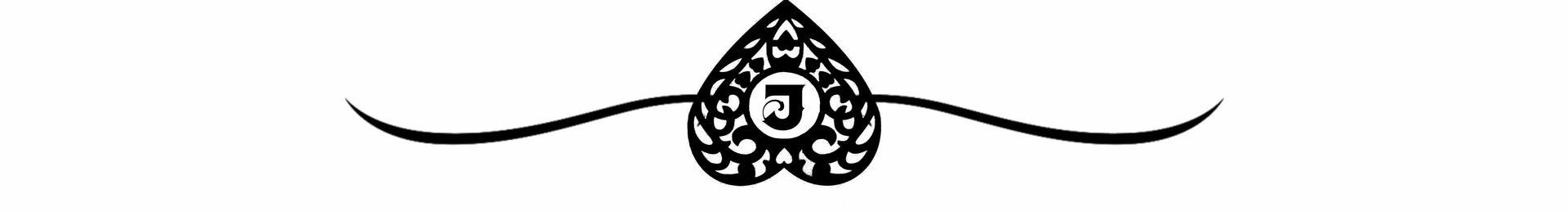
Fine
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top