Vuoto. Pieno.
Il pieno e il vuoto si succedono, come interstizi di silenzio tra i rintocchi di un orologio.
La vita degli esseri umani si riduce a questo, in fondo: un gioco di pieno-vuoto.
Bianco-nero.
Lo stesso battito del cuore è una metafora che riassume il ritmo dell'esistenza.
Bum. Bum.
Pieno. Vuoto.
E poi l'ingranaggio all'improvviso s'inceppa. Un minuscolo granellino di volontà non diverrà la perla preziosa tra le valve di un'ostrica gelosa, ma la sferetta impazzita di una roulette.
Entropia.
Qualcosa d'imponderabile. Disatteso. Pericoloso.
Da quando ho memoria, ogni mio gesto si è tradotto nello sforzo convulso di frenare la sferetta, spazzare via il granello, arrestare la roulette; sentimenti compressi e legati più stretti di uno shibari rituale.
Non pensare e non cedere mai. Assumere emozioni in dosi modeste, come certi farmaci che fanno ciò che promettono ma, se presi in soluzioni sature, ti uccidono come il più impietoso dei veleni.
È stata una scelta autonoma: quella della bambina che non trovava risposta all'unica domanda che tu non debba mai farti. Perché sono viva? Quella della bambina che nel dubbio preferiva morire di fame.
E riempirsi di cose che svuotano.
Dovevi essere una di quelle cose, accontentarti del pezzettino di me che ti avevo offerto, avevo scelto la parte più dolce. Ma tu non ti accontenti, mai.
Scavi, scavi, scavi.
Sotto, dentro, più giù.
Miliardi di neuroni compongono la mente umana e tutti riescono a farsi fottere da una persona sola.
«Cosa ci hai trovato là sotto?»
«Fà finta che io non esista.»
Ho vissuto con il cuore muto e con gli occhi chiusi sino al giorno in cui le tue parole hanno invaso gli interstizi di silenzio, facendoli assottigliare sino a sparire; la roulette ha cominciato a girare quando ti ho incontrato. La mia mano non era in grado di fermarla, pur volendo. E sinceramente credo di non averlo voluto mai davvero.
«Ho finto fin troppo.»
Costruiscimi un tappeto di favole comode da calpestare e utili ad andare avanti. La verità non serve davvero a nessuno, se fa male.
«Cosa hai trovato là sotto?» ripeto, insisto. «Dimmi la verità.»
Abbassi lo sguardo, ti avvicini, tremo. Labbra che sfiorano punti che appartengono a te soltanto; non sei capace di accontentarti dei pezzettini, tu conquisti territori. Il tuo odore mi arriva prima del filo delle tue labbra in quel punto tra il collo e la spalla. Una fragranza leggera, che stuzzica piano, potrei immergermici dentro per ore - ininterrottamente. È come la fine di un lungo viaggio, è come tornare a casa - inspiegabilmente.
Il problema è che a volte la verità non esiste. Uno tenta di convincersi che ha qualche certezza, qualche punto fermo, qualche postulato fondamentale e inamovibile: poi si sveglia da quel gran bel sogno che è l'innocenza e annega in un oceano di grigio. Esattamente. Niente bianco e nero e limiti netti e confini definiti. Solo un magma informe e monolitico, qua e là spruzzato di rosso.
La verità dei guerrieri e dei mercenari, dei disperati e dei cani sciolti è semplicemente un sistema di obbedienze dovute al padrone. Sissignore e assensi comodi. Un non pensare persistente, perché se il tarlo del dubbio cominciasse a erodere la libertà dell'obbedienza, allora si innescherebbe un circuito di autodistruzione.
La legge di conservazione, in fin dei conti, impone un capo chino: a guardare il sole in modo troppo diretto, del resto, la retina si brucia.
Il problema, fondamentalmente, è l'abitudine. Anche quella, con il tempo, diventa una specie di nostalgia. Uno tenta di combatterla in qualche modo, ma nel momento in cui se ne accorge è già finito. Tutto qui. È finito perché quando s'innesca l'abitudine vuol dire che gli anelli della catena sono già stati tutti disposti ad arte, attorno al collo: e chiunque possa tirare uno strappo deciso può pure chiamarsi padrone.
Il problema, fondamentalmente, è che di abitudine ti ammali. Lo fai fino al punto di guardare quella catena e di non avere neppure il coraggio di frantumarla. E dire che sarebbe quasi facile, in fin dei conti.
Oppure, molto semplicemente, è un'altra bugia pietosa che ti racconti per nascondere il collare che porti con vergognosa fierezza.
«Rispondi.» imperativo che stride con tutto, con ciò che sono, con la paura che trapela dalla voce, con gli occhi sbarrati dal terrore di perderti e di perdermi.
«Fà finta che io non esista.»
«Sono stanca di questo gioco. Non mi riesce più.»
Mi sono svegliata al buio.
Ai miei piedi, tutte le maschere che avevo indossato in trent'anni.
L'ultima e la prima portavano lo stesso nome – il mio.
«Cosa pensi che abbia visto?» velo di rabbia, si incunea tra noi come una lancia nel costato.
Noia, asimmetrie, nulla che ti piace.
Non rispondo. È pericoloso dare per scontati i tuoi pensieri, l'ho imparato a mie spese. Conti in tasca emozionali, li detesti. Quindi taccio.
Ma non basta, forse è tardi. Prendi il cappotto, lo spazio tra noi si colma di lontananza. Mi viene da pensare che ero meglio prima, quando mi negavo il diritto di apparire fragile e il calore di un tuo abbraccio.
Tu credi che il silenzio renda forti, invece amplifica i piccoli terrori che ci invadono ogni giorno. Anche tu hai paura, lo sento anche se non lo dici. È soprattutto il timore di fallire a farti male, il timore di spegnerci senza la certezza di avermi protetta e salvata davvero. O almeno così mi piace pensare.
«La verità è che siamo rette parallele tu ed io, Reky.»
Ti fermi. Ti volti. Ti fai male da solo a pensare che questa sia solo una mera fantasia innocua e senza ritorno.
«Ma sai cosa?»
Eccoli, i tuoi occhi quando si accendono sono un concentrato di spettacoli pirotecnici. Attesa. Vuoto.
«Facendoci incontrare, il destino ha dimostrato che nemmeno lui crede a Euclide.»
Sorridi. Pieno.
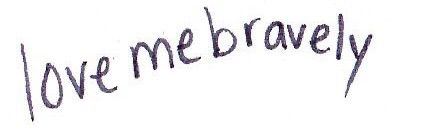
Non posso far finta che tu non esista, ma posso far finta di essere almeno un po' speciale per meritarti un po'. Ma questo, se ancora lo vuoi, te lo spiego meglio sabato.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top