Ishin-denshin
Capirsi senza parlarsi
Una settimana dopo la scomparsa di Marco, a scuola.
In molti si sono riuniti all'angolo fumatori, ammassati vicino la ringhiera e stretti in cerchio, come se stessero pregando. Bertolt ha la schiena adagiata al muro, in un angolo, così da attirare meno l'attenzione, e osserva gli occhi lucidi di Jean.
Di solito il compagno di classe ha sempre la battuta pronta, invece oggi stringe una cicca spenta nella mano tremante e tiene lo sguardo basso. Accanto a lui, Connie e Sasha tengono lo guardano con le labbra accartocciate in un broncio. Quando a quest'ultima brontola lo stomaco, nessuno la rimprovera per la sua golosità. Sembra che il lutto abbia cavato la lingua di bocca a tutti loro.
Armin, Mikasa ed Eren sono di fronte agli altri tre, però nessuno di loro ha il coraggio di dire qualcosa.
Christa digita qualcosa sul cellulare – ogni tic, tic, tic dei polpastrelli sulla tastiera irrita Bertolt – e pare fregarsene di tutto, ma sa che è una reazione al disagio che le crea quella situazione. In mezzo a Reiner e all'altra ragazza, Ymir aspira avide boccate dalla sigaretta, tuttavia nessuna parola, né sarcastica né confortevole, lascia le sue labbra. Reiner ha le braccia incrociate al petto e gli occhi enormi, vuoti, dispersi in chissà quale meandro della propria mente.
«Reiner» lo richiama Bertolt, ma l'altro non sbatte nemmeno le ciglia.
«Reiner.»
Non riceve alcuna risposta. Soltanto Armin solleva lo sguardo per studiare Reiner, ma lo distoglie dopo qualche secondo. Gli altri si sono accorti dell'atteggiamento dell'amico, ma, ignorando quale sia la verità, lo hanno attribuito allo shock della scoperta.
«Non avrebbe avuto motivo di farlo...» sussurra Jean ad un tratto e spezza la quiete a cui tutti si erano abituati, «perché avrebbe dovuto andarsene di casa? Senza dire niente a nessuno?»
Tutti gli puntano gli occhi addosso, mentre il ragazzo fa vagare gli occhi su tutti i presenti. Solo Reiner non ha ancora alzato il capo – sarà per questo motivo che Armin gli ha lanciato un'occhiata?
«Magari ha litigato coi suoi?» propone Connie, ma Jean scuote con veemenza il capo, quasi se lo volesse scrollare dal collo.
«Impossibile. Marco non litigava mai con nessuno. Mai»
«Forse... Forse ha incontrato qualcuno lungo la strada che gli ha fatto del male?»
Bertolt quasi soffoca nella sua stessa saliva, quando Sasha azzarda quell'ipotesi. Ha indovinato, pensa, mentre deglutisce di nuovo e spia con la coda dell'occhio Reiner, per studiarne la reazione. Nulla. Si è estraniato così tanto, che pare si trovi su un altro pianeta.
«Dici al ritorno dal ballo?» Christa ha finalmente scollato gli occhi dal cellulare e fissa la compagna di classe.
«Perché proprio al ritorno dal ballo?» chiede Ymir e si volge verso la ragazza accanto a lei, poi picchietta la cenere della sigaretta.
«No, impossibile» le interrompe Jean, «non al ritorno dal ballo, ma durante il ballo.»
«In che senso?» borbotta Eren, che s'infila le mani nelle tasche dei jeans.
«Noi due... avremmo dovuto vederci negli spogliatoi, però, quando sono andato lì, non ho trovato nessuno. Nulla. Era come se si fosse dissolto nel nulla.»
Devo ancora parlargli risuona la voce di Marco nella testa di Bertolt. Ecco a chi si riferiva, quando quello aveva detto quelle parole. Stava parlando di Jean, perché loro due... Si porta una mano allo stomaco, quando una fitta lancinante lo trapassa. Percepisce un peso sul fondo della gola, stessa sensazione che prova quando è in procinto di vomitare.
Perché Reiner ha insistito per unirsi al gruppo, oggi? Non dovrebbero stare accanto a loro, dato quello che è successo. È come prendersi gioco del loro dolore.
«Quindi pensi che qualcuno gli abbia fatto del male mentre era a scuola? Non prima o dopo?» domanda Armin, i cui occhi scrutano Jean e ogni minimo gesto che questo esegue.
Jean si porta una mano sulla nuca, la gratta, poi annuisce e sospira. Sasha gli appoggia una mano sulla spalla e la accarezza per dargli conforto.
«Perché non pensate che sia successo prima di arrivare a scuola?»
Mikasa non batte nemmeno le ciglia, quando pone quel quesito. Non sembra umana. Le labbra ritte non si scostano di un centimetro, dopo che le ha richiuse, e gli occhi ebano sono fissi su Jean, che abbassa il capo.
«Perché mi aveva avvisato che era appena arrivato a scuola, quando ha smesso di rispondere ai miei messaggi.»
Cala il silenzio dopo che Jean rivela quel dettaglio. A parte Reiner e Jean, che tengono lo sguardo abbassato, i presenti cominciano a lanciarsi occhiate intorno. Bertolt nota che Armin fissa Reiner con insistenza e quel dettaglio non gli piace affatto.
«Pensate...»
Sasha si morde il labbro inferiore, interrompendosi. Tutti le hanno messo lo sguardo addosso, però, dato che ha richiamato la loro attenzione.
«Cosa, ragazza-patata?» la sollecita Ymir e Sasha arrossisce, poi oscilla la coda di cavallo e gesticola per spiegarsi.
«Io, be', ecco! Pensavo e se... e se fosse stato qualcuno della scuola a fargli del male?! Magari qualcuno geloso! O che ne so! Un professore pedofilo! Qualcosa così!»
Armin si prende il mento tra l'indice e pollice, socchiudendo le palpebre. Christa attorciglia una ciocca di capelli biondi attorno l'indice e si volta verso Ymir, la quale ha aggrottato le sopracciglia.
Eren e Mikasa hanno sbattuto un paio di volte le sopracciglia e, se il primo ha incassato il capo nelle spalle, la ragazza ha di nuovo assunto un'espressione neutrale.
«Dai, ragazzi! Non lo penserete davvero!» esclama Connie, che incrocia le braccia al petto e inclina la testa di lato, per squadrare meglio le espressioni degli altri.
Invece sì, lo sospettano davvero realizza Bertolt, dopo che nessuno replica il contrario. Non li biasima: soltanto uno stupido non prenderebbe in considerazione quell'ipotesi. Hanno agito d'impulso quella sera e, se avessero avuto la mente lucida, avrebbero sfruttato il cellulare di Marco per destare meno sospetti, invece lo hanno distrutto appena ne hanno avuto la possibilità.
«Chiunque sia stato... la pagherà.»
Non è stato Jean a pronunciare quelle parole, né Eren, né Connie o Ymir. Quella frase carica d'odio è stata pronunciata da Reiner, che adesso stringe i pugni fino a farsi sbiancare le nocche. Sul collo ha persino una vena che pulsa e ha contratto la mascella dalla rabbia.
Bertolt dischiude le labbra, le richiude e inghiotte un sospiro. Qualsiasi cosa direbbe, sarebbe inutile, crede. Quello che ora ha gli occhi lucidi a causa delle lacrime è il vecchio Reiner, quello che piangeva quando Porco lo prendeva in giro. Di certo è ignaro di quello che è successo la notte dell'omicidio. Se solo sapesse che è stato proprio lui a uccidere Marco. La mente dell'amico si disintegrerebbe all'istante nel momento in cui ne prenderebbe atto.
Bertolt infila le mani nella tasca enorme della felpa, affinché gli altri non possano vederle, e si conficca le unghie nei palmi delle mani. Le fitte di dolore che percepisce lo rilassano, ma non sono abbastanza da annebbiargli la mente. Ha bisogno di soffrire di più.
È indeciso se andarsene o meno senza Reiner, ma, quando vede quest'ultimo avvicinarsi a Jean, rimane impalato sul posto. Bertolt percepisce la lingua secca, mentre osserva Reiner stringere la spalla di Jean.
«Lo ritroveremo. Non preoccuparti. Marco è un ragazzo in gamba, starà bene.»
Il labbro inferiore di Jean trema, poi Reiner gli circonda la vita con il braccio, in un abbraccio goffo e storto. Jean gli lascia una pacca sulla schiena e ricambia il gesto. Adesso sono spalla contro spalla. Bertolt percepisce un nodo all'altezza della gola, che gli impedisce di deglutire. Sono schifosi come le blatte che strisciano fuori dai sacchi dell'immondizia.
«Grazie, Reiner» sussurra Jean, che poco dopo scioglie la presa. Reiner accarezza un po' la spalla del ragazzo, prima di staccarsi.
Il trillo della campanella si diffonde nel cortile, ricordando loro che la giornata non è ancora finita. Eren, Mikasa e Armin afferrano gli zaini abbandonati ai loro piedi e se li infilano in spalla. Senza dire nulla, Ymir inforca il proprio e quello di Christa, che si è avvicinata a Jean per accarezzargli il braccio e mormorare un "ciao". Le due ragazze sono le prime ad andarsene, seguite da Eren, Armin e Mikasa. Jean scuote il capo, poi mogio si defila. Sasha e Connie rimangono qualche minuto indietro, dopodiché sbarrano gli occhi e corrono dietro a Jean. Non hanno capito che li ha lasciati di proposito indietro.
«Aspetta! Aspettaci Jean!» grida Sasha mentre svolta l'angolo.
Reiner è rimasto al suo posto e osserva il punto in cui Jean è sparito. Ha le palpebre socchiuse come se stesse riflettendo. Bertolt sospira e si avvicina all'amico. Sicuramente l'altro è perso nei meandri della propria mente – ancora – e nemmeno ha realizzato che la campanella è suonata. Gli sfiora la mano con le dita, ma niente muta nell'espressione di Reiner.
«Reiner» lo chiama.
Allunga la mano per stringere quella dell'altro ed è allora che ottiene un segno: Reiner ritrae il braccio di scatto e si allontana. Nonostante ciò, Reiner si ostina a non guardare Bertolt.
«Che state facendo?»
Bertolt sobbalza e si volta, quando la voce anonima pone quella domanda. Annie solleva un sopracciglio e si mette una mano sul fianco, mentre lo scruta. Che imbecille, pensa, dopo che la riconosce.
La ragazza non stacca gli occhi dai suoi, finché un rantolo non sfugge dalle labbra di Reiner ed entrambi si voltano ad osservarlo. L'amico è impallidito, sebbene adesso abbia spalancato le palpebre e stia fissando Annie sorpreso, come se le fosse spuntata una seconda testa.
«Dove sono gli altri?» domanda Reiner e il cuore di Bertolt si stringe. Se non lo ricorda, chi era il Reiner che prima ha consolato Jean, allora?
«Sono andati via. È suonata la campanella» spiega, ma Reiner sfarfalla le ciglia. Pare che non sia convinto della risposta che gli ha dato.
«Con chi eravate?» borbotta Annie, le cui labbra si incurvano verso il basso.
Reiner si volta verso di lui e Bertolt sospira per l'ennesima volta, dato che tocca a lui parlare. Odia essere al centro dell'attenzione. Si asciuga i palmi sudati sulla felpa, poi comincia ad elencare:
«Ymir, Christa, Jean, Sasha, Connie, Armin, Mikasa... Eren.»
Annie stringe la mano sinistra in un pugno. Bertolt chiude le palpebre e solleva appena le braccia, convinto che lei stia per colpirlo – di nuovo –, ma quando sente lo schianto della pelle contro una superficie solida, riapre gli occhi. La ragazza ha tirato un cazzotto al muro e sbatte le ciglia, spaesata forse dalla sua reazione, prima di corrugare le sopracciglia. La cravatta che indossa adesso penzola storta, a causa del movimento brusco che ha compiuto.
«Non eri stato tu» sibila, rivolta a Reiner, «a dire che avremmo dovuto dare poca confidenza ai nostri compagni? Che cazzo stai facendo?»
Annie rivolge un'occhiataccia anche a Bertolt. Anche lui è colpevole di quella situazione, lo sa bene, perché non frena l'impulsività di Reiner. Abbassa lo sguardo e si accarezza la nuca con la mano. È proprio un essere inutile.
«Lo so bene cos'ho detto. Ma volevo sapere se sospettavano qualcosa. O di qualcuno. Come faccio a scoprirlo, se non parlo con loro?»
Reiner contrae la mascella e stringe i pugni all'altezza dei fianchi.
«Smettila di prendermi per il culo, Reiner. Non parlo solo di oggi. Mi riferisco anche a Bertolt e Armin. O dell'estate scorsa, quando vi siete attaccati al culo di Eren. Questo ti sembra dare poca confidenza alle persone?!»
Annie e Reiner stanno litigando di nuovo. La schiena di Bertolt aderisce alla ringhiera grigia. Prima osserva la ragazza, poi il ragazzo e respira piano, come se temesse di disturbarli.
«Perché tiri fuori questa discussione ora? Perché stai dando la colpa solo a me e a Bertolt?! Come se anche tu non andassi in giro con Armin!»
La risposta di Reiner fa ammutolire Annie, la quale spalanca gli occhi e si volta verso Bertolt. La ragazza stringe le labbra e questo gli è sufficiente per capire che lei è arrabbiata con lui. Ha pensato che fosse un'informazione innocente da condividere con Reiner, ma si è sbagliato. È stato ingenuo, poiché si ostina a fidarsi delle persone.
L'idea di isolarsi da tutti – persino da Reiner, che gli è sempre stato accanto –, però, la teme più della rabbia di Annie. Bertolt non sa come quest'ultima riesca a gestire la solitudine, mantenendo segreti che, con alte probabilità, si porterebbe nella tomba se questo significasse salvaguardare gli altri. È lui quello debole.
«Mi dispiace... Mi dispiace, Annie... Scusa» mormora, ma la ragazza scuote il capo e schiocca la lingua contro il palato.
«Dovevo aspettarmelo da te» borbotta lei. Il tono è privo di astio, piatto, eppure quelle parole a Bertolt fanno male come un coltello che gli penetra nella carne. Dovevo aspettarmelo da te. Perché è questo quello che si aspettano tutti da lui: che acconsenti e riferisca.
Le lacrime gli pizzicano gli angoli degli occhi, ma tira su col naso e stritola le bretelle dello zaino per impedire loro di scendere.
«Scusa...!» strilla e, prima che gli altri due possano fermarlo, si ritrova a correre nel cortile della scuola.
«Aspettami, Bertolt!»
Mentre corre via da Reiner ed Annie, Bertolt si ripete un'unica frase in mente:
"Devo sparire."
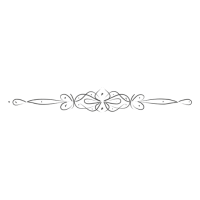
«Spero che tu sia soddisfatta.»
Reiner ha incrociato le braccia al petto e ha aggrottato le sopracciglia. Ha assunto quell'aria da duro che Annie detesta. Se avesse tempo, potrebbe persino prendere a pugni in faccia l'altro – così, forse, ritornerebbe in sé una volta per tutte e lei e Bertolt avrebbero un peso in meno sulle spalle.
«Ho soltanto detto la verità.»
Le dispiace che Bertolt abbia reagito in quel modo, perché non era sua intenzione offenderlo, tuttavia non si scuserà con lui per quello che ha detto. È stata colpa sua fin da principio: avrebbe dovuto tenere per sé quell'informazione, dato che qualsiasi cosa venga riferita a Bertolt, di conseguenza la saprà anche Reiner.
«È ironico detto da te. Ancora gli tieni nascosta quella cosa, vero?»
Annie smette di respirare e si morde l'interno della guancia, cosicché Reiner non abbia la soddisfazione di vedere l'espressione del suo viso mutare. Reiner scuote il capo, poi lo gira a destra e guarda oltre la ringhiera – come se fosse talmente schifato da lei da non volerla osservare in volto.
«Marcel avrebbe voluto che lo sapesse, lo sai meglio di me. Perché ti ostini a nasconderglielo? Più passa il tempo, più...»
«Smettila di sparare cazzate» lo rimprovera e Reiner si morde il labbro inferiore, mentre la sua fronte è attraversata da rughe sottili.
Ad Annie formicola la fronte e si pinza la radice del naso per alleviare quella sensazione. Non vede l'ora di tagliare quella discussione, tornare a casa, prendere del paracetamolo e infilarsi sotto le coperte. Se potesse, dormirebbe tutto il giorno e tutti i giorni, cosicché non debba più vivere quell'esistenza insostenibile.
«È un pessimo momento per parlare di me e Marcel a Bertolt. Dobbiamo concentrarci su come salvarci il culo, non creare altri problemi. Se già ha reagito così per quello che ho detto prima...»
Annie s'interrompe, lasciando all'immaginazione di Reiner il seguito. Non riesce a comprendere come Reiner possa preoccuparsi di quel piccolo segreto, quando tutti e tre – no, cinque, se conta la complicità di Porco e Pieck – camminano sul filo del rasoio. Mentre lei è agile, gli altri due sono goffi e questo non li aiuta a tirarsi fuori dal casino in cui si sono cacciati. Se ripensa al volto tumefatto di Marco, alle sue membra che venivano masticate dalle zanne dei cani...
La ragazza sospira e scrolla le spalle, cosicché i brividi che le attraversano la schiena si plachino.
«Perché dovremmo salvarci il culo?»
Si toglie la mano da davanti il volto e scruta Reiner, per capire se la prenda in giro. Dalla smorfia in cui si sono arricciate le labbra dell'altro, però, Annie intuisce che il ragazzo sia serissimo. Un altro vuoto di memoria conclude lei, mentre digrigna i denti.
Reiner sta peggiorando. Invece di provare pena per lui, lei percepisce la bile ribollirle nello stomaco e salirle in bocca, dove la ricaccia giù con un singulto – altrimenti la sputerebbe in faccia al ragazzo che ora le sta di fronte.
Mentre tutti loro affrontano le conseguenze delle loro azioni e il senso di colpa, Reiner dimentica, neanche qualcuno gli cancellasse i ricordi come le onde cancellano i disegni sulla sabbia.
Annie si avvicina a Reiner, il naso che sfiora quello dell'altro, e gli afferra la camicia a quadretti neri e rossi per strattonarla.
«Perché noi abbiamo ucciso Marco» sibila lei e scandisce ogni parola che pronuncia, affinché resti impressa nella mente di Reiner.
«Che cazzo dici?!» sussurra il ragazzo, che le afferra i lembi della giacca nera e li stritola.
«Chiedi a Bertolt, se a me non credi, idiota.»
Annie lo lascia andare e si allontana di qualche passo. L'alito pesante di Reiner le ha dato la nausea – o è tutto di quel ragazzo che le stimola il vomito?
Reiner ha il respiro pesante e le mani gli tremano dal nervosismo. Forse da lì a poco avrà una crisi, a cui Annie, tuttavia, non vuole assistere. Non sono amici, sono soltanto due disgraziati che hanno un destino comune, quindi non si sente in colpa quando gli dà le spalle e si allontana a passi veloci.
«'Fanculo» borbotta tra sé e non sa se lo indirizza a Reiner, a sé stessa, oppure alla situazione in cui si trova.
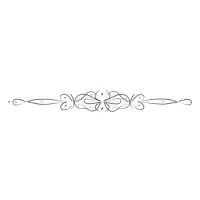
Qualche ora dopo, casa degli Hoover.
Quando rientra a casa, Bertolt fa in modo che la serratura scatti piano, cosicché suo padre non si accorga di lui. Accompagna la porta al telaio, poi appoggia lo zaino sul pavimento, accanto al cassettone a destra della porta d'entrata.
Sul mobile c'è la cornice in cui è racchiusa una foto di sua madre. Bertolt sospira e accarezza il portafoto, mentre osserva gli occhi verdi della donna. Suo padre gli ha sempre detto che ha preso da lei gli occhi e la carnagione. Sono l'unica eredità che lei gli ha lasciato, ricordi a parte.
La luce nel soggiorno si accende e Bertolt sobbalza, come un ladro che è stato colto con le mani nel sacco.
«Bertl?»
Suo padre è sulla soglia della cucina, con gli occhiali scivolati sul naso e le mani umide.
«Ciao, papà.»
Bertolt distoglie lo sguardo dall'uomo e si massaggia la nuca. Non ha voglia di parlare col padre, soprattutto dopo quello che è successo. Vorrebbe soltanto chiudersi a chiave nella stanza finché avrà fiato in corpo.
«Non ti ho sentito entrare e... Sei tutto sudato» mormora suo padre dopo qualche secondo, «hai corso?»
Annuisce col capo, ma non aggiunge altro. L'uomo si morde il labbro inferiore, poi sospira e si volta.
«Vieni in cucina, Bertl. Ti faccio un po' di tè.»
Senza protestare, Bertolt raggiunge la cucina e si accomoda al tavolo di plastica. Davanti a sé vi è la schiena del padre, il quale fa cozzare i piatti e le posate all'interno della piattaia per estrarne fuori due tazze piccole. Bertolt scruta il modo in cui il padre si solleva sulle punte dei piedi, come stira il braccio destro per afferrare le tazze, o ancora, le dita che sfiorano con incertezza gli oggetti per paura di farli cadere.
Se la memoria non lo inganna, sua madre era addirittura più bassa del padre. Bertolt si morde l'interno della guancia, mentre realizza che è troppo alto, se paragonato ai suoi genitori. Si dice che i figli diventino più alti dei padri, ma Bertolt realizza soltanto adesso che la sua altezza è fuori dalla norma. È colpa degli uomini in camice bianco.
Ripensa al pizzicore dell'ago che s'infila sotto pelle, al padre che piange e non fa nulla mentre due uomini in camice bianco lo trasportano di peso fuori dalla loro vecchia abitazione. Perché ha dovuto subire tutto questo? Ha fatto qualcosa di male per meritarselo?
«Ecco fatto» annuncia il signor Hoover, dopo che ha riempito un pentolino d'acqua e l'ha messo sul fuoco.
Suo padre si gira verso di lui con un sorriso, che si spegne non appena lo guarda in volto. L'uomo si asciuga le mani con un panno consunto, dopodiché si aggiusta gli occhiali sul naso e ripone il pezzo di stoffa su una sedia. Al di sotto del grembiule che l'altro indossa, Bertolt scorge gli abiti arancione fluo che l'altro indossa durante i turni alla discarica. Se annusa l'aria, percepisce anche l'olezzo nauseabondo che emana la spazzatura e che gli fa rivoltare lo stomaco.
Il volto di Marco gli lampeggia dinanzi gli occhi, rivelando i muscoli al di sotto della pelle scorticata e l'orbita sinistra vuota. Quella è stata l'ultima volta che ha visto la faccia di Marco, prima che lo chiudessero in un sacco nero della spazzatura.
«Tutto bene, Bertl? Sei parecchio pallido. Hai la nausea?»
Bertolt nega col capo e si stringe nelle spalle. La verità è che non ha proprio mangiato oggi, ma non è necessario che suo padre lo sappia. L'uomo scosta la sedia di fronte Bertolt e si accomoda, inarcando le sopracciglia e, insieme ad esse, le rughe di espressione accanto agli occhi.
«È successo qualcosa? Vuoi parlarmene?»
«No... Non preoccuparti...»
Il signor Hoover scuote il capo e sospira, la bocca storta in un'espressione di rammarico.
«Per caso... è successo qualcosa al ballo? È da quel giorno che ti vedo un po' strano.»
Se non fosse per i tratti del viso identici, Bertolt penserebbe d'essere stato adottato. A differenza sua, il padre arriva dritto al dunque durante le discussioni. Lui non farebbe mai domande così dirette, eppure il genitore lo fa con una disinvoltura tale che non gli arreca disagio.
Ciò che lo preoccupa è la consapevolezza di quanto accaduto quella notte.
«No...» mente Bertolt, mentre percepisce la testa leggerissima, come se fosse in procinto di svenire.
La ruga che gli marca l'angolo della bocca, pare più profonda quando si incurva verso il basso. Bertolt nota soltanto adesso quanto pesino gli anni sulle spalle del padre.
«Ne sei sicuro?»
Non sa se è a causa del tono del padre, oppure del suo tono insistente, ma Bertolt cede e nega di nuovo col capo, contraddicendosi
«Non ce l'ho fatta...» mormora vago e non sa se si riferisce a quanto accaduto con Marco, oppure ad altro. Avrebbe desiderato imporsi, dare una seconda possibilità a compagno di scuola, invece, come fa un cane col suo padrone, ha eseguito gli ordini di Reiner e Pieck senza opporsi.
«Sono... sono stato debole» continua e la sua voce vacilla ad ogni parola che pronuncia.
L'acqua nel pentolino borbotta, ma il genitore non pare farci caso, perché allunga una mano verso Bertolt per prendere una delle sue tra le proprie. Il signor Hoover accenna un piccolo sorriso, mentre gli accarezza il dorso della mano.
«Non sei debole, tesoro mio. Sei come tua madre, hai soltanto bisogno... di un po' di sollecitazione.»
Le labbra gli tremano, quando viene menzionata la madre. La ricorda calma e gentile, non codarda come è diventato lui. Si domanda se le cose sarebbero migliori, se lei fosse viva.
«Questo mi ricorda quando le chiesi di uscire la prima volta. Tutti i nostri amici dicevano che io a lei piacessi, ma lei non mi aveva mai detto nulla. Non mi mandava segnali che me lo facessero capire! Alla fine mi sono buttato e ci siamo messi insieme.»
Bertolt annuisce col labbro che vibra a causa del nervosismo. Buttarsi è un'azione che, durante quel periodo, molti gli hanno consigliato di fare. Prende un respiro profondo e con la mano libera serra un pugno. Vorrebbe davvero seguire quel consiglio, ma ogni volta è come se una forza esterna gli impedisse di agire secondo la propria volontà.
«Ovviamente so che siamo due persone molto differenti, piccolo mio, però... rifletti sulle mie parole. Chissà, magari un giorno ti torneranno utili e, anche se l'occasione non ti sembra propizia, tu buttati. Alle conseguenze, positive o negative che siano, ci penserai dopo. Ogni tanto fa bene essere impulsivi!»
Il padre gli schiaccia l'occhio e Bertolt tenta di sorridere, sebbene non abbia motivi o diritti per farlo. L'uomo gli accarezza ancora un po' il dorso della mano, poi si alza e armeggia con i fornelli e le tazze per preparare il tè.
Bertolt non comprende come una persona così buona si sia invischiato con gli uomini in camice bianco. Perché lo abbia condannato ad una vita in gabbia.
«Ricordo quella sera come se fosse ieri. Anisha aveva raccolto i capelli in uno chignon e aveva indossato un abito azzurro, sembrava Cenerentola mentre scendeva le scale. Io avevo indossato la camicia bianca, quella che ti ho prestato, e dei pantaloni neri. Sembravo un cameriere!»
L'uomo scuote la testa e ridacchia, mentre tiene le palpebre socchiuse, immerso nel fiume di ricordi che ha scaturito quel breve racconto. Quando suo padre sorride, la ruga sotto l'angolo della bocca svanisce e a Bertolt sembra di rivedersi in uno specchio.
Chissà se sarà identico a lui, quando invecchierà. Ingoia un boccone amaro, però, quando riflette che, data la vita che conduce, è molto improbabile che vivrà tanto a lungo come il padre.
«Ecco qui.»
Le tazze tintinnano le une contro le altre, quando il signor Hoover appoggia il vassoio di plastica sul tavolo. La tazza di Bertolt è quella rossa e, senza che si sporga a leggere l'etichetta, sa già che l'infuso è una camomilla con melatonina, invece di un tè. È una delle sue essenze preferite, perché è una delle poche cose che lo fa calmare.
«A proposito del ballo... dov'è la camicia?» chiede l'uomo, mentre si porta alle labbra la tazza e vi soffia sopra, «Prima di andarmene vorrei fare una lavatrice.»
Dinanzi quella domanda, percepisce la gamba sinistra tremare contro la gamba del tavolo, che sobbalza così tanto che il padre se ne accorge.
«Non ci fa nulla se l'hai sporcata. Non sai quante volte l'ho fatto io...»
«No, non... Cioè sì, l'ho sporcata» borbotta Bertolt, interrompendolo. Deve inventarsi una scusa plausibile, altrimenti desterà sospetti.
«Solo che... be', che... Che ho tentato di lavarla, ma la macchia non andava più via, quindi... ho deciso di buttarla...»
Il padre spalanca gli occhi e quasi gli scivolano gli occhiali sul naso. All'altro non serve dire nulla, affinché Bertolt capisca che ci sia rimasto male. Si morde l'interno della guancia, gustando il sapore ferreo del sangue, e comincia a contare fino a dieci per calmarsi. Ha sicuramente deluso il genitore, oltre che sé stesso, e si domanda se possa toccare il fondo e oltrepassarlo.
«... Mi dispiace, papà.»
L'uomo scuote il capo e tenta di sorridere, anche se pare una smorfia sofferente.
«Non fa nulla! Non avresti potuto saperlo, è colpa mia. Avrei dovuto dirtelo.»
Nonostante il padre sorrida, gli occhi lucidi lo tradiscono. Bertolt sospira e deglutisce, mentre la gamba continua a martellare contro il tavolo. Adesso non basterà nemmeno la camomilla con la melatonina a calmarlo. Se avesse saputo prima quanto suo padre tenesse a quella camicia, lui ne avrebbe chiesta una a Reiner, oppure ne avrebbe fregata una in qualche negozio del South Side.
Invece ha imbrattato di sangue uno dei pochi ricordi che i suoi genitori condividevano e, come ciliegina sulla torta, l'ha gettato nella spazzatura.
«Non preoccuparti, Bertl. Davvero.»
L'orologio segna le otto e mezza e sa che il turno del padre inizierà tra un'ora. Dopo quella rivelazione Bertolt sa che non è un momento adatto per porre domande, ma, dopo quello che è successo la settimana scorsa a Marco, ha bisogno di sapere. Ha bisogno di sapere perché è stato costretto a diventare un mostro.
«Papà...»
L'uomo si porta alle labbra la tazza di tè bollente e vi soffia sopra, dopodiché se la porta alle labbra e ne trae un lungo sorso.
«Sì, Bertl?»
«Perché... perché devo andare alla clinica?»
L'eco di un pianto riecheggia nelle sue orecchie. Suo padre impallidisce e deglutisce, poi appoggia la tazza sul tavolo e ne spilla un po' il contenuto. Il liquido giallo rimane sulla tovaglia di plastica, senza che essa lo assorba.
«Vuoi sapere perché... perché devi andare alla clinica?»
Trova sia ironico che un tipo chiacchierone come lui sia muto come un pesce, quando devono affrontare argomenti così delicati.
In realtà, se prova a ricordare, si rende conto che non hanno mai discusso riguardo la sorte a cui lo ha assegnato. L'uomo è sempre stato ben attento ad evitare quell'argomento. Bertolt si porta l'indice alle labbra, ne mordicchia l'unghia e scuote la testa.
«Sì. Mi fanno sempre iniezioni e...» e il suo corpo ha cominciato ad emettere fumo dalle ferite, «... ed è piena di soldati. Perché devo andarci?»
Bertolt comprende di essere sul punto di piangere, quando le lacrime gli pizzicano gli occhi. Si sfrega quello destro con la manica, mentre vede che il genitore abbassa lo sguardo e si prende la testa tra le mani.
«È stata tutta colpa mia...» mormora l'uomo e Bertolt trattiene il respiro, in attesa che l'altro gli riveli l'origine della sua sfortuna.
«Io... Io...»
Quando il padre s'interrompe, Bertolt rantola di frustrazione. Ha atteso fino a quel momento per sapere la verità e il genitore si ostina a procrastinare. Non esiste un momento giusto per confessare certi crimini, di conseguenza insisterà – a modo suo - finché non otterrà la verità.
«Papà...?»
Il volto dell'uomo è tanto pallido, che lui crede di trovarsi di fronte ad un altro fantasma. Non lo osserva, anzi, quando cerca il suo contatto visivo, quello distoglie lo sguardo di proposito e lo rivolge altrove.
«Mi dispiace tanto... È stata tutta colpa mia e... e di quel maledetto tumore.»
Il tumore. Suo padre si riferisce al cancro che a Bertolt ha portato via la madre, quando aveva soltanto sette anni. Tragedia che si è verificata qualche settimana prima che quegli uomini si presentassero a casa sua. Spalanca gli occhi quando nota quel dettaglio e si sporge sul tavolo, mentre le prime lacrime cominciano a scendergli lungo le guance.
«Cosa... cosa... cosa significa, papà?»
È allora che vede il padre spezzarsi. L'uomo si toglie gli occhiali e tira su col naso, mentre tenta di non piangere. Guarda altrove, come se sostenere lo sguardo di Bertolt fosse troppo per lui, e prende un respiro profondo.
«Io... io te ne parlerò. Ti prego solo di... di non odiarmi.»
È una richiesta importante quella che il padre gli pone. Bertolt non ha mai odiato nessuno – forse un sentimento che si avvicina all'odio è quella che prova verso gli uomini in camice bianco –, ma non sa se potrebbe iniziare ad odiare il padre. A seconda di ciò che gli rivelerà, forse potrebbe, però.
«Non posso promettertelo...»
Il tono è deciso ed è questo che fa nascere una smorfia di dolore sul viso del padre. Il genitore annuisce e mormora a stento:
«Capisco.»
«Tu... Tu non sai quanto mi odio per quello che ti ho fatto. Che vi ho fatto, anche se... se è stata tua madre ad insistere, per quanto riguarda la sua terapia...»
Bertolt spalanca gli occhi e stringe i pugni sul tavolo, quando ascolta quelle parole. Le lacrime continuano a scendere, ma insieme ad esse emerge un sentimento che gli fa gustare l'acido in bocca e gli accelera il battito: la rabbia. Suo padre sembra leggerlo in volto, poiché si affretta a proseguire.
«Noi eravamo senza un soldo e... e poi c'eri tu, c'era la malattia... e lo stato dell'Illinois, be'... non ha fatto molto per aiutarci. Eravamo sul punto di dover abbandonare casa e trasferirci in uno di quei centri per senzatetto.»
Lui ricorda bene i giorni in cui mancavano la luce, oppure il gas, o l'acqua e bisognava adattarsi a questi inconvenienti. Il dettaglio che fa la differenza, però, è che Bertolt ha sempre creduto che questi eventi fossero normali.
«Una sera... noi eravamo a casa, tu dormivi... e loro suonarono. Né io né tua madre avevamo idea di chi fossero, né li avevamo mai visti. Ci proposero un'alternativa. Loro volevano che tua madre seguisse la loro terapia "speciale" e ci avrebbero persino pagati, se lei avesse accettato.»
Senza preoccuparsi di farsi vedere dal padre, Bertolt si copre il volto con le mani e lo preme contro i palmi. La terapia di cui parla il padre è la stessa a cui hanno sottoposto lui. Quegli uomini hanno riempito sua madre di veleni per nulla, dato che è morta nonostante tutto.
Oppure sono state le loro iniezioni a completare il lavoro?
Gli sfugge un singhiozzo e percepisce il fruscio delle vesti del padre, ma Bertolt arretra insieme alla sedia per non farsi toccare.
«E... e perché adesso usano me, dopo che lei è... è...» non riesce nemmeno a pronunciare la parola morte, tanto gli tremano le labbra.
Il padre si ritrae e scuote la testa, con le lacrime che gli scivolano lungo le guance e si congiungono sul mento. Il grembiule rosa ha una macchia umida sul petto, adesso.
«Avevano detto che se lei non fosse sopravvissuta abbastanza a lungo, loro avrebbero avuto bisogno di una... di una... garanzia.»
Una garanzia. Soldi. Bertolt si sente trattato come un oggetto. Si domanda se valga la pena lottare, quando la sua vita rappresenta soltanto una cifra, qualcosa di freddo, un semplice strumento di baratto per ottenere qualcosa in cambio – quale sia l'obiettivo degli uomini in camice bianco, però, lui non l'ha ancora compreso. Forse non gli sarà mai dato saperlo, dopotutto la sua stessa vita non gli appartiene più.
Si porta le mani sul capo, sconsolato, e osserva le mattonelle bianche della cucina. Ha persino smesso di piangere, la morsa in cui era stretto il suo cuore è sparita. Non prova niente – oppure si convince di non provare niente, perché è più facile ignorare le sue emozioni per sopravvivere.
«Bertolt, mi dispiace... io... Non potrò mai essere perdonato per i peccati che ho commesso, io...»
«Papà.»
Il suo tono di voce è distaccato e lontano, nonostante la voce fuoriesca dalla propria gola. È più disumano.
«Dove sono i soldi?»
Al signor Hoover scivolano gli occhiali sul naso, mentre osserva il figlio. Forse si aspettava una reazione diversa – rabbia, magari – e questa domanda improvvisa lo lascia stupefatto. L'uomo indugia qualche minuto, poi mormora:
«Adesso... adesso te lo dirò.»
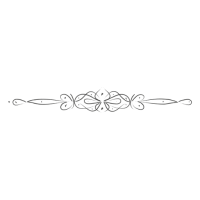
A Bertolt basta allungare una mano verso il soffitto per afferrare la catenella che penzola da essa. La botola della mansarda si apre piano, cigola, e rivela una scaletta di legno secco e smussato dalle termiti. Spera che reggerà il suo peso, altrimenti cadrà.
Suo padre è rimasto in cucina e dal corridoio dove si trova ascolta i singhiozzi del genitore. Bertolt poggia un piede sulla prima asse di legno, che scricchiola quando vi bilancia tutto il suo peso. Ignora i successivi scricchiolii e si arrampica sulla scaletta senza battere ciglio. Non prova timore, sebbene dovrebbe, né rabbia, nonostante sia lecito in quel momento.
È come se una bolla di indifferenza lo avesse avvolto e all'interno di essa i suoni giungessero ovattati, i colori opachi e gli oggetti avessero i contorni sfuocati. Nessuna emozione eccessiva può minacciare la sua precaria stabilità in questo momento.
Quando giunge alla fine della scala e si ritrova in mansarda, l'odore stantio della muffa gli pizzica le narici. Si pinza il naso con due dita, affinché trattenga lo starnuto imminente, dopodiché si osserva intorno alla ricerca del minibar di cui suo padre gli ha parlato.
Le ragnatele penzolano da ogni angolo del soffitto e s'insinuano tra ogni trave del soffitto. Le assi di legno del pavimento, inoltre, sono rese quasi grigie da uno spesso strato di polvere. Per fortuna in mansarda non conservano molte cose: c'è qualche mobile inutilizzato, una pila di scatole, una lampada dal collo spezzato e, infine, il maledetto frigorifero.
Suo padre ha piazzato sopra all'oggetto una scatola di mattonelle rotte e presine, che tiene fermo un telo blu che ricopre il frigorifero fino alla base, in modo che esso sembri un banale comodino. Soltanto adesso che Bertolt è a conoscenza del contenuto, comprende il perché di quel bizzarro arredamento.
Zigzagando tra i vari oggetti e tenendo bassa la testa, Bertolt raggiunge l'angolo della mansarda. Afferra la scatola e la lascia cadere per terra con un tonfo sordo, incurante delle mattonelle che diventano cocci di marmo, oppure delle presine che cadono fuori dalla scatola. Con un gesto secco lancia via anche il telo, rivelando il frigorifero, poi si accovaccia dinanzi all'elettrodomestico.
Fa un sospiro profondo e, quando sente il cuore più leggero, realizza di aver trattenuto il respiro nell'ultimo minuto. Quando allunga la mano verso la maniglia dell'oggetto, nota che il polso trema e il palmo è appiccicoso al contatto con il metallo. In fondo prova ancora qualcosa si rende conto, mentre gira la maniglia e apre con lentezza esasperante l'anta del frigorifero.
Sul primo ripiano c'è una valigetta nera, anch'essa resa opaca dalla polvere. A quanto pare il padre qualcosa di vero l'ha detta: non ha più toccato quei soldi, dopo che si sono trasferiti nel West Side.
Bertolt estrae la valigetta dal frigorifero, poi ne accarezza la superficie e i suoi polpastrelli si ricoprono di polvere. Si sente insignificante come quei granelli di polvere, poiché non può fare nulla, se non lasciarsi trasportare dagli eventi.
Una volta pulitosi le dita sui jeans, fa scattare con l'indice la serratura metallica e con un fastidio clic la valigetta si apre appena. Bertolt la spalanca e quando ne osserva il contenuto è indeciso se richiuderla, oppure immergere le mani in quel male – tanto ne è già ricoperto fino al collo, quindi un centimetro in più o in meno non farà la differenza. Il suo destino è ormai segnato.
Sul fondo sono disposti in ordine tanti mazzetti di banconote quanto bastano per riempirla fino all'orlo. Solo in alto a sinistra vi è un buco, lì dove avrebbero dovuto esserci tre mazzetti impilati l'uno sull'altro. Bertolt sa che dovrebbe fermarsi in quel momento e riporre la valigetta nel minibar, allontanarsi, scendere e chiudersi in camera, ma non lo fa.
Non sa se è curiosità o masochismo, però afferra uno dei blocchetti e comincia a contarne le banconote. Quando ha finito, estrae il cellulare e clicca sulla calcolatrice, poi moltiplica il valore del singolo blocchetto per il numero di blocchetti presenti all'interno della valigia. Cinquecentomila dollari è il risultato apparso sullo schermo del telefonino.
Duecentocinquantamila dollari, comprende Bertolt, è il prezzo che hanno attribuito alla sua vita.
Note dell'Autrice:
Il capitolo di oggi è un po' vuoto nei contenuti e per questo chiedo scusa, ma ognuna di queste scene avrà un senso in futuro, lo prometto! Chiedo scusa per l'enorme ritardo, ma ho avuto degli alti e bassi in questi mesi e prima di pubblicare questo capitolo volevo scriverne almeno metà dell'altro, quindi eccoci qui!
Questo mese non aggiornerò una volta ogni due settimane, bensì rimanderò a dicembre, perché ho intenzione di partecipare al NaNoWriMo, in modo da concludere questa storia – o perlomeno, ci proviamo...
Per quanto riguarda ciò che è successo, l'unica cosa sicura che si può evincere è che qui il padre di Bertolt è proprio una pessima persona (e che sua madre è indiana, nazionalità che avrei voluto Isayama gli attribuisse, invece di sparare quell'assurdità sull'Italia... ma lasciamo stare questo discorso), un po' come tutti gli adulti in questa fanfiction – o forse no?
Mi pare di aver detto tutto – e invece no, sento di star dimenticando qualcosa –, ma se avete dubbi o critiche costruttive da muovermi sono sempre lieta di rispondervi e ascoltarvi!
La parola di oggi è:
Ishin-denshin (giapponese): una comunicazione intima, personale tra due individui che si capiscono a vicenda senza bisogno di parlare.
Vi mando un caloroso abbraccio,
Luschek
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top