8.1 // I nodi al pettine
Everard stava là, in piedi sulla porta, aspettando la risposta di Solomon come se pensasse che avrebbe davvero potuto dirgli di uscire da quella stanza, che avrebbe preferito la compagnia di Floki per quella notte. Si era tolto il mantello, che aveva sottobraccio, e aveva addosso la bisaccia da viaggio che avrebbe posato nella loro camera. Avrebbe dovuto farsi la barba che cominciava a spuntare di nuovo, la cicatrice sulla sua gola si intravedeva dal colletto, e gli occhi scuri e titubanti lo risucchiarono intero.
“Perché?” chiese Solomon, anziché invitarlo a entrare o dirgli di andar via. “Perché vuoi passare la notte con me?”
Lui si strinse nelle spalle. “Ho pensato che potessi essere spaventato per domani. Ho pensato che avrei potuto aiutare. Ma se ho pensato male me ne vado, non voglio peggiorare la situazione, io…”
“Resta,” disse Solomon, anche se so sentiva in imbarazzo, un po’ a disagio e un enorme idiota che non sapeva cosa fare o dire. “Avevi ragione. Sono spaventato per domani. Stai qui.”
Everard entrò nella stanza e si chiuse la porta alle spalle, piano per non emettere suono. Gettò bisaccia e mantello sul letto opposto a quello su cui era seduto Solomon, e poi si voltò a guardarlo. Anche lui sembrava a disagio, come se non sapesse bene dove guardare.
Fu allora che Solomon si decise ad alzarsi in piedi, ad andargli incontro, fermandosi solo a pochi centimetri da lui. Il ragazzo restò immobile, in attesa che fosse lui a fare qualcosa, qualunque cosa, e Solomon pensò che glielo doveva. Everard era andato da Floki a chiedere il cambio di letto, aveva già fatto il suo, ora spettava a lui.
“È strano,” mormorò, resistendo all’impulso di sporgere il braccio avanti e di toccarlo, per assicurarsi che era davvero lì. “Saperti qui con me per la notte, intendo.”
“Non voglio che sia strano. Voglio che sia facile come prima. È sempre stato facile stare insieme a te.”
Solomon non sapeva come rispondere a quell’affermazione. Sapeva però cosa desiderava davvero.
Anch’io voglio che sia facile. Voglio te, come non ho mai voluto nient’altro al mondo. Ti voglio perché siamo qui, a dieci centimetri di distanza, e sono dieci di troppo per come la vedo io.
“Posso abbracciarti?” gli chiese, perché voleva averlo vicino.
“Penso che se non vieni qui subito potrei morire,” rispose Everard.
Così Solomon gli gettò le braccia al collo e sentì che lui gli passava le braccia attorno ai fianchi stringendolo a sé.
Everard infilò il volto nell’incavo della sua spalla e gli diede un breve bacio sul collo.
Rabbrividì e lo strinse più forte.
Per un attimo, tutti i pezzi in cui si era infranto tornarono a posto, come se Everard lo stesse tenendo insieme. Aveva paura che appena avesse mollato la presa si sarebbe rotto di nuovo, ma essere di nuovo tutto d’un pezzo fu qualcosa di così grande che si accorse di stare tremando.
Everard lo baciò sul collo una seconda volta e poi una terza, e Solomon gli infilò le dita tra i capelli come aveva desiderato fare da quando l’aveva visto la prima volta settimane prima.
“Sei qui,” gli sussurrò Solomon all’orecchio. “Per davvero.”
“Sono qui, per davvero.”
Nonostante il ragazzo lo stesse stringendo forte, facendogli scricchiolare le ossa della sua schiena, ebbe l’impressione che la sua cassa toracica si stesse espandendo nel suo petto, e che il suo cuore stesse diventando sempre più grande. Chiuse gli occhi e si aggrappò a lui con tutta la forza che aveva, inspirando a pieni polmoni con la mente annebbiata da tutta quella vicinanza così intima che non c’era stata in tutte le settimane che avevano viaggiato insieme.
I minuti passarono e i suoi battiti si calmarono, in una bolla di pace che escludeva tutto ciò che era fuori da quella stanza. Niente avrebbe potuto toccarlo in quel momento, erano insieme, al sicuro, lontani dalle aspettative degli altri e da sguardi indiscreti.
Fu malvolentieri, quando ormai il tempo passato era troppo, che si separarono.
Solomon tremava ancora, e quello che sarebbe successo il giorno seguente gli ripiombò addosso con prepotenza, affannandogli il respiro.
Everard lo notò, come sempre. Lo notò, e gli prese il volto tra le mani. Solomon si sentì precipitare da un’altezza altissima, un vuoto allo stomaco, poi Everard parlò.
“Non posso prometterti che andrà tutto bene, ma posso prometterti questo: non importa cosa accadrà, possiamo affrontarlo insieme domani. Non sei solo. E per quel poco che può valere… per quel poco che può valere non mi importa se la tua magia fa cilecca o se non sei nel pieno delle forze, se c’è qualcuno che può riprendersi il Libro quello sei tu. Ho piena fiducia in te, e sai perché? Perché tu sei la persona più capace, brillante, testarda che io conosca. Quindi non avere paura. Tutto quello che dovrai sopportare, potrai sopportarlo con me. E tu puoi farcela. Puoi farcela Solomon, io lo so. Io credo in te.”
Everard lo guardava coi suoi occhi in fiamme, non era stato niente meno che sincero e Solomon, con le gambe che gli tremavano, resse il suo sguardo.
“Hayati,” mormorò, non l’aveva più chiamato così da quando non era più stato suo, ma quella volta fu inevitabile. “Aiutami, non so cosa fare. Aiutami, ti prego.”
“Tutto,” rispose, in un filo di voce. “Ti darò tutto quello che vuoi, stanotte.”
“C’è solo una cosa che voglio.” E tu sai qual è.
Everard deglutì a quelle parole. “Ti capita mai di voler commettere un errore pur sapendo che è un errore? Ma tu niente, vuoi farlo lo stesso?”
“Sì, a volte. È capitato anche a me.”
“E cosa fai in quei casi? Commetti lo sbaglio oppure no?”
“Dipende,” rispose Solomon.
“Dipende da cosa?”
“Da se penso che ne valga la pena.”
Così Everard lo fece, gli sollevò il mento con due dita, si sporse verso di lui e lo baciò.
Quando le loro labbra si incontrarono fu come se non se ne fosse mai andato. Tutto il tempo appena passato gli crollò addosso ma lui restò in piedi, incolume, stringendo i capelli di Everard tra le dita, premendoglisi contro e approfondendo il bacio. Si lasciò spazzare via e rimodellare dalle sue mani che avevano iniziato a esplorargli il corpo, come se cercasse di conoscerlo di nuovo. I suoni dei suoi pensieri si spensero e i sensi si riaccesero. Sentì la magia crescere in lui, cantare dalla gioia e riprendersi lo spazio che aveva perso. Crebbe nelle sue vene come la marea, inondandolo e tornando più forte di com’era stata prima di allora.
Fu allora che fece la cosa più difficile che aveva mai fatto, e tra un bacio e l’altro si separò da lui e sussurrò “Fermo, aspetta.”
Everard si irrigidì e si bloccò non appena pronunciò quelle parole. “Scusami,” gli disse, “ho sbagliato, l’ho detto che sarebbe stato un errore, io…”
“Che significa?” chiese Solomon, piantando gli occhi nei suoi. “Che significa tutto questo?”
“In che senso?”
“È un primo bacio o un ultimo bacio? Vuoi tornare con me? Lo fai solo perché forse domani moriremo? Che significa? Cosa siamo?”
“Io… non lo so, Solomon. L’ho fatto perché volevo farlo, perché pensavo lo volessi anche tu.”
“Io lo volevo, io… lo voglio. Ma devo sapere cosa significa per te.”
“Non so neanche se domani a quest’ora saremo vivi. Non voglio pensare al futuro, non so cosa ci riserverà. Voglio pensare a questo momento, e in questo momento voglio stare con te.”
“Un po’ comodo così, non ti pare?”
“Hai ragione,” rispose, in un sospiro. “Devo prendermi le responsabilità di quello che faccio. Io ti voglio. Oggi, domani, per quanto sarà possibile.”
“E mia madre? Il fatto che è stata lei a mettermi quest’idea in testa? Non ti turba più?”
“Certo che mi turba. Ma rischio davvero di perderti domani, e se avrò la fortuna di averti ancora con me non la voglio sprecare. Sarebbe da stupidi,” disse, con una fermezza nella voce rara da trovare in lui. “Ma il fatto che la nostra storia sia stata orchestrata da tua madre mi turba ancora. Mi turberà sempre. Ti sta bene, questo?”
“Se mi sta bene?” chiese Solomon, con un sorrisino. “Se gli dèi mi chiedessero di scegliere tra passare questa notte con te e morire domani e non vederti più e vivere cent’anni, domani sarei il cadavere più felice del Regno.”
Everard scosse la testa, incredulo. “Sei sempre stato bravo con le metafore, ma stavolta hai proprio esagerato.”
“Non era un’esagerazione,” rispose. “Posso baciarti adesso?”
Lo sguardo dolce di Everard si infiammò di nuovo. “Ti prego, sì.”
Così lo fece. Lo tirò giù per la veste e lo baciò, in un bacio che si accese all’istante, con più fretta e fame di prima, tanto che quando Solomon si ritrovò sul letto non sapeva neanche come ci fosse arrivato. Everard era con lui, sopra di lui per essere precisi, erano appena tornati insieme e lo stava baciando come se la sua vita ne dipendesse, quindi non gli importava nulla del mondo fuori da quel letto.
Everard iniziò a baciargli il collo, salendo con la tutta la calma di cui disponeva e mordendogli la pelle mentre passava, in una lenta tortura dolcissima. Solomon si lasciò sfuggire un gemito, abbandonando la testa all’indietro e chiudendo gli occhi, lasciandosi che i pensieri in lui svanissero come fumo, pura sensazione incontrollata.
Le labbra del compagno arrivarono all’orecchio e il ragazzo sussurrò “Sei mio, adesso. Non ti lascio più andare.”
Quello fu troppo. La persona che amava che gli giurava di non lasciarla mai più ed era sincera, il suo corpo che fremeva dalla voglia di averlo lì, subito, la sua magia impazzita che tornava a cantare di gioia e lui restò là, col fiato mozzo e tremante, ad aggrapparsi all'altro come se la sua vita né dipendesse, con tutta la forza che aveva.
Everard gli accarezzò il volto, un tocco dolce e lo sguardo tanto colmo d'amore da stordirlo, poi si abbassò di nuovo sulle sue labbra.
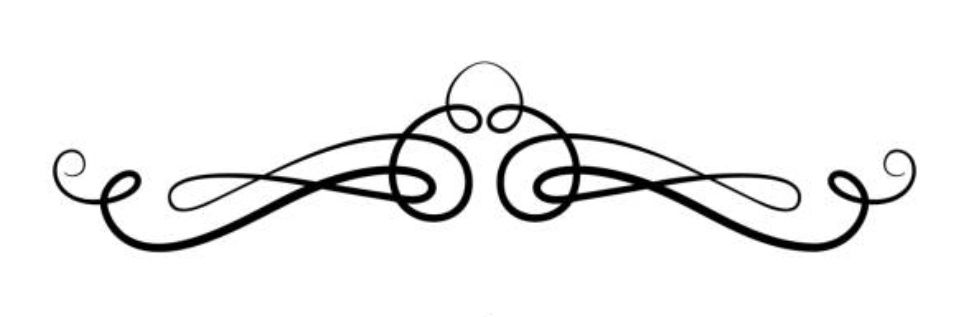
Gli uomini reclutati da Sigga erano tutti riuniti là dove il fronte degli elfi era più nutrito, dove l’Arshim Zvanak, il loro capo che ormai non aveva più il potere di ammaliare, stava con gli altri. Una macchina da guerra e di morte, il circolo elfico che faceva piazza pulita di chi gli si trovava davanti, circondati da un cumulo di cadaveri di uomini che avevano provato a fermare la loro avanzata.
Sigga strinse il bastone tra le dita, osservando le gambe di quel gruppo compatto che stava là davanti a lei, e si avvicinava all’insieme di umani che lei aveva radunato là nella sala d’ingresso. Uno di loro era persino riuscito a trovare un acciarino e stringeva una torcia ardente, il fuoco ciò che gli elfi temevano di più.
“Dammela,” gli disse Frederick, consegnandogli la spada. “Aprirò io la strada, proverò a separarli in modo che possiamo arrivare al loro capo.”
“Perché tu?” gli chiese l’uomo che brandiva la torcia, tenendo gli occhi puntati sulla minaccia che in quel momento si era fermata, guardava il raduno di uomini e aveva smesso di combattere.
“Perché è pericoloso. Non voglio mandare qualcuno a morire, però va fatto. Così andrò io.”
L’uomo, che Sigga non aveva mai visto, sembrò ponderare le sue parole. “Ho una figlia,” gli disse. “Mi piacerebbe rivederla quando tutto questo sarà finito.”
“Io non ho nessuno, invece. Dammi quella torcia, avanti.”
Sigga sentì quelle parole, e le arrivarono come una frustata. Io non ho nessuno, invece. Avrebbe voluto dirgli che non era vero. Che lei gli voleva bene, tanto, sino a scoppiare. Che avrebbe sempre trovato un rifugio in lei, che l’avrebbe sempre ascoltato, che sarebbe stata un porto sicuro.
Non ne ebbe modo. Quando Frederick ebbe in mano la torcia, si voltò verso di loro e alzò il braccio per attirare l’attenzione, facendo svettare il fuoco come un blasone. Gli elfi si ritirarono in parte, spaventati. Sigga non poteva guardare ad altezza volto ma sapeva, sentiva, che gli occhi ciechi dell’Arshim erano puntati su di loro e su di lui.
“Siete pronti?” gridò, lo sguardo deciso e fiero, imponente pure nella sua magrezza, pure coi vestiti troppo larghi e pure in quella strana posizione col braccio al cielo.
“Siamo pronti,” disse Clarice, che teneva Sigga per la mano e nell’altra stringeva un coltello da carne. Lei non si era allenata con gli altri, ma non si sarebbe tirata indietro.
“Siamo pronti!” gridò di rimando Michael, brandendo la sua mazza chiodata.
“Siamo pronti!” esclamò Hansel, seguito da buona parte delle donne e degli uomini insieme a loro.
“Siamo pronti,” sussurrò Sigga, stringendo la mano di Clarice nella sua e poi lasciandola andare.
Frederick si voltò, rivolto verso gli elfi con cui non incrociò lo sguardo. “Andiamo ad ammazzare questi bastardi!” gridò, poi iniziò a correre.
Tutto fu molto meno chiaro a quel punto. Gli elfi ruppero le righe, cercando di evitare impauriti l’avanzata del fuoco. Frederick brandì la sua torcia come un bastone, le grida stridule delle creature fendettero l’aria, insieme alle urla degli umani. Quando fu nella mischia, perse di vista Clarice, Hansel e quelli che conosceva. L’unico che vedeva era Frederick, che roteava quella fiamma ardente come un’arma, creandole un passaggio sicuro.
Si sentì afferrare le vesti e si strapparono, ma non si fermò, decisa ad arrivare a lui.
Seguì Frederick come un’ombra, il ragazzo creò una spaccatura nella difesa elfica, spianandole la strada. Ricevette un’unghiata alla spalla che le stracciò l’abito e la portò a sanguinare, ma non se ne crucciò. Nessuno si avvicinava troppo a loro, non con il suo amico armato del fuoco.
Arrivarono davanti all’Arshim abbastanza in fretta, evitati dagli altri che facevano mattanza dei compagni intorno a loro. Sigga poté alzare lo sguardo e posarlo su di lui. Le sue orbite vuote, che era stata proprio lei a cavare, era come se la fissassero senza vederla.
Frederick avvicinò la torcia anche a lui, ma quello non si lasciò impressionare come gli altri.
Con una manata ben assestata, dall’alto degli oltre due metri della sua altezza, gli fece cadere la torcia sul pavimento di pietra, e poi lo scaraventò giù a sua volta, facendolo finire riverso a terra in un gemito di dolore.
Sigga vide con la coda dell’occhio che gli elfi si riavvicinavano guardinghi ora che la torcia non era più in suo possesso. Era solo questione di tempo prima che gli si avventassero addosso, ma Sigga non poteva permettersi di pensare a lui, né a chiunque altro, persino a Clarice che non riusciva più a vedere né sentire, là in quella mischia infernale.
Fece ruotare il bastone sopra di lei e colpì, prendendogli la spalla. L’Arshim fece due passi indietro, poi urlò. Non poteva vederla, ma lei poteva vedere lui. I ruoli si erano invertiti, l’elfo era in svantaggio quella volta e lei doveva approfittarne.
Lo colpì alla testa la volta successiva, facendolo urlare più forte e contorcere dal dolore. Era pronta a dargli il colpo di grazia quando un suo compagno, attratto dal fatto che ora la torcia non era più nelle loro mani, la afferrò da dietro e la prese per la vita, sollevandola di peso.
Lei urlò e scalciò, abbassò la vista non appena il mostro si voltò, portandola con sé. Le sfuggì il bastone di mano ma continuò a urlare, sinché non riuscì a dargli un calcio sulla ginocchio alla cieca e a fargli mollare la presa.
Quando si voltò di nuovo, vide dalle loro gambe che si erano riuniti ancora intorno al loro Arshim, e mormorò tra i denti “Non credo proprio.”
Si buttò in terra e raccolse la torcia da terra, sollevandola e allontanando elfi da lei come nugoli di mosche infastidite.
Arrivò di nuovo a lui, faccia a faccia, e prima che potesse fare qualunque altra cosa gli premette la torcia al volto, bruciandogli il viso. Lo vide cadere all’indietro dalla sorpresa e dal dolore, così gli salì a cavalcioni addosso. Tenne premuto il fuoco contro il suo volto sinché non la smise di dimenarsi, arreso al dolore atroce di quella tortura e alla morte.
Non si accontentò di vederlo fermo e immobile sotto di lei, di vedere il resto degli elfi impazzire intorno a loro e cercare una via d’uscita. Si voltò indietro, prese da uno dei cadaveri la spada e fece un taglio netto sulla sua gola, squarciandola come carta velina.
Quando fu certa che non potesse essere vivo, l’adrenalina non sfumò. Vide che gli elfi si diradavano, correndo da ogni parte e lanciando le loro grida forse diffondendo la notizia che il loro leader era morto. Battevano in ritirata e in quel momento, solo in quel momento, lei si alzò dalla posizione in cui era e si voltò a guardare i compagni.
Individuò subito Clarice e Hansel, inginocchiati a terra, poi lo vide: Frederick aveva gli amici intorno, continuava a gemere riverso sul pavimento di pietra e perdeva copioso sangue da un lungo taglio.
La ragazza andò verso di loro, il cuore ancora impazzito nel suo petto. Camminò a passi tremanti, la testa le girava per via dell’adrenalina e del pericolo appena scampato.
“Frederick,” sussurrò, cadendo anche lei in ginocchio. Intorno a loro, tutti cercavano di recuperare i feriti ancora non troppo oltre, e loro non facevano eccezione.
Hansel tamponava in modo convulso il sangue che continuava a fluire imperterrito, Clarice si guardava intorno come se cercasse qualcosa che poteva aiutare, senza trovarla.
Sigga afferrò qualcosa dall’ampia tasca del suo abito, e legò stretto il suo nastro sul braccio di Frederick, sotto la spalla, sopra la ferita. “È tutto a posto,” gli disse, “è tutto a posto. Ora ti passa. Stai tranquillo, stai tranquillo.”
“Ne è valsa la pena,” disse lui, mentre Clarice cominciava ad avere le lacrime agli occhi. “Sapevo quello che facevo.”
“Andrà tutto bene,” ripeté Sigga, tra le lacrime, decisa a non lasciarlo andare.
“Avrei dovuto farlo io,” singhiozzò Clarice, passandogli una mano lungo il volto. “Non è giusto.”
“Non morirà,” insistette l’amica.
“Un guaritore! Ci serve un guaritore! Aiuto!” gridò Hansel, che gli afferrò la mano e la strinse per dargli conforto.
“Mettiti in fila, ragazzino,” rispose qualcuno di indistinto dall’enormità della sala.
Gli occhi di Frederick erano lucidi, la sua espressione sofferente le stringeva il cuore. “Andrà tutto bene,” sussurrò ancora, passandogli una mano tra i capelli. “Te lo prometto.”

La prima volta che Everard posò gli occhi sul mare, provò un’emozione tanto forte da stordirlo. Aveva sempre saputo cosa fosse: una distesa d’acqua infinita che si allungava a perdita d’occhio, sino a sparire all’orizzonte; nulla però l’avrebbe potuto preparare alla magnificenza di ciò che vedeva in quel momento.
Era l’alba, e il sole sorgeva facendo capolino dalle acque ancora nere della notte, iniziando a brillare di riflessi rossi e d’oro. Il suono delle onde mosse dal vento e della risacca erano un rumore bianco nelle sue orecchie, totalizzante e quasi spaventoso.
Quello che provò, però, nonostante ciò che lo aspettava e il pericolo che si annidava dietro l’angolo, fu un devastante, straziante senso di pace.
“Wow,” sussurrò, facendo qualche passo verso il termine del promontorio, sporgendosi sul salto nel vuoto in cui si sarebbe dovuto calare a momenti. “Dunque è questo il mare.”
“Bellissimo, non è vero?” chiese Solomon, avvicinandosi. “Ti fa chiedere quale sia il senso di ciò che stiamo facendo. Siamo così piccoli in confronto… il mare è come il cielo, a lui non importa nulla di noi o dei nostri problemi…”
“È… magnifico.”
“Lo è,” mormorò il druido, sfiorandogli la mano con la sua. “Tanto bello che ti senti quasi in colpa a guardarlo.”
Everard si voltò a verso di lui, lasciando perdere la grande distesa oceanica. Gli sorrise, un sorriso incoraggiante anche se sentiva il cuore battere forte e le gambe a un passo dal cedere. Lo osservò bene, aspettando la forza per andare avanti.
Solomon aveva di nuovo la tunica dorata, che scintillava alle prime luci dell’alba, gli aveva spiegato perché. Gli aveva spiegato anche perché i suoi poteri erano tornati forti come prima, e Everard si era un po’ arrabbiato al sentirlo. Gli aveva detto che avrebbe dovuto avvertirlo, che aveva il diritto di sapere che la sua scelta aveva influenzato tanto la vita del druido.
Capiva anche perché Solomon l’aveva fatto però, e in quel momento tutta l’arrabbiatura era evaporata, come nebbia al sole.
Anche lui era tanto bello che Everard si sentiva in colpa a guardarlo, proprio come il mare. E, proprio come il mare, Solomon gli appariva misterioso e inesplorato, tanto placido quanto selvaggio, coi suoi capelli bianchi e gli occhi ferini puntati a loro volta su di lui.
“Cosa c’è?” gli chiese, e anche se Everard sapeva quanto fosse nervoso, un angolo delle sue labbra si piegò all’insù.
“Pensavo a te,” gli disse, senza aggiungere altro. Non amava parlare di sentimenti, e il giorno precedente l’aveva fatto anche troppo.
Una luce di genuina sorpresa gli accese il volto, e il suo sorriso si fece imbarazzato e incredulo. Scosse la testa, addolcendo lo sguardo. “Andiamo, avanti.”
Everard annuì, osservandolo mentre si accovacciava in terra e affondava le dita nei fili d’erba mossi dal vento che coprivano il promontorio. Lo vide chiudere gli occhi e, dopo qualche secondo di concentrazione, delle piante rampicanti formarono una scala che scendeva giù verso il mare.
Le fiammelle che sino a quel momento li avevano accompagnati svolazzando e fluttuando intorno a loro si spensero, ora che il sole aveva iniziato a salire per l’orizzonte.
“Sicuro di riuscire a scendere?” chiese Everard, guardando il druido che si era alzato in piedi e ammirava il suo lavoro terminato. “È parecchia strada e tu non sei, beh, diciamo troppo atletico… senza offesa.”
“Grazie mille,” commentò Solomon, alzando gli occhi al cielo. “Posso farcela, l’edera mi aiuterà.”
“Come preferisci,” rispose lui, alzando le spalle.
Solomon, da sempre il più permaloso, resse il suo sguardo con aria di superiorità e si abbassò di nuovo, pronto a calarsi. Puntò i piedi sulle liane intrecciate e si appoggiò a loro, scendendo a tentoni e aiutandosi con le mani aggrappate alla fitta vegetazione che stava ancorata alla roccia.
Everard lo guardò scettico, ma neanche quando Solomon sbiancò e mise un piede in fallo, subito riacchiappato dell’edera senziente, fece un commento a riguardo. Sapeva che il druido l’avrebbe presa male, per cui non disse nulla.
Anche se lui sarebbe forse riuscito a scendere anche senza aiuto, decise che era meglio non rischiare. Aspettò che Solomon arrivasse quasi alla fine della sua corsa, per evitare di andargli addosso essendo più veloce di lui, e iniziò a calarsi a sua volta.
Le sue mani esperte si tennero salde alle liane che erano aggrappate con forza al promontorio, mentre scendeva senza difficoltà e senza mollare la presa.
Quando raggiunse quasi l’altezza dell’acqua, vide che si apriva una spaccatura nella roccia, che si squarciava nell’ingresso di una caverna. In un saltello fu arrivato, il suono dei sandali che atterrarono sulla pietra nuda e quello delle onde furiose unico suono che potevano sentire.
“Ci sei?” chiese Solomon avvicinandosi, lui annuì. “Dovrebbero essere là dentro.”
Everard guardò l’entrata della grotta col cuore in gola. Lo spazio si restringeva in un piccolo corridoio che si insinuava nel ventre del promontorio, e lui aveva sempre odiato gli spazi chiusi. In più, là dentro lo aspettavano pericoli che non riusciva neanche a immaginare. I figli di Ingar sarebbero stati nella grotta, forse persino Ingerid. Loro erano soltanto due – Hildebrand aveva insistito tanto per andare con loro, ma Solomon non aveva voluto saperne, non avendo poteri sarebbe stato solo d’intralcio – e di cui uno un essere umano.
“Non devi entrare per forza. Puoi tornare su con gli altri,” gli disse Solomon, notando la sua agitazione.
“Non dire idiozie. Ti ho detto che l’avremmo affrontato insieme e lo faremo. Non ti lascio da solo.”
“Neanche tu hai poteri magici, non sei costretto a…”
“Ho il mio pugnale a proteggermi dagli incantesimi. Posso esserti utile. E poi, sono abituato a non avere la magia. Con gli altri druidi è diverso.”
“Va bene,” sospirò Solomon, che aveva capito che non c’era altro da fare. “Andiamo, allora.”
Una nuvola di fiammelle si alzò in volo e andò a illuminare il corridoio all’interno della grotta. Everard, col cuore in gola, fece per avanzare al suo interno quando Solomon afferrò la sua mano e lo tirò indietro.
“Che cosa c’è anc…” chiese, ma non fece in tempo a finire la frase, perché l’altro si era alzato sulle punte, l’aveva tirato a sé e in quel momento lo stava baciando.
Everard non avrebbe mai rifiutato un bacio da lui, lo sapeva, lo sentiva. Ne aveva bisogno come dell’aria quando era stato in procinto di annegare e così rispose al bacio, schiudendo gli le labbra e assaggiando il suo sapore, estorcendogli un verso di apprezzamento che gli fece ribollire il sangue nelle vene e prendendolo per i fianchi, facendolo aderire a sé.
Lo baciò con calma, senza fretta, anche se non c’era tempo. Lo baciò come se fosse la cosa più importante in quel momento, come se il mondo avesse smesso di girare, il sole di salire su per l’orizzonte, il mare di agitarsi, il suo cuore di tremare.
Quando si separarono Solomon sbatté le palpebre e lo guardò come se lo vedesse in quel momento per la prima volta. “Scusa. Forse era la mia ultima occasione di farlo.”
Everard sapeva quello a cui andavano incontro. Sapeva che Solomon aveva ragione, quella poteva essere l’ultima volta che posava le labbra sulle sue, che uno di loro o entrambi sarebbero potuti non tornare quel giorno. Lo sapeva, eppure sarebbe entrato in quella grotta comunque, anche se non voleva farlo.
“Insieme,” gli disse, perché non c’era bisogno di altro.
“Sino alla fine.”
Si scambiarono un altro sguardo, poi riuscì a forza a tornare in sé. “Andiamo.”
Note autrice
Gli umani, guidati da Sigga e Frederick, hanno avuto la meglio a Palazzo. Frederick è rimasto gravemente ferito, chissà se si salverà, sono aperte le scommesse! Secondo voi?
La mattina dopo, invece, Everard e Solomon – che sono tornati insieme, dopo un intero libro separati – sono giunti infine nella grotta del Libro Sacro. Nel prossimo capitolo ci sarà il gran finale, il momento che stiamo tutti aspettando, quello in cui si vedrà se e –nel caso– come riusciranno a rimettere i nomi nel Libro ed evitare l’estinzione dei druidi.
Chi la spunterà? Un umano con un pugnale incantato e un druido che ha appena ripreso possesso della sua magia, o i figli di Ingar? State a vedere!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top